di Cecilia Lagomarsino
Il segreto delle madri, anche quelle che non sanno o non vogliono esserlo: la capacità misteriosa di diventare un posto che accoglie tutto quello che succede nel cammino, tutto quello che viene e che c’è.
La capacità di tenere insieme quel che insieme non sta. Di ricordare daccapo, ogni volta, da dove passa la vita e perché.
(“Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto” di Concita De Gregorio)
Guardo l’Italia dal finestrino, seduta in un treno puntualissimo che arriva dal nord. Vedo le persone sulla banchina, illuminate dal sole, che chiacchierano, si salutano, sembrano cordiali, anche da qui. Intravedo scorci di natura (è tutto più verde, mamma!), e mi sembra di sentire il calore del sole pervadermi attraverso il vetro. Non so nemmeno se realmente sia più caldo qui che a Vienna. Ma mi piace pensare di sì.
Sorrido all’idea che sono dovuta andare a vivere lontano, per capire davvero cosa sia il legame che provo verso il mio paese di origine. È un dolore sordo che, ne sono convinta, accompagna tutti coloro che vivono all’estero da tanti anni. È la consapevolezza di avere un’altra vita, parallela, che ci somiglia di più, ma per casi fortuiti, per scelta o per necessità, non abbiamo vissuto.
È un sentimento che nel mio caso si è acuito, di molto, da quando sono diventata mamma e non sono più stata solo io. Ho sentito dentro di me la responsabilità di trasmettere questo legame, o quello che ne resta, a mia figlia e a mio figlio che sono nati all’estero.
Nonostante entrambi parlino perfettamente l’italiano, mi trovo spesso a lottare per far sì che non diventino pigri e continuino ad usare la lingua madre, specie quando parlano con me ma anche nelle conversazioni tra di loro, torno spesso in Italia, e cerco di trasmettere il più possibile la mia cultura attraverso il racconto e la lettura.
Confrontandomi con amiche che sono diventate mamme come me, ma in Italia, vicine ai loro affetti, mi sono resa conto che loro soffrivano molto meno la solitudine che invece è, mio malgrado, diventata parte integrante della mia vita di mamma all’estero.
Ho letto “I diari” di Sylvia Plath da adolescente. Allora, proprio non riuscivo a spiegarmi come una donna tanto intelligente, sensibile e piena di talento avesse potuto decidere di togliersi la vita, a soli trent’anni. Tra l’altro aveva due figli, e il più piccolo aveva poco più di un anno quando si è suicidata.
Qualche anno fa, mettendo a posto la libreria, mi è ricapitato tra le mani il suo libro. E ho capito, anzi ho sentito. Sylvia Plath soffriva di problemi psichici già prima, certo, però il fatto di aver avuto due figli in due anni e di vivere isolata, con un marito assente, e soprattutto con poche possibilità di lavorare…
Pensavo che diventare mamma fosse il gesto d’amore più grande in assoluto – quindi motivo di gioia e felicità. La penso ancora così, ma ora so che non è l’unica sfaccettatura della maternità. Se una persona non ha una rete solida di sostegno, immagino sia durissima. E Sylvia Plath che mette la testa nel forno di casa sua dopo aver dato da mangiare ai suoi due bambini non mi sembra più tanto inspiegabile.
Penso sia importantissimo parlarne, parlarsi tra mamme e cercare di isolarsi il meno possibile. A mio avviso però, nel mondo di oggi le mamme sono molto più sole di una volta, in particolare, se come me, vivono all’estero, e quindi i pericoli sono maggiormente insidiosi.
Chi è neomamma, e lo è all’estero per giunta, sa esattamente a cosa mi riferisco. Niente nonne/i, zii/e, amiche o amici, a cui affidare di tanto in tanto i propri bambini, o con i quali andare ai giardinetti. Fatica immane a reinserirsi nel mondo del lavoro, per lo stesso motivo di cui sopra.
Proprio per approfondire questi temi nel marzo 2012 ho aperto un blog, mammitudine, che quest’anno compie dieci anni. Scrivere il blog è stata per me una vera conquista, un esercizio quasi terapeutico. Mi ha permesso da un lato di esprimere il mio sentire, facendomi spesso anche capire meglio quello che stavo vivendo nel momento, dall’altro è diventato un luogo di incontro, anche se virtuale, dove scambiare consigli sulla maternità e condividere esperienze: il mio personale antidoto alla solitudine. Un luogo di svago e sfogo, come dicevo anche nel mio primissimo post. Alcuni post hanno raggiunto le 2.000 visualizzazioni e talvolta ho avuto fino a 40 commenti. Inoltre, condividendo su altri siti che si occupano di maternità ho allargato i miei orizzonti e ho scritto contributi per comunità virtuali di mamme all’estero come per esempio Itagirlsontheroad, Famigliaontheroad e altri.
Ho poi trovato una risorsa davvero preziosa nel gruppo delle mamme italiane a Vienna: incontrare, stavolta dal vivo, altre donne nella mia stessa situazione, costruire amicizie profonde e condividere, oltre alla maternità, anche i problemi legati all’emigrazione è stato importantissimo. Ha completato il lavoro iniziato con il blog e reso ancora più evidente che fare rete è la formula magica per essere meno sole e più consapevoli nell’incredibile viaggio della maternità.
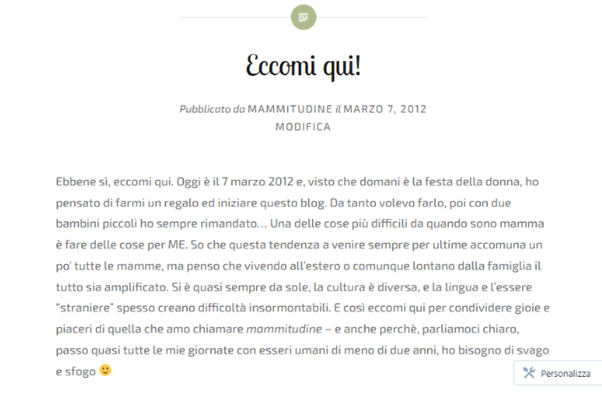
(#VD3 – www.libreriadelledonne.it, 10 ottobre 2022)
di Vita Cosentino
In un panorama politico in cui si parla a proposito o a sproposito di maternità, in cui si esercita una forte pressione sociale sulle donne, è più che opportuno che siano le femministe a prendere parola per significare la loro esperienza, sia quella di essere madre che quella di non esserlo. Parlarne, anzi riparlarne, aumenta lo spazio di libertà delle donne che si trovano oggi ad affrontarla.
In questo senso, a quasi cinquant’anni di distanza, ho riconsiderato la mia esperienza. La lontananza nel tempo è una lente che filtra e fa decantare i fatti. Sì, i dolori del parto sono stati tremendi, ma subito dimenticati. Ma cosa continua a riaffiorare prepotente e vuole essere detto?
Ho provato sì la fatica, la stanchezza, le notti quasi bianche nei primi mesi di vita di mio figlio, ma riemerge soprattutto la fiducia piena e l’amore speciale che una madre riceve dalla sua creatura, soprattutto negli anni dell’infanzia. Pensando ad allora, mi accorgo che la narrazione patriarcale sulla maternità fa acqua da tutte le parti. Non mi corrisponde e sento fasulla soprattutto la retorica per cui l’amore di una madre sarebbe gratuito e lei si annullerebbe nell’altro. Non è un amore gratuito, a perdere, è un amore ricambiato. È una relazione in cui si dà molto e si riceve molto.
Quando si sente dire da una donna, che sia madre o no, «mi piacciono i bambini», in realtà si allude a quella relazione speciale che sanno creare le creature piccole non solo con la madre, non solo nella cerchia familiare. Bambine e bambini posano «uno sguardo primo» (Ortese) sul mondo: per me i primi anni di Marco sono stati anche pieni di meraviglia.
Marta Equi ha messo a disposizione delle giovani donne, che oggi vivono l’esperienza di essere madre, un’immagine potente tratta da Carla Lonzi: con la maternità «la donna si disaccultura. Vede il mondo come un prodotto estraneo alle esigenze primarie dell’esistenza che lei rivive».
L’ho trovata una idea forte, che toglie la maternità dall’essere un intrappolamento nel ruolo, ne fa una fonte di pensiero e delinea una delle possibili strade di fuoriuscita dalla cultura patriarcale.
Con il suo viaggio lei esperisce come il mondo sia retto da altre esigenze (potere? denaro?) che non sono quelle della vita. Penso, però, che questo viaggio possa essere trasformativo a condizione che lei non rimanga nel chiuso della casa, come vorrebbero alcune forze politiche del tempo presente. È essenziale che lei oltrepassi quelle mura e possa portare il suo nuovo sguardo nel mondo. Leggendo “I sogni si spiegano da soli” di Ursula Le Guin, ho capito che questo passaggio è stato ed è ancora più complicato se si tratta di una donna artista o di una scrittrice. La nota autrice di fantascienza, e madre di tre figli, ne parla a fondo nel saggio “La figlia della pescatrice” e a un certo punto richiama le parole di Alicia Ostriker che sento in grande sintonia con quelle di Carla Lonzi:
«Se un’artista è stata addestrata a credere che le attività dell’essere madre siano banali, tangenti rispetto al vero argomento della vita, irrilevanti rispetto ai grandi temi della letteratura, è arrivato il momento di disaddestrarsi. Quell’addestramento è misogino, protegge e perpetua sistemi di pensiero e di sentire che prediligono la morte e la violenza rispetto all’amore e alla nascita, ed è bugiardo». (p. 178)
Anche per lei la questione è dis-fare le costruzioni culturali in cui siamo immerse e aprire a qualcos’altro. Molto è già cambiato e una scrittrice, un’artista oggi può contare sulla grande autorizzazione che viene dall’assegnazione del Nobel per la letteratura a Annie Ernaux, che non si è mai allontanata dal racconto della propria vita e ne ha fatto un punto di vista sull’intera società.
Tornando alla mia vicenda personale, io, mentre crescevo mio figlio, insegnavo a scuola a preadolescenti. Ricordo che sono rimasta affascinata, e poi piena di curiosità scientifica, per come Marco imparava a parlare e a fare tutto il resto. In quegli anni ho misurato la distanza tra un processo di apprendimento galoppante nella prima infanzia e la lentezza, per non dire la stasi, dell’apprendimento a scuola. Consapevolmente, e anche inconsapevolmente, a quelle esperienze ho attinto per decostruire l’insegnamento tradizionale e trovare, insieme alle altre e agli altri dell’Autoriforma della scuola, modalità più vicine alla vita.
È vero, le donne sono dappertutto, ma ci può essere cambiamento solo se portano lì dove sono l’interezza della loro esperienza umana. Scrive Ursula Le Guin: «Quando le donne parlano sinceramente sono sovversive».
(#VD3 – www.libreriadelledonne.it, 10 ottobre 2022)
di Paola Cavallari
Minoo Mirshahvalad è ricercatrice presso la Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII. Si occupa di diritto sciita, immigrazione e rapporti di genere in Italia e in Iran.
Può parlarci dell’immagine straordinariamente potente delle giovani manifestanti che rischiano la vita perché non vogliono portare il velo?
In queste settimane l’Iran ha testimoniato la tortura, lo stupro e l’uccisione di numerosi giovanissimi donne e uomini; un crimine perpetrato dalla teocrazia che lascerà una perenne cicatrice sulla memoria del mondo. Gli studenti presi di mira con colpi di bastone o buttati giù dai palazzi diventano il simbolo di un plurisecolare debito che noi iraniani avevamo nei confronti dello sciismo. In queste settimane l’Iran, ma anche l’Afghanistan, sono teatro di novità straordinariamente ricche dal punto di vista sociologico. Le rivoluzioni hanno sempre componenti inaspettate che prendono di sorpresa anche i più attenti sociologi. Malgrado il blocco plurisettimanale di internet in Iran, sulla rete si trovano i video delle studenti iraniane delle scuole medie che sventolando il velo corrono contro le forze dell’ordine senza armi, mentre insultano uomini armati che le picchiano e gli sparano contro. Sono sbalordita di tali coraggio e rabbia senza precedenti nella storia del paese. È vero che per quattro decadi dopo la Rivoluzione del ’79 le donne iraniane hanno coltivato dentro di sé un furore inaudito, ma per ora non so darmi spiegazioni su perché e come la generazione degli attuali adolescenti si senta così profondamente partecipe di questo rancore. È un evento che per la sua violenza e l’audacia delle protagoniste evoca la Rivoluzione francese, lanciato però dalle donne con il sostegno sorprendente degli uomini.
Che rapporto c’è tra il velo e la libertà per le donne iraniane?
Bisogna specificare un punto cruciale. Il Corano non ha mai parlato della copertura della testa della donna. Tuttavia, il velo per una serie di motivi sociopolitici ampiamente discussi nella letteratura esistente, è diventato un elemento fortemente identitario con connotazioni politiche. Il fatto che l’imposizione del velo cozzi con la libertà della donna non deriva dall’eventuale calore che lei dovrebbe sopportare d’estate o dell’eventuale peso di un pezzo di stoffa. Il problema è sentirsi ridotte all’oggetto della propaganda politica senza essere disponibili. Chi fa la modella è consenziente e, più importante ancora, remunerata per quella mansione. La donna iraniana non è né consenziente, né retribuita per essere il veicolo di un messaggio, politico o commerciale che sia.
Non solo in Iran, ma in altre realtà le religioni sono ridiventate platealmente strumento politico, incardinato su un fondamento patriarcale. Molti/e giornalisti e politici denunciano la teocrazia iraniana, ma non ne traggono le conseguenze di un dominio patriarcale.
La teocrazia è la più brutale truffa che l’essere umano abbia mai creato. Questa mira a perpetuare la subordinazione di quei ceti sociali che, per il loro aspetto minoritario, non hanno potuto costruire legami di «parentela» con il presunto Dio che governa. Nel mondo islamico, sin dal settimo secolo del calendario gregoriano, i «vicari» di Dio o del profeta sono stati sempre gli uomini. Nel mondo sciita, dopo una serie di lunghe evoluzioni giuridiche, l’istituto clericale (inaccessibile alla donna) è riuscito a spacciarsi per il vicario di Dio. Dunque, visto che Dio avrebbe bisogno di un qualche rappresentante per governare l’umanità e considerando la mascolinità di questa presunta rappresentanza nel mondo islamico, è chiaro che il patriarcato e la teocrazia vanno a braccetto. Di questa collaborazione la memoria italiana ha una lunga traccia, tuttavia, il ceto dirigente assieme agli organi di propaganda continuano a essere prevalentemente diretti dagli uomini. Non è difficile vedere le conseguenze.
Donna, vita, libertà: come commenta questo slogan?
Lo slogan è originariamente lanciato dal movimento di liberazione curdo e sembra sia stato coniato da Abdullah Öcalan (il presidente del Pkk, ndr). È uno slogan assai progressista che sancisce un rapporto diretto tra la donna e la libertà. Si basa sulla convinzione che la liberazione della donna sia la pietra miliare per la liberazione di tutta la società. Questa idea è stata felicemente formulata da Öcalan e promossa dalle attiviste curde. Mahsa Amini, il simbolo delle attuali rivolte, era curda e quindi l’adozione di questo slogan mi sembra molto opportuno e tempestivo.
In Europa si espande l’ondata di conservatorismo, di cui uno dei cardini è il rilancio della famiglia tradizionale che conferisce alla donna un ruolo «centrale e insostituibile». Vede qualche legame?
In Europa occidentale sin dalla Prima guerra mondiale si continua a nutrire una particolare nostalgia per un passato presunto ordinato e sensato che con «l’invasione» della modernità è stato compromesso. Un passato in cui il rapporto di genere, la famiglia e l’autorità avevano definizioni plurisecolare e quindi ben stabilite. Soprattutto dopo il Concilio Vaticano II siamo richiamati alla «rivolta contro il mondo moderno». Oggi per alcune frange del conservatorismo europeo, gli Stati autoritari – come quello iraniano – sono paradigmatici e purtroppo, in Italia, questo conservatorismo richiama il ritorno al passato spalleggiando il fondamentalismo islamico. La conseguenza del ritorno trionfale del conservatorismo in Europa, che con la crisi della spiritualità fa pure un numero considerevole di proseliti, ahimè, affligge sia il Medio Oriente che l’Europa stessa.
(il manifesto, 8 ottobre 2022)
L’Associazione Lucrezia Marinelli presenta il documentario di Kim Longinotto Letizia Battaglia-Shooting the Mafia. La voce di Letizia Battaglia e lo sguardo militante della regista Kim Longinotto ci accompagnano nel racconto della vita privata e professionale della grande fotografa e fotoreporter, recentemente scomparsa. Un ricco materiale di interviste, foto e filmati ci restituisce la sua vita, il suo lavoro e il suo impegno civile: documenti impareggiabili di un’epoca e di una vita appassionata. Introduce Silvana Ferrari.
di Simona Sirianni
Per il suo pubblico era già un’icona e di certo non serviva il Premio Nobel per la Letteratura vinto ieri a farla amare ancora di più dai suoi lettori. Fatto sta che Annie Ernaux, una delle voci più autorevoli della letteratura mondiale, il prezioso riconoscimento lo ha ricevuto, non facendo altro che confermare il suo essere una scrittrice eccezionale.
L’autrice francese è capostipite dell’autofiction. Si tratta di quel genere letterario che usa il proprio io e la propria vita come chiave per affrontare questioni come la famiglia, la violenza, gli affetti e che si racconta con una disarmante onestà. Ed Ernaux lo fa in maniera talmente profonda che l’Accademia svedese ha motivato la sua scelta «per il coraggio e l’acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale».
Ciò che racconta Ernaux, infatti, nei suoi libri, è esattamente quello che ha vissuto, il ricordo e la scrittura sono legate in maniera indissolubile, senza nascondere mai che l’io dei suoi libri coincide quasi completamente con sé stessa.
I libri di Annie Ernaux
Una donna
Negli ultimi anni, Ernaux è diventata quasi un culto per chiunque ami la scrittura. E questo è successo anche in Italia. I suoi libri sono tutti molto amati e, tra questi c’è sicuramente Una donna (Ed. L’orma), di cui Teresa Ciabatti, tra le più importanti scrittrici italiane contemporanee, ha detto: «Annie Ernaux spiazza, incanta, commuove. Non consola».
È un libro scritto pochi giorni dopo la morte della madre, nel periodo del lutto in cui le vicende personali emergono dalla memoria. La storia di questa donna prende vita a partire dalla miseria contadina per arrivare al riscatto come piccola commerciante. Che dura fino allo sprofondare nel buio della malattia. Un libro che, utilizzando una lingua «più neutra possibile», indaga le contraddizioni e l’opacità dei sentimenti con un secco dolore.
Gli anni
Gli anni è un libro del 2008. Difficile descriverlo, perché non è un romanzo né una raccolta di memorie. È un flusso di ricordi dell’autrice che ripercorre la sua vita dagli anni quaranta fino ai giorni nostri. E mentre racconta di sé, racconta anche il Novecento e la storia di una generazione.
Quella cresciuta durante il boom economico degli anni cinquanta, travolta dal consumismo e infine sopraffatta dalla nuova era digitale. Con una domanda che rimane centrale per tutte le pagine: resterà di me qualcosa, infine, ancora?
L’evento
Con il successo di La scelta di Anne – L’Événement, vincitore del Leone d’oro al Festival di Venezia 2020, il libro L’evento da cui è tratto il film è tornato molto in auge. Uscito in Francia nel 2010, racconta l’esperienza di una ragazza che cerca disperatamente di abortire in un mondo che non le riconosce questo diritto, portando alla luce una ferita collettiva. Una terribile richiesta in forma letteraria di costruire un presente più giusto per tutte quelle donne incinte, vicine o lontane, a cui è proibito per legge o nei fatti disporre di sé stesse.
«Se non andassi fino in fondo a riferire questa esperienza contribuirei a oscurare la realtà delle donne schierandomi dalla parte della dominazione maschile del mondo», ha detto la scrittrice delle sue pagine.
La donna gelata
Ancora la Ernaux femminista in un libro che riavvolge i ricordi dell’educazione sentimentale e sessuale di una donna dalla provincia francese degli anni Quaranta. Le scoperte e i tabù dell’adolescenza, gli anni più indipendenti e intensi dell’università, dove si ricorrono amori e scelte. Per arrivare ai bivi della giovinezza: matrimonio, famiglia. Ma qui lo squilibrio di ruoli e mansioni tra moglie e marito, tra madre e padre condanna l’autrice alla glaciazione dell’interiorità e del desiderio.
Annie descrive con precisa passione l’apprendistato alla disparità di una donna, consegnando al lettore con spietata limpidezza un’impareggiabile radiografia della moderna vita di coppia.
Il posto
In queste pagine la scrittrice racconta la storia del padre, della sua vita, del conflitto creatosi tra loro nel corso degli anni. E, il desiderio di scrivere coincide con la necessità di affrontare ancora una volta l’autorità paterna, di verificare il contraddittorio rapporto tra padre e figlia, di far riemergere dettagli considerati perduti per sempre.
di Laura Pezzino
Una delle prime cose che ho fatto è stata digitare sulla tastiera «Auchan» e «Cergy» e cliccare su Street View. Appena il segretario permanente dell’Accademia di Svezia ha annunciato che Annie Ernaux aveva vinto il Nobel per la Letteratura, ma che non erano ancora riusciti ad avvisarla al telefono, il mio pensiero è andato a uno dei luoghi simbolo dell’autrice francese, almeno nell’ultima parte della sua produzione letteraria. Magari, ho pensato, proprio in quel momento Annie Ernaux si trovava all’Auchan a fare la spesa e, tra gli avvisi all’altoparlante e la musichetta in filodiffusione, non aveva sentito il cellulare. Può capitare a tutti, anche a una neo-Nobel, no?
Quello sull’Auchan di Cergy, il «Cremlino di mattoni», è stato l’ultimo libro di Ernaux che ho letto, qualche mese fa. Il titolo è Guarda le luci, amore mio, e sono certa che qualcuno lo avrà classificato come un Ernaux «minore». A mio parere, sbagliando. Il primo, invece, era stato Gli anni, da molti considerato il suo capolavoro. Ero io, però, a non essere pronta. Erano, quelli, tempi in cui cercavo soprattutto immagini alle quali aderire, e la foto di gruppo scattata da quelle pagine, che si prefiggevano di ricostruire la memoria di un intero Paese, mi era parsa eccessivamente generica, affollata. Miravo, esigevo, primissimi piani. Quando è arrivato Il posto mi son detta “ci siamo”. Fin dalle prime pagine, mi aveva introdotta in un mondo, immenso nella sua minuscolezza, che si era trasformato istantaneamente in topos: il bar-alimentari che i suoi genitori, i Duchesne (Ernaux è il cognome dell’ex marito), avevano gestito per anni a Yvetot, il paesotto della Normandia dove era cresciuta e che avrebbe ossessivamente raccontato nei successivi cinquant’anni.
All’inizio del Posto, lei è da poco diventata insegnante di ruolo (avrebbe poi insegnato in diversi licei) quando suo padre muore a sessantasette anni, un passo dalla pensione, una domenica pomeriggio. Ernaux lo dice così: «Mia madre è comparsa in cima alle scale. Si tamponava gli occhi con un tovagliolo che probabilmente aveva portato con sé quando era salita in camera dopo pranzo. Con voce neutra ha detto: “È finita”». Ora che lo rileggo a distanza di anni, penso sia stato proprio quel tovagliolo – non un Kleenex, non un fazzoletto, proprio un tovagliolo, magari macchiato di minestra – a farmi pensare, ci siamo. Per Ernaux la scrittura è sempre stata un mezzo per raggiungere il reale, e poco cose sono più reali di un tovagliolo sporco con il quale tamponarsi le lacrime per un marito appena morto. Quel padre lì, che si faceva fotografare con le cose di cui andava orgoglioso – il negozio, la bicicletta, la Renault 4 poi. Quella madre lì, la cui infanzia era stata «un appetito mai sazio» – anche se questo lo scrive in Una donna, dove dice anche: «Ora mi sembra di scrivere su mia madre per, a mia volta, metterla al mondo». Ecco, quei genitori lì erano i miei genitori. E non lo erano mai stati. Da lì in poi, l’universo Ernaux mi si è srotolato davanti e non ho mai avuto la tentazione di abbandonarlo.
È stato sempre nel Posto che mi si è svelata per la prima volta una parola comunissima eppure chiave nella scrittura di Ernaux, «vergogna», quel «timore di essere fuori posto». Di quella vergogna, così dolorosamente dissezionata fino a mostrarne il meccanismo più nascosto, sarei andata alla ricerca, come una detective delle miserie umane, in ogni suo libro: in Memoria di ragazza (sulla sua prima esperienza sessuale) c’è; in L’altra figlia (quando scopre di avere avuto una sorella morta prima che lei nascesse) c’è; in La donna gelata (dove il gelo è il matrimonio, e infatti non ha mai più voluto sposarsi, e dove scrive: «Le donne della mia vita parlavano tutte a voce alta, avevano corpi trascurati, troppo grassi o troppo scialbi, dita ruvide, volti senza un filo di belletto o altrimenti truccati in modo esagerato, vistoso, con grandi chiazza sulle guance e sulle labbra») c’è. In massimo grado c’è in L’evento, che racconta di un aborto clandestino messo poi in pellicola dalla regista Audrey Diwan, e in un altro suo libro intitolato proprio così, La vergogna: lì parla di violenza domestica, una tipologia che, se esistesse una scala Richter della vergogna, sfiorerebbe il livello massimo. Sulla vergogna, un’altra scrittrice francese, Nathalie Léger, una volta mi disse una cosa interessante: «La vergogna è sempre un’ustione ereditata, ciò che crea quel sistema di lealtà e di promesse non dette alle quali si resta incatenati. E il romanzo, la letteratura, esistono per questo, perché per confessare bisogna mentire». E se è, come è, qualcosa di ereditato, la prima vergogna è quella per la propria famiglia, il posto da dove si proviene. La prima vergogna è vergogna di classe.
Parte della motivazione dell’Accademia dice: «Con grande coraggio e acutezza clinica, Annie Ernaux ha rivelato l’agonia dell’esperienza di classe e descrivendone la vergogna, l’umiliazione, la gelosia o l’incapacità di vedere chi si è, ha realizzato qualcosa di ammirevole e duraturo». Nel saggio Scrivere è dare forma a un desiderio (Castelvecchi), rifacendosi al suo maestro, il sociologo Pierre Bourdieu, Ernaux dice che non potrebbe immaginare una forma letteraria slegata dai rapporti sociali, dove l’io di chi scrive è solo uno dei vari nodi. In una delle due interviste che ho avuto la fortuna e l’onore di farle, ha spiegato, riferendosi al 1971: «Mi resi conto che provenendo dal popolo ed essendo stata una borsista, non facevo parte dei cosiddetti “eredi” delle élite che, a scuola, riuscivano ad appropriarsi con facilità di quella che era la cultura “generale”. Questa presa di coscienza fu molto importante per me e mi spinse a scrivere il mio primo libro, Gli armadi vuoti». Poche scrittrici come Ernaux – una è di sicuro Dorothy Allison, un’altra Elena Ferrante – hanno saputo entrare con uguale affilata precisione all’interno dei rapporti di classe, eviscerarli, svergognarli, ed è significativo il fatto che Alberto Prunetti, autore dell’importante lavoro seminale sulla letteratura working class Non è un pranzo di gala (appena uscito per minimum fax), la citi come esempio di «transfuga di classe» (con Didier Eribon ed Édouard Luis) e come scrittrice con un background working class.
Dopo un lungo percorso a scandagliare in lungo e in largo quel luogo acquatico e cangiante che è la memoria personale, Ernaux ha iniziato ad annettere un tipo di patrimonio più collettivo, e lo ha fatto usando soprattutto i discorsi e le parole delle persone. Arriva a questo punto, nel 2008, Gli anni, a occupare un importante tassello all’interno di quell’ampia «autobiografia sociale», così è stata chiamata l’opera di Ernaux, di cui fa parte anche Guarda le luci, amore mio, il libro sull’Auchan dal quale sono partita, dove un ipermercato di periferia diventa osservatorio privilegiato del mondo e delle persone in un’ottica sociale e, quindi, politica. Nello stesso filone si possono leggere anche opere come Journal de dehors e La vie exterieur, che trattano «oggetti considerati indegni della lingua letteraria» come i viaggi sulla Rer, i parcheggi e, appunto, i supermercati. In Journal scrive: «Più nessuna descrizione, nessuna storia. Solo degli istanti, degli incontri. Un etno-testo». E di fronte a una materia così incandescente – la vita, le vergogne, le fatiche, le miserie –, l’unica arma di Ernaux è stata un tipo di scrittura essenziale, piatta, che mi ha spiegato così: «La mia scrittura piatta è nutrita dalle sensazioni, che restano, però, dietro le parole». Parole-schermo, dunque.
Dal posto in cui è nata, Ernaux ha cercato di fuggire come si fa dagli incendi. La sua salvezza è stata la Grande Città, Parigi e tutte le meraviglie stipate là dentro, i salotti, la bourgeoisie, le lucine, la letteratura alta. A un certo punto però, la sua strada – come quella di tanti, in realtà – ha fatto un’inversione a u, e allora la sua scelta è caduta su un posto, che potrebbe essere qualunque posto ma che si chiama Cergy, a 40 minuti con la Rer A dal centro di Parigi, e su una casa con un grande giardino sul fiume Oise. Più volte ho fantasticato su quel giardino, soprattutto da quando lei stessa me ne aveva parlato durante la nostra prima intervista.
Al telefono Annie Ernaux ha una voce di ragazza, e io mi ero molto emozionata quando avevo sentito il suo allô dall’altra parte del filo – la immaginavo, non so perché, aggrappata a una pesante cornetta di bachelite, immersa in una poltrona di velluto lisa sui braccioli, a guardare con quei suoi occhi liquidi oltre la portafinestra aperta sui salici del giardino. La voce è una delle cose che cambiano meno di noi mentre gli anni corrono, e se tutto il resto prima o poi si disfa e ci trasfigura, la voce è l’unica in grado di opporre una piccola resistenza. Quella, ho immaginato anche, era la stessa voce della giovane donna che aveva vissuto i fatti raccontati in L’evento o in Memoria di ragazza.
E così, quella ragazza scappata dalle fiamme ora ha vinto il Nobel per la Letteratura, che notizia! E si spera che questa volta saranno in pochi a dire «Ernaux chi?». Doveva essere il turno di Salman Rushdie, si mormorava, ma si sa, l’Accademia ha ragioni che la ragione non comprende e viceversa, e i fatti del mondo, soprattutto loro, hanno scarsissime chance di riuscire a intrufolarsi dietro la porta chiusa più fotografata del mondo. Ogni volta che, in questi ultimi anni, il Nobel è andato a una delle scrittrici che hanno contribuito a darmi forma – ed è successo finora quattro volte: Alice Munro, Olga Tokarczuk, Louise Glück ed Ernaux, perché quando è stato il turno di Szymborska e Aleksievic io, per eccesso di gioventù o di stoltezza, non le avevo ancora lette – mi sono sentita contenta come se un pezzettino di quella luce fosse anche mia. E di tutte, tutte quante, le altre invisibili che mi hanno preceduta e mi succederanno. Una rivincita, anzi di più, una speranza. «Un aiuto a comprendere, e sopportare, ciò che accade e ciò che facciamo», scrive la Nobel in Memoria di ragazza.
Prima di chiudere questo pezzo, nel quale, pur nella lungaggine, non sono riuscita a parlare del femminismo di Ernaux – i suoi testi sono stati paragonati, per impatto, a quelli di Simone de Beauvoir, e quando le chiesi quale fosse lo stereotipo più difficile da superare per una donna rispose «la sottomissione. Il fatto che siamo troppo gentili con gli uomini, li perdoniamo e accettiamo tutto nonostante loro non facciano altrettanto nei nostri confronti» – faccio in tempo a vedere un brevissimo video in cui si vede Annie, sciarpa e calze rosse, che attraversa con il passo cauto di una signora di 82 anni il giardino di casa sua a Cergy e raggiunge i giornalisti che le chiedono un commento sul premio. Ma lei è sopraffatta, incredula: «Non ci riesco. Sono felice, e orgogliosa. È tutto». È commossa. Commuove. E quelli, comunque, non sono salici.
(rivistastudio.com, 7 ottobre 2022)
di #Senzagiridiboa
Era la fresca sera del 4 maggio 2022, alle 20. Tutto nasce da un messaggio su una chat WhatsApp: «Avete sentito le parole della Franchi? Dobbiamo reagire, fare qualcosa!».
Elisabetta Franchi è una stella del mondo della moda. Nasce in una famiglia poverissima poi fa la commessa in una bancarella di intimo fino a realizzare il suo sogno dominando le passerelle più ambite con abiti indossati anche da Angelina Jolie e Jennifer Lopez. Durante un incontro pubblico parlando del suo modello di business rispetto al tema dell’occupazione femminile dice: «Faccio una premessa. Io le donne le ho messe ma sono -anta, ancora ragazze ma ragazze cresciute. Se dovevano sposarsi si sono già sposate, se dovevano far figli li hanno fatti, se dovevano separarsi hanno fatto anche quello. Diciamo che io le prendo dopo i quattro giri di boa. Sono tranquille e lavorano h24». Eccole le donne che hanno già fatto i quattro giri di boa.
Over 40 (quindi affidabili e formate ma ancora giovani per lo standard italiano), matrimonio fatto, figli già cresciuti (quindi secondo lei già fuori dalle balle), divorzio (eh sì perché se fai la manager non hai tempo per investire sulla tua relazione quindi per forza finisce male). A questo punto sola come un cane senza più nessuno di cui occuparti non ti resta che lavorare h24 (perché no, se sei una donna in carriera – con o senza figli – non c’è spazio per il tempo libero, per leggere un libro, passeggiare o godersi la vita. Puoi solo sgobbare).
Queste parole ci hanno fatto arrabbiare. All’inizio in chat eravamo in cinque. Alle 21.30 nel gruppo WhatsApp superavamo le trenta. Alle 22 di quella sera di maggio ognuna di noi ha lanciato sui propri social network l’hashtag #senzagiridiboa accompagnato da una fotografia di sé stessa (con o senza pancione, con o senza figli, sul lavoro, in vacanza) e un pensiero, una riflessione personale sulle parole pronunciate dall’imprenditrice della moda.
Alla campagna si sono unite molte altre lavoratrici. Non solo giornaliste ma anche scrittrici, artiste, sceneggiatrici, blogger, sportive, attrici.
Elisabetta Franchi ha poi precisato le sue parole così: «L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne […] Lo Stato italiano è ancora abbastanza assente, mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta tra famiglia e carriera». Quindi, conclude la stilista emiliana, “chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente quello che ho dovuto fare io”. Effettivamente l’imprenditrice è madre di due figli, il primo avuto poco prima delle boe, mentre la seconda dopo i suoi giri di boa. Non ha senso prendersela con chi ha solo avuto la sincerità, impudente, di dire in un consesso pubblico quel che ogni giorno si dice e si fa dentro le segrete stanze delle aziende dove si decidono le carriere delle donne. Alla fine dobbiamo essere grate a Elisabetta Franchi. Da lì abbiamo deciso di uscire dal perimetro della campagna social e di fare ciò che ci viene meglio e cioè quello che facciamo per lavoro: esercitare il nostro diritto di cronaca e di critica. Raccontare, dopo aver raccontato le nostre storie, le storie degli altri. Così abbiamo chiesto a chi ci ha seguito sui social di mandarci le proprie storie. Non ci credevamo, dobbiamo dire, ma in un mese, grazie a chi c’ha dato fiducia, abbiamo raccolto oltre cento testimonianze di lavoro/vita/diritti. Questo libro* è il loro libro. È il frutto di questa raccolta di storie. Ma è anche il nostro libro. È un racconto corale. Uno sforzo collettivo che avevamo disimparato a compiere in questo mondo, il nostro mondo, in cui l’individualismo sfrenato ha spesso il sopravvento: noi ci siamo unite. Questo libro è quindi per noi molto più che un libro. È un metodo, un approccio solidale alla vita.
Ma attenzione: il nostro non è un movimento politico. Né tantomeno un coro composto solo da madri. È al contrario un grido trasversale che comprende donne con storie diverse e che non si ferma solo al difficile bilanciamento tra lavoro e figli. Questo libro parla anche alle -anta single e senza figli che si dà per scontato, non avendo prole, non abbiano una vita degna di essere vissuta al di fuori del loro impiego. In più non si considera che oggi il problema è semmai quello opposto: per fare figli si aspettano proprio gli -anta di cui parla la Franchi. Perché negli -enta si fa la gavetta. E poi ci sono gli uomini, che a stare con i figli ci tengono sul serio e magari si sentono discriminati per non poterlo fare perché alla fine se manca lo stipendio più consistente, quello maschile nella maggior parte dei casi, chi porta avanti la famiglia? Uomini che vorrebbero anche loro avere diritto ad un mondo del lavoro che non faccia solo della disponibilità il metro della propria prestazione e del proprio valore.
Questo libro vuole spiegare a tutte (e tutti) che non siamo davanti a un problema individuale con una soluzione individuale. Questo problema è il problema sociale più importante che abbiamo davanti nel mondo del lavoro e deve avere una risposta sociale. Fino a quando la perdita del lavoro di una donna in attesa sarà solo il problema di quella donna e non un’offesa a tutte le donne lavoratrici e un danno a tutta la società, non se ne uscirà.
(*) AA. VV., Senza giri di boa, PaperFirst.
Un’opera sociale e collettiva. La prefazione la firma Chiara Saraceno. Il libro è un’opera a più mani di giornaliste, scrittrici, blogger: Francesca Biagiotti, Valeria Brigida, Giulia Cerino, Gaia De Scalzi, Micaela Farrocco, Francesca Fornario, Silvia Franco, Chiara Maria Gargioli, Linda Giannattasio, Sara Giudice, Barbara Gubellini, Sofia Mattioli, Ambra Orengo, Valentina Petrini, Giulia Presutti, Chiara Proietti D’Ambra.
(Il Fatto Quotidiano, 7 ottobre 2022)
di Chiara Cruciati
Un mese dopo l’inizio del feroce assedio dell’Isis a Kobane, nel settembre 2014, un noto marchio d’abbigliamento europeo inserì nel suo catalogo capi di vestiario femminili ispirati alle uniformi delle combattenti curde. Durò poco, le polemiche lo costrinsero a scusarsi. Quell’episodio si accompagnava all’estemporaneo interesse occidentale per le donne del nord-est della Siria, impegnate a difendere la propria società e il progetto politico del confederalismo democratico dall’attacco militare e ideologico del fanatismo islamista.
Un’attenzione superficiale, limitata ai fucili in spalla, che evaporò poco dopo e che non ha mai scavato nella teorizzazione che stava dietro a quell’impegno. Eppure la lotta curda di liberazione delle donne non è ascrivibile a un lasso di tempo o a un territorio limitato né a un frangente storico definito. È figlia di un percorso a ritroso, alle origini dell’umanità, dove rintracciare le origini del patriarcato e la millenaria impalcatura politica, sociale ed economica di dominio maschile sulle donne.
Quel percorso è raccontato da Jin, Jiyan, Azadi. La rivoluzione delle donne del Kurdistan (Tamu, pp. 448, euro 22). Realizzato dall’Istituto Andrea Wolf, nato nel 2019 e parte dell’Accademia di Jineolojî in Rojava, è stato tradotto in italiano dal comitato italiano di Jineolojî. Dalla struttura fluida, il libro – nella prospettiva di costruzione di una forma di sapere non patriarcale – conduce nelle viscere della rivoluzione attraverso le voci delle donne che l’hanno realizzata, e la stanno realizzando. Venti rivoluzionarie offrono le loro memorie, pagine di diario, lettere, racconti e riflessioni, il lavoro compiuto su se stesse, sul Pkk e la società curda per una trasformazione storica dei rapporti di genere, sociali e nazionali, potenzialmente a livello globale.
Al cuore del processo rivoluzionario sta uno dei pilastri del confederalismo democratico, teorizzato dal leader del Pkk Abdullah Öcalan e reso pratica quotidiana dalle comunità della Siria del nord-est: democrazia radicale, ecologismo e liberazione delle donne, che ne è il fulcro, il femminismo come conditio sine qua non per un nuovo modello di società, il cemento con cui costruirne la struttura, l’indispensabile creta per plasmarne la forma. Perché è possibile immaginare il ribaltamento del sistema patriarcale e l’uccisione del maschio dominante solo attraverso la liberazione delle donne, prima nazione oppressa e colonizzata del mondo dalle civiltà post-neolitiche per mano dell’embrionale sistema capitalista e del nucleo fondante l’idea di Stato: la famiglia.
Con gradi e forme diverse nelle varie epoche storiche e luoghi del pianeta, la sostituzione del matriarcato (affatto inteso come dominio femminile sul maschile, ma come società equa fondata sulla comune partecipazione alla collettività e al suo sviluppo, nel rispetto delle differenze e della natura) con il patriarcato è segnata dalla nascita delle prime classi sociali e delle gerarchie di potere (lo sciamano, il guerriero e il capo tribù, volti delle istituzioni religiose, militari e politiche). È all’interno della famiglia, con il matrimonio, che il capitalismo fonda le sue radici: è nei rapporti familiari che si realizza la primitiva appropriazione del capitale a scapito delle donne, l’imposizione del ruolo riproduttivo e di cura e il controllo della sessualità, l’annullamento della partecipazione femminile alla cosa comune.
Da queste basi teoriche, il movimento delle donne curde avvia il suo lungo e complesso viaggio. Fatto di educazione nelle carceri dello Stato turco, di studio e autocritica, di lotta al patriarcato all’interno del Pkk delle origini, di creazione delle prime forme assembleari solo femminili, di liberazione dai vincoli sociali imposti da comunità restie al ritorno delle donne al cuore dello sviluppo politico, economico e sociale. Fino alla nascita di un partito nel partito e alle prime forze di autodifesa, tra gli anni Novanta e Duemila, e alla fondazione di Jineolojî, una scienza nuova che superi il positivismo bianco, maschile e borghese e riveda lo studio della storia, l’economia, la politica, le scienze secondo criteri nuovi, plurali, femminili.
L’io narrante del libro diventa il noi, voci che incontrandosi restituiscono la forza propulsiva di un radicalismo realmente trasformativo. Che torna alle origini dell’umanità per creare – o ricreare – una società eguale, democratica e libera, dove etica ed estetica forgiano l’umanità nuova. Bella, come una donna che combatte. E come, ricorda il libro, la prima parola coniata per nominare la libertà: in lingua sumera amargi, introdotta dopo l’imposizione del potere maschile e gerarchico, è composta da due simboli, «ritorno» e «madre». Il ritorno alla madre, all’assenza di dominio, violenza e guerra.
di Luca Kocci
All’indomani dell’Angelus di domenica a san Pietro con il quale papa Francesco si è rivolto a Putin («fermi, anche per amore del suo popolo, questa spirale di violenza e di morte»), a Zelensky («sia aperto a serie proposte di pace») e alla comunità internazionale (faccia il possibile «per porre fine alla guerra in corso, senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation»), dalla Santa sede, attraverso un editoriale del direttore del dicastero per la comunicazione Andrea Tornielli (il “ministro della comunicazione” del Vaticano), arriva una sorta di interpretazione autentica delle parole del pontefice.
Non spetta solo a Putin e a Zelensky, ma anche ad altri – capi di Stato e di governo, organizzazioni internazionali – «chiedere con forza il cessate-il-fuoco e promuovere iniziative di dialogo per far prevalere quelli che papa Francesco chiama “schemi di pace”, invece di continuare ad applicare “schemi di guerra” rimanendo succubi di una folle corsa al riarmo che sta archiviando le speranze di un ordine internazionale non più basato sulla legge del più forte e sulle vecchie alleanze militari», scrive Tornielli in un editoriale pubblicato ieri sui media vaticani. «Da quel 24 febbraio che ha segnato l’inizio della guerra con l’invasione russa dell’Ucraina, tutto è sembrato precipitare come per inerzia, quasi che l’unico esito possibile fosse la vittoria di uno sull’altro».
Il modello a cui richiamarsi – a cui ha fatto riferimento lo stesso Bergoglio – sono invece gli accordi di Helsinki del 1975, «che segnarono una significativa svolta per l’Europa attraversata dalla cortina di ferro e per il mondo diviso in due blocchi».
La preoccupazione del papa – forse attualmente l’unico leader mondiale a parlare davvero di pace – è crescente. Lo dimostra, come rilevato da diversi osservatori, che il precedente di un Angelus interamente dedicato all’attualità politica internazionale risale al 2013, quando sembrava imminente un bombardamento Usa sulla Siria. E che i toni di Bergoglio di domenica ricordino quelli di Roncalli di sessant’anni fa, durante la crisi dei missili a Cuba. «L’umanità si trova nuovamente davanti alla minaccia atomica», ha detto Francesco all’Angelus. «Dopo sette mesi di ostilità, si faccia ricorso a tutti gli strumenti diplomatici, anche quelli finora eventualmente non utilizzati, per far finire questa immane tragedia. La guerra in sé è un errore e un orrore!».
L’analisi della situazione da parte del pontefice resta complessa («bisogna indagare la dinamica che ha sviluppato il conflitto», «non si può essere semplicisti»). Lo conferma il contenuto del colloquio fra Bergoglio e i gesuiti della regione russa che si è svolto a metà settembre, durante il viaggio del papa in Kazakhstan, pubblicato sabato dalla Civiltà Cattolica.
«È in corso una guerra e credo sia un errore pensare che sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi» e «che questa è una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una guerra mondiale», ha detto il pontefice. Il quale, pur ribadendo che «la vittima di questo conflitto è l’Ucraina» (ha subito un’«aggressione inaccettabile, ripugnante, insensata, barbara, sacrilega»), ha sottolineato che la parola chiave del conflitto è «imperialismo»: la Nato è «andata ad abbaiare alle porte della Russia senza capire che i russi sono imperiali e temono l’insicurezza ai confini». Dunque «io vedo imperialismi in conflitto. E, quando si sentono minacciati e in decadenza, gli imperialismi reagiscono pensando che la soluzione sia scatenare una guerra».
(il manifesto, 4 ottobre 2022)
di Alberto Leiss
In una parola La rubrica settimanale a cura di Alberto Leiss.
Ogni tanto, anzi sempre più spesso, penso che i fatti orrendi e catastrofici che accadono nel mondo dipendano in un modo o nell’altro dal fallimento – un fallimento colpevole – di quella grande, radicale ipotesi di cambiamento dello stato delle cose che si è chiamato «comunismo».
Quel che resta della sinistra perde perché, in trent’anni abbondanti, non è riuscita a fare i conti davvero con quel fallimento.
E credo non sia un caso che una guerra ormai giunta al limite inaudito dell’uso delle armi nucleari sia esplosa – annunciata da molto tempo – nel cuore non solo dell’Europa, ma del territorio russo-europeo che è stato teatro tragico di quel fallimento.
Domenica mattina ho potuto assistere, pur trovandomi a qualche migliaio di chilometri di distanza, alla discussione che la Libreria delle donne di Milano ha organizzato “sulla maternità”. Un confronto aperto da Silvia Baratella, Marta Equi e Daniela Santoro e introdotto da questa constatazione: «Oggi la maternità non è più un destino. Grazie alle precedenti generazioni di femminismo, si colloca nell’orizzonte della libertà femminile come un desiderio e una possibilità che una donna può cogliere o no, senza esserne definita. Tuttavia in questione c’è il valore simbolico dell’essere tutte e tutti nati di donna, che non
sembra ancora riconosciuto dalla società nel suo insieme».
A un certo punto Lia Cigarini – una donna che ha scelto di non essere madre ma che afferma la «relazione materna» come valore simbolico fondamentale – ha osservato che il principio fondante del comunismo: da ciascuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i propri bisogni, si realizza finora in una unica relazione realmente esistente. Quella della madre con i propri figli. Ma i capi del movimento operaio, pur avendo questa realtà ogni giorno sotto i propri occhi, non hanno saputo e forse voluto vederla. Hanno continuato a pensare e a agire come se spettasse solo a loro maschi di decidere tutto.
Non sarà proprio qui l’origine della sconfitta del comunismo? Ne ha convenuto un’altra femminista «storica», Alessandra Bocchetti: quella «magnifica impresa» è fallita perché dietro il proposito di assicurare a ognuno il proprio bisogno agiva «l’idea della giustizia che è uguale per tutti». Qualcosa di irriducibile «all’attenzione e all’amore» che sa vedere le differenze.
D’altra parte il modo con cui si parla sulla scena pubblica della maternità – questione che ha avuto un certo peso nella campagna elettorale appena conclusa, e non solo per le affermazioni più o meno urlate di Giorgia Meloni – presenta profonde distorsioni. Ci si allarma per la crisi delle nascite (mentre il mondo intanto cresce ormai a quasi 8 miliardi di individui e individue) e si rivendica il «diritto» all’aborto, minacciato dall’ansia maschile e patriarcale di re-impossessarsi del controllo sul corpo femminile.
Ma – ha osservato Letizia Paolozzi – non si interpellano le giovani donne che scelgono, non solo per motivi materiali, di non fare figli, e il discorso pubblico si ferma all’aborto «che non è nell’orizzonte simbolico della libertà». E sull’aborto, ha aggiunto Giordana Masotto, quando si manifesterà anche una responsabilizzazione degli uomini? Sono forse estranei alle dinamiche riproduttive e ai comportamenti sessuali? Gli uomini mi pare non ci fossero alla riunione. Io sono rimasto in silenzio. Ho scritto «sinistra». Avrei dovuto parlare dell’incapacità di auto riflessione prima di tutto dei suoi dirigenti maschi. Non possiamo usare uno sguardo materno, ma finché non vedremo e non sapremo parlare la differenza che attraversa anche noi, temo che nulla cambierà in meglio.
(il manifesto, 4/10/2022)
di Daniela Santoro
Introduzione alla Redazione aperta di Via Dogana 3 Sulla maternità, domenica 2 ottobre 2022
«Curiosamente mi accorgo di voler stare dalla parte dei bambini, e da quella delle madri; […] non voglio fare parte di un movimento politico che mi porti a guardare il mio stesso corpo con sospetto e terrore. A prescindere da quello che pensiamo o temiamo del futuro della nostra civiltà, in ogni parte del mondo le donne continueranno ad avere figli, e io sono una di loro, e qualunque figlio potrò avere sarà uno dei loro.» (Sally Rooney, Dove sei mondo bello?)
Nel suo ultimo romanzo, Sally Rooney – che potremmo definire la scrittrice più affermata della mia generazione – porta tra le sue pagine il tema della maternità. Sono voluta partire da questa citazione (alla quale io aggiungerei “figlie”) perché è così che viene fuori, agli sgoccioli del romanzo e senza alcun precedente accenno, come se un riflettore improvvisamente si puntasse su questa parola, che alla romanziera (e anche a me, fino a qualche tempo fa) sembrava oscura e lontana: la madre.
La scoperta improvvisa che si percepisce dalle parole di una delle due protagoniste del romanzo, può tranquillamente rappresentare una copia carbone di come io stessa mi sono approcciata al tema della maternità. Ovviamente, essendomi avvicinata alle politiche femministe da pressoché adolescente, ha occupato una posizione defilata, anzi un po’ condizionata da quanto vedevo propagandato in rete. Ho sempre visto la maternità come l’“anti-femminismo”, come simbolo per eccellenza del patriarcato e dei ruoli di genere. Certo, bisogna anche dire che questo sentimento “anti-materno” non è nato per caso: le pagine femministe più “pop” non ne parlano e inoltre sui social network negli ultimi anni impazza una nuova forma di ironia – ben lontana dalla definizione ariostesca del termine – che vede le madri al centro di battute misogine, nascoste sotto l’egida del progressismo.
Mombie – crasi di mamma e zombie –, mamme pancine: derise, messe alla berlina per il solo motivo di essere madri, avere dei dubbi e (orrore!) confidarsi con altre mamme su Facebook. Sulla definizione di “mamme pancine” un famoso signore ha basato tutta la sua carriera (se così la vogliamo chiamare) da “personaggio pubblico” e “comico”: i suoi post con più click sono infatti condivisioni di screen presi dal gruppo Pancine, cuori e bimbi (di non ben chiara autenticità, visto che più volte è venuto fuori che si trattasse di screen creati ad hoc dal nostro signore di cui sopra) in cui queste donne vengono derise dagli avventori della pagina per il loro basso grado di istruzione e per le loro condizioni sociali di “mamme e casalinghe”. Infatti, piuttosto che indagare sul perché queste donne abbiano un basso grado di istruzione, sul perché si trovino in relazioni non spesso appaganti e perché siano abbandonate nella cura dei figli, si preferisce prenderle in giro e creare un vero e proprio circolo di bulli misogini che guardano il dito quando gli viene indicata la luna. Questi post sono il sintomo di una grande problematica, che i commentatori dell’ultimo minuto sembrano ignorare: la solitudine delle donne, la solitudine delle madri.
I gruppi, i forum per mamme sono sempre esistiti, ed è giusto che sia così, soprattutto è giusto che siano spazi sicuri per dubbi e confidenze e ora, con questo nuovo trend di misoginia, non lo sono più. Le comunità di mamme in rete sono luoghi meravigliosi, luoghi che negli ultimi anni ho avuto modo di approfondire anche in controtendenza con quanto accadeva intorno a me sui social network. Soprattutto, ritornando su un tema che è a me molto caro, ovvero quello della solitudine e dell’isolamento, tramite questi gruppi alcune mamme riescono a creare intorno a loro una vera e propria rete di ascolto e aiuto, in un momento molto delicato della loro vita in cui però sono spesso lasciate sole, da una società che si aspetta che “se la sbrighino da sole”.
Così, anch’io, osservando da lontano questi piccoli ingranaggi di supporto ho iniziato ad avvicinarmi alle madri e alle loro voci. Forse a questo fa anche capo l’abbandono dell’adolescenza e del tetto familiare, che mi ha permesso di mettermi maggiormente nei panni della prima madre con cui ho avuto a che fare: la mia. Ho visto il suo sudore nel mio, la sua fatica nella mia e ho pensato alla nostra vicinanza, che fino a poco tempo prima mi sembrava una distanza insormontabile. È come se avessi aperto davvero gli occhi su quanto la maternità sia ormai passata in sordina nel discorso politico, eccetto quando si vogliono attuare politiche di controllo sulla maternità e di conseguenza sul corpo delle donne, come aborto e GPA. E in questo contesto perde voce l’esperienza materna – che diventa solo un modo per accaparrarsi consenso politico a destra e sinistra – e le madri vengono relegate a figure di secondo piano, sole.
Da un lato abbiamo gli attacchi misogini di chi ritiene che queste donne abbiano voluto la bicicletta e dunque debbano pedalare, cito testualmente da un commento in merito: «Ovunque incrocino un altro essere umano, devono far notare che hanno il bambino, come se non fosse qualcosa che accade da quando è nato il mondo. Fare figli è naturale, ma soprattutto una scelta di vita che riguarda te e non il resto del pianeta. Eppure, queste ritengono di aver creato qualcosa di unico, mentre si tratta di un normalissimo bambino, che a dire il vero fa pure un po’ pena […] ma perché accade questo? Probabilmente queste donne, non essendo state capaci di concludere nulla nella vita e ritenendosi sistemate per aver trovato un uomo che le mantiene, si attaccano all’unica cosa che hanno creato nella vita: il figlio».I figli sono un problema loro – casualmente solo delle madri – loro li hanno voluti e loro li devono crescere. Dall’altro queste donne, come sempre, hanno trovato il modo di starsi vicine anche se lontane, anche se le tutele sono poche e le porte in faccia parecchie. E non c’è niente di più femminista di questo, a mio avviso: per me, e mi permetto di parlare a nome di tutte Le Compromesse, questa luce di sorellanza non è altro che sintomo di quella forza femminile di cui tanto abbiamo parlato in questa sede il 12 giugno. E se all’inizio del mio percorso alla scoperta del femminismo (in cui ancora ho tanta strada da fare) vedevo le madri come un qualcosa di completamente distante da me, un’alterità quasi problematica, adesso allo specchio vedo una madre, mia madre e tutte le madri del mondo, donne, perché – proprio come dice Sally Rooney – «io sono una di loro».
(Via Dogana 3 – www.libreriadelledonne.it, 4 ottobre 2022)
di Marta Equi
Introduzione alla Redazione aperta di Via Dogana 3 Sulla maternità, domenica 2 ottobre 2022
La maternità […] è stata una nostra risorsa di pensieri e di sensazioni,
la circostanza di una iniziazione particolare.
(Carla Lonzi, 1970)[1]
Scrive così, nel 1970, Carla Lonzi, che non è di certo una pensatrice del materno e della maternità, eppure nella sua opera torna in maniera frammentata su un’esperienza di madre che lei stessa vive; leggerla in questa chiave mi ha accompagnata nel pensare per questa relazione in cui proverò a render conto di come per me maternità e gravidanza siano state anche esperienze di forza e di pensiero; trasformative non solo nei sensi più ovvi, ma anche nel senso femminista di una «trasformazione si sé che fa corpo con una possibile trasformazione sociale»[2].
Premetto che prendere parola pubblica su questo argomento è molto faticoso per me. L’esperienza della maternità costituisce ora, nel suo mistero, carne viva della mia vita – ho messo al mondo una creatura un anno e mezzo fa, e il corpo che avete di fronte porta di nuovo il segno di una gravidanza. Questo essere così addentro all’esperienza rende il lavoro del partire da sé ancora più insidioso. Sento, inoltre, necessità di cautela nel pronunciarmi su un’esperienza così abissale, che porta con sé implicazioni, doni e dolori diversi in ognuna di noi – madri e non madri.
Assumendo e accogliendo nel mio procedere questi disagi, credo però che sia importante iniziare a fare il lavoro di racconto di esperienze, che naturalmente non si esaurisce con le mie parole, ma che comincerà proprio nel dialogo comune di questo incontro, la cui posta in gioco è quella, come si legge nell’invito, di «far emergere un pensiero femminista sulla maternità fondato sull’esperienza, la parola e l’autorità delle dirette interessate: le donne, madri e no».
Non avevo mai desiderato essere madre. Come tale non mi sono mai immaginata, anzi, il presentarsi di questa immagine generava in me disagio. E poi, se la mente andava a soppesare la possibilità di avere un figlio venivo gettata nello sconforto, data la precarietà nella quale sta in equilibrio la mia vita – e le vite di tante donne della mia generazione. Eppure, durante il periodo della prima pandemia, proprio quando la precarietà e il senso di precarietà si andavano acuendo, quando l’idea di vita che ci eravamo immaginate iniziava a sbiadire, a mutare prospettive (sulla salute, sulla vita metropolitana, sulle relazioni, sull’organizzazione del lavoro…) è arrivato in me un desiderio di maternità. Improvviso, imperioso.
Manuela Fraire, nel DWF intitolato “Maternità Femministe” (2020) registra un aumento di desideri di maternità in lockdown, «come se – scrive – l’isolamento sociale provocasse per tutte quel rallentamento che ogni maternità impone»[3]. Non è stato quello nel mio caso, approfittare di un’imposta lentezza, bensì, piuttosto, un senso misterioso di voglia di resistenza e insieme di assunzione di responsabilità, apertura all’imprevisto in un momento in cui ogni strada sembrava sbarrata. «Il mondo ricomincia con ogni essere umano», – scrive Luisa Muraro nel testo Il lavoro della creatura piccola.[4]
Con questo non voglio naturalmente suggerire che le condizioni di precarietà scompaiano come per magia con il mettere al mondo una creatura, né che farlo possa costituire una risposta diretta ai problemi del presente. Piuttosto vorrei, da un lato, condividere come questo imprevisto nella mia vita mi abbia fatto inquadrare l’esperienza di maternità in un viaggio che non ha che fare con una consapevole scelta – si tratta di una parola che viene spesso usata per qualificare la maternità nell’epoca della libertà femminile ma che esprime un’idea che rimanda a qualcosa di programmato, razionale, qualcosa che ti porrebbe in controllo della vita e del suo fluire. Sono caratteristiche che non ritrovo in un’esperienza che nel suo farsi è piena di sbavature, che abita piuttosto uno stare nella vita organico, relazionale e vulnerabile. Dall’altro lato vorrei dire come l’esperienza libera del mettere al mondo abbia rappresentato per me e credo possa rappresentare per altre donne – naturalmente se così assunto e significato da colei che lo compie – un atto che scompiglia le carte date, in cerca della creazione del nuovo, come se la trasformazione del nostro corpo fosse promessa di un cambiamento anche nella società.
La gravidanza, ossia l’esperienza della centralità del mio corpo, è stata fondamentale in questo, per me. Dicevo prima di provare fastidio nel pensarmi come madre, come se, per diventarlo, avessi dovuto acquisire una specifica identità, consunta di significati già dati, caratterizzata da immagini svilenti e caricata di pressioni sociali ridicole – ne abbiamo avuto prova recentemente.
Una volta rimasta incinta, però, si è sciolta l’ansia definitoria e mi sono sentita solo io. Un corpo che era lo stesso e che si arricchiva di antri e forme per diventare due ma comunque uno. Ho capito con l’esperienza e non con il pensiero che sono corpo e che la mia identità è multipla. Il mio corpo di donna è segnato da essere stato anche un altro essere (non da averlo ospitato!). Infatti durante la gravidanza – che per me è stato un momento in cui ho provato senso di esplorazione, bellezza e giocosità; per trasmettervi meglio queste sensazioni le mie parole ci dovrebbero essere immagini, le fotografie di Paola Mattioli sulla gravidanza per esempio[5] – il mio centro sono sempre stata io, non l’essere che stavo generando. Vicino alla data del parto alcune amiche dicevano delle loro creature frasi come: «non vediamo l’ora di conoscerla», o «non vediamo l’ora di tenerla tra le braccia», e io mi sentivo estranea a questo sentire, tanto che la notte del mio travaglio è stata di commiato a me stessa in quella forma, a me stessa duale, alla mia pancia. Non c’era lui nei miei pensieri, ma sempre il mio mutevole stato. Quell’esperienza ha lasciato traccia in me come di un ricordo di potenza segreta e di possibilità di cambiamento: sono una donna, sono un essere multiforme che sa cambiare.
E in effetti cambia molto nella vita di una donna dopo il parto, almeno per i primi anni, quelli dell’accudimento di una creatura che dipende da te, tempo in cui la maternità può essere un’esperienza anche molto difficile, di solitudine e di fatica. Per me è stato così, e mi sono sentita compresa e rappresentata nelle parole di Lonzi, quando scrive, in una poesia del 1960 dei «giorni crudamente a fuoco» in cui ti senti «in stato di fermo», caratterizzati da «una lentezza inconciliabile con l’erompente ricognizione del mondo» che vive la creatura che ti sta davanti e con la quale avviene un incontro che lei definisce «un capolavoro di pazienza che mi sommerge, mentre lo solleva».[6]
Ci sarebbe molto da dire sui lati oscuri della maternità e forse alcuni interventi di oggi li metteranno in luce, non è mia intenzione soffermarmici ma piuttosto provare a dirvi come proprio il passarvi attraverso è stato, per me non privo di guadagni. Questo, lo stare nella perdita, nella fatica, nello scacco come passaggio di senso, mi viene suggerito da alcuni frammenti sulla maternità di Lonzi appunto, che accostano consapevolezza delle insidie della maternità – «una dilazione senza fine alla realizzazione di sé», la definisce in un passo del Diario[7] – ma anche del suo potenziale radicale per la vita di una donna: «La maternità – scrive – è il momento in cui, ripercorrendo le tappe iniziali della vita in simbiosi emotiva col figlio, la donna si disaccultura. Essa vede il mondo come un prodotto estraneo alle esigenze primarie dell’esistenza che lei rivive. La maternità è il suo ‘viaggio’».[8]
Questo della disacculturazione è un passaggio che sento come vero, e centrale, di cui però non so dirvi fino in fondo. Posso dire qualche elemento.
“Disacculturarsi”, per me, ha voluto dire togliere credito al lavoro come unica possibile sfera di realizzazione e di identità, non nel senso che ho capito che c’è un’altra sfera, quella domestica, di possibile realizzazione, ma piuttosto nel senso che mi ha portato a demistificare alcune pratiche lavorative di pretesa di assorbimento totale della mia vita. Mi sembra poi di aver acquisito con la maternità una postura di ironia e libertà rispetto alle piccole cattiverie del mondo del lavoro, insieme a più efficacia nel fare le cose e nell’assegnare priorità.[9] Mi ha messa di fronte alla scomoda sensazione di dover chiedere aiuto, mi ha fatta misurare con la sapienza del dire di no – non sono ancora brava a far questo, confesso. Per dire, se non fosse già ovvio, che si tratta di guadagni da riconquistare ogni giorno, ogni singola volta, mai acquisiti definitivamente.
Disacculturarsi ha poi voluto dire vivere delle esperienze di quotidianità che mi hanno mostrato qualcosa che prima non avevo mai incontrato. Confrontarmi con l’intensità che l’attenzione all’altro richiede – cosa così difficile da praticare, così brillante nel momento in cui accade – e con la gratuità dei gesti di cura, «quelli – mi appoggio ancora alle parole di Lonzi – che non diventano un prodotto, ma solo un accudire»[10] che sono assai concreti e spesso molto poco poetici. Questo confronto è stato ed è per me un’esperienza – tutt’ora enigmatica – che mi ha insegnato con più radicalità di quanto non sapessi già, teoricamente, a stare attaccata alle cose, all’imperfezione, al non finito, al macchiato.[11]
La maternità, nei suoi aspetti più concreti, è un’esperienza ambivalente, che merita attenzione e parola politica. Da un lato, per continuare a resistere al rischio sul quale dobbiamo sempre vigilare che le esperienze del quotidiano femminile oscillino tra esaltazione stereotipata e cancellazione, essendo relegate alla sfera privata, ai margini della società attiva e pensante, e dall’altro perché si stanno configurando altri luoghi e altri contesti che si stanno appropriando della narrazione della maternità consegnandola a dinamiche di estetizzazione, messa a valore e disprezzo, come ci racconta in parte la relazione di Daniela Santoro.
Per questo è importante un momento di dialogo come questo e lo è in particolare a partire da un luogo come questo che ci ospita, un luogo fondamentale per il femminismo italiano che tanto ha lavorato sul materno e per lasciare a noi nuove generazioni una libertà e una felicità possibile.
(Via Dogana 3 – www.libreriadelledonne.it, 4 ottobre 2022)
[1] Carla Lonzi, Sputiamo Su Hegel, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1970, p. 31.
[2] Mi riferisco con questa espressione alla formula coniata a proposito della Pratica del Fare nel testo Il tempo, i mezzi e i luoghi, Sottosopra Senape, 1976.
[3] L’impresa di diventare madre. Intervista a Manuela Fraire di Patrizia Cacioli e Teresa Di Martino (2020), DWF “Emme Effe Maternità Femministe”, 2020 3-4 (127-128), p. 16.
[4] Luisa Muraro (2013) Il lavoro della creatura piccola. Continuare l’opera della madre. Mimesis, Udine 2013, p. 11.
[5] Paola Mattioli, Sara è incinta, 1977.
[6] “Maternità”, Carla Lonzi, in Scacco Ragionato, Poesie dal ’58 al ’63, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1985, p.158.
[7] Carla Lonzi, 1978, Taci Anzi Parla. Diario di Una Femminista, Milano: Scritti di Rivolta Femminile, p. 872.
[8] Carla Lonzi, Sputiamo su Hegel, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1970, p. 36-37.
[9] Su questo si veda per esempio Andrea Vitullo, Riccarda Zezza (2014) Maam. La maternità è un master che rende più forti uomini e donne. BUR Rizzoli, Milano 2014.
[10] C. Lonzi, Taci, anzi parla. Diario di una femminista, Scritti di Rivolta Femminile, Milano 1978, p. 767. E ancora: «La donna genera un nuovo essere, non un prodotto.», Diario, p. 714.
[11] Naturalmente il pensiero femminista ha già lavorato molto sulla quotidianità, la domesticità e le pratiche che le sorreggono, lette come possibili spazi critici. Ida Farè per esempio, per citare una donna attiva politicamente in Libreria delle donne, a fine anni novanta e nei primi duemila ha formulato l’idea di un “bricolage” di saperi che può emergere dalle esperienze quotidiane femminili, qualificandolo come “intelligenza del quotidiano”. Non si tratta – e questo è davvero importante – di essere assimilate dal domestico, ma piuttosto, come precisa Farè, di imparare a riconoscere, nominare, valorizzare «questo sapere corporeo e antico […] per portarselo appresso […] qualsiasi professione si debba svolgere al tempo della libertà femminile». Ida Farè (2009), L’intelligenza domestica, in “Intossicano gonfiano rubano strozzano… e la chiamano economia”, Via Dogana 89, giugno 2009, pp. 5-7; Ida Farè (1996), L’intelligenza della cura. Intervista a cura di Gianni Saporetti, Una Città n. 53/1996, ottobre.
Per citare invece un esempio contemporaneo, Linda Bertelli sta portando avanti un lavoro di ricerca su una possibile definizione di un’estetica femminista del quotidiano. L. Bertelli (2021), L’aria necessaria. Gesti di estetica femminista, in “Io dico Io”, a cura di C. Canziani, L. Conte, P. Ugolini, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, pp. 134-147; L. Bertelli, (2021) La quotidianità della rivolta. Alcune osservazioni per un’estetica femminista e un suo possibile uso a vantaggio dell’oggetto fotografico, in C. Casero (a cura di), “Fotografia e femminismo nell’Italia degli anni ’70: rispecchiamento, indagine critica, testimonianza”, Postmedia books, Milano, pp. 51-61.
di Silvia Baratella
Introduzione alla Redazione aperta di Via Dogana 3 Sulla maternità, domenica 2 ottobre 2022
Tutto comincia con la maternità: vale per le vite di ciascuna e ciascuno di noi, ma vale anche per la Storia che, per come la conosciamo, è storia dell’invidia maschile per la potenza della maternità e storia di tutto ciò che è stato messo in atto per assoggettare e controllare questa potenza: racconta di una sistematica svalutazione delle donne come attrici sociali, in quanto destinate a essere esclusivamente madri, e della loro esaltazione come figure materne affinché aderissero al loro ruolo sostenendo così quell’ordine simbolico che abbiamo chiamato patriarcato. Sappiamo che quell’ordine è caduto quando le donne, con il femminismo, gli hanno ritirato il credito. E sappiamo che stiamo vivendo gli effetti del suo crollo, nel male e nel bene, tra forme di potere svuotate e pericolanti che ci ha lasciato in eredità e nuove forme di libertà, femminile e non solo.
Ora, da una parte, c’è molta più libertà di vivere o non vivere la maternità, e non è più la condizione che definisce una donna. Dall’altra per chi la desidera ci sono sempre più difficoltà materiali: il lavoro o non si trova o non dà da vivere, per cui cresce sempre più l’età della prima gravidanza, che per questo diventa più spesso a rischio e viene consegnata a una crescente medicalizzazione.
Ciò nonostante le donne delle nuove generazioni continuano ad affrontare con desiderio e inventiva quella scommessa che il Gruppo lavoro della Libreria delle donne nel 2008 aveva battezzato “Il doppio sì”[1], sì al lavoro e sì alla maternità. Castellina, in un’intervista su La Stampa dell’8 luglio 2022, invita le ragazze che desiderano figli a ribellarsi alle necessità economiche e a farli finché è fisiologicamente agevole: «Fateli, fateli pure a diciassette anni, se li volete, e qualcuno poi provvederà», dice, perché è «meglio far figli che mattonelle»: questo è un riconoscimento di senso di civiltà alla maternità.
L’invidia maschile tuttavia persiste anche dopo la caduta del patriarcato e si nutre anche della sofferenza delle donne che non possono avere figli. Ha così inventato l’utero in affitto, che sul piano medico tenta di segmentare la maternità in fasi e tra donne diverse riducendo le creature piccole a prodotti, e sul piano giuridico tenta di cancellarla istituendo falsi ideologici come i certificati di “nascita da due padri” o la figura dei “genitori intenzionali” che prevalgono sulla madre effettiva. Non ne parleremo, oggi: l’abbiamo fatto e lo rifaremo. Mi preme solo mostrare che gli Stati Uniti oggi ci offrono un esempio lampante e simultaneo dei diversi aspetti dell’invida post-patriarcale per la maternità: lo stesso paese che cancella la garanzia di scelta femminile sull’aborto è uno dei pochi al mondo in cui la gravidanza per altri è legale (e paradossalmente è legale per i committenti imporre l’aborto alla gestante).
Eppure questi sono anche tempi di cambiamenti interessanti. Negli ultimi anni in paesi come l’Irlanda e l’Argentina il divieto di abortire è stato finalmente abrogato dopo decenni di lotte, e in Italia una recentissima sentenza della Corte di cassazione (27 aprile 2022) elimina l’automatismo di attribuzione del cognome paterno anche per i nati all’interno del matrimonio: è il crollo di un altro pilastro simbolico del patriarcato, di un tabù come l’ha definito il Fatto quotidiano.
Infine la maternità è stata uno dei pochi temi politici che hanno caratterizzato la campagna elettorale appena conclusa, tra giusto orgoglio, timori di vederla di nuovo imposta come destino biologico, paure per la legge 194/78 e appelli contro una denatalità immaginaria (al contrario, in quarant’anni la popolazione mondiale è passata da quattro a otto miliardi!): segno dell’urgenza di darle un senso dopo e fuori dal patriarcato.
Il femminismo ha già fatto un importante lavoro di rivalutazione della figura e della relazione materna da parte delle figlie, che ha prodotto pensiero e pratiche politiche come l’ordine simbolico della madre, l’autorità femminile e l’affidamento. Proprio il 24 settembre scorso abbiamo discusso qui in Libreria con Alessandra Bocchetti del suo “anno dell’ambiguo materno”: il 1982[2], in cui al Centro culturale Virginia Woolf si era iniziato a mettere a tema l’esperienza della maternità cercando di darle un senso politico. È un lavoro che vogliamo riprendere oggi, ripartendo proprio dalla nostra esperienza di maternità: vissuta, scelta, accolta o rifiutata, a partire dalla parola e dal desiderio di essere o no madri, e soprattutto dalla verità soggettiva di chi oggi lo diventa, per trarre dal nostro vissuto e dal nostro sentire un pensiero di cambiamento, di quel cambio di civiltà che vogliamo realizzare.
Ne parleremo con Marta Equi, della redazione del profilo Instagram della Libreria delle donne e madre da poco più di un anno, e con Daniela Santoro, del gruppo femminista Le Compromesse, anch’esse presenti su Instagram.
(Via Dogana 3 – www.libreriadelledonne.it, 4 ottobre 2022)
[1] Lavoro e maternità, il doppio sì – Esperienze e innovazioni, di AA.VV., Quaderni di Via Dogana – collana Lavoro, Milano 2008
[2] L’anno dell’ambiguo materno. Note, appunti, illuminazioni da un seminario del Centro Culturale Virginia Woolf – 1982, di Alessandra Bocchetti, ed. Somara!, Ferrara 2022.
Silvia Plath. Le api sono tutte donne di Antonella Grandicelli, Morellini 2022.
La vita di Sylvia Plath sembrava una favola: l’amore con Ted Hughes, il talento poetico fiammeggiante. Ma dalla favola alla tragedia il passo è breve: la fine burrascosa della relazione con Ted, la morte tragica. Con la voce stessa della Plath, l’autrice ci conduce in un viaggio a ritroso nella storia di una delle più grandi voci poetiche di tutti i tempi. Dialoga con l’autrice Elena Petrassi.
Per acquistare online Silvia Plath. Le api sono tutte donne:https://www.bookdealer.it/goto/9788862988971/607
di Stefania Tarantino
È appena uscita per la casa editrice Mimesis, nella collana «Minima/Volti», una nuova traduzione dello scritto di Hannah Arendt su Rosa Luxemburg (pp. 138, euro 10). Si tratta di una recensione che Arendt scrisse in occasione della pubblicazione della biografia in due volumi di Peter J. Nettl dedicata a Luxemburg nel 1966 e poi inserita come «ritratto» nel libro del 1968 Man in Dark Times. Sotto l’attenta e rigorosa cura di Rosalia Peluso che, oltre alla traduzione ne firma anche la postfazione, emerge quanto e come il pensiero rivoluzionario di Rosa Luxemburg sia stato un faro per le riflessioni di Hannah Arendt sullo spirito tradito della rivoluzione, sul totalitarismo, sull’imperialismo e sul senso sorgivo dell’azione politica. Il rispecchiamento in questa donna così ostracizzata, marginalizzata ma anche per certi versi mitizzata e strumentalizzata, porta Hannah Arendt a riconoscere come un colpo di genio la biografia di Nettl perché riesce a sottrarla a tutte quelle leggende costruite intorno alla sua figura per restituirla alla piena realtà della sua vita storica. Ma non solo.
Il primo elemento che in apertura di questo scritto Arendt valorizza è il fatto che, seppur rientrando nel genere storiografico della «biografia definitiva» atta a celebrare i personaggi «vincenti» della storia, lo sfondo su cui si dipana la trama della narrazione non è la storia dei vincitori ma la completa unità di vita e mondo. Un’unità che, in Rosa Luxemburg, vive sotto il segno di un fallimento e di una sconfitta umana e storica senza precedenti. Alla «donna sbagliata» cui si attribuiscono ontologicamente errori e sentimentalismi di varia e sospetta natura, all’accusa reiterata di una scarsa scientificità delle sue analisi, alla costruzione postuma e distorta del «luxemburghismo», il merito di Nettl è quello di aver saputo sbarazzarsi dei pregiudizi che pesavano sulla sua figura e restituire, in maniera obiettiva quanto appassionata, la «verità» relativa al più importante e originale contributo di Rosa Luxemburg che riguarda in primo luogo la teoria e l’azione politica. Ciò comporta un primo passo per riscoprire la sua autentica dimensione di scienziata della politica e per riconoscere come un elemento di grande valore quella «virilità» che lei era costretta a rivendicare per sé per avere diritto di parola nel contesto tutto maschile del socialismo tedesco. Tale rivendicazione la tenne lontana, purtroppo, dalle battaglie delle suffragette per l’emancipazione femminile che per lei rappresentava solo una piccola parte del problema più generale dell’emancipazione dell’umanità nel suo complesso.
Come giustamente nota la curatrice, la stessa ansia di giustizia che animava Rosa Luxemburg si ritrova in Hannah Arendt, la quale, seppur non aderendo al movimento femminista, ha dedicato a donne esemplari dei ritratti di grande forza e intensità e, inoltre, ha dimostrato nel corso degli anni di influenzarlo notevolmente attraverso le fondamentali categorie della sua teoria politica, a partire da quella della pluralità e della natalità. Hannah Arendt riconosce il fatto che l’assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht il 15 gennaio del 1919 sia stato un punto di non ritorno non solo per la sinistra tedesca ma per tutta la sinistra europea. Il tradimento dello spirito rivoluzionario, il suo «tesoro perduto», è tutto dentro la storia di questa donna il cui insuccesso può essere ascrivibile al fallimento stesso della rivoluzione.
Arendt pone questo interrogativo: che volto avrebbe avuto la storia europea se in essa avessero trionfato la vita e l’opera di Rosa Luxemburg? Il rifiuto da parte di Rosa di un’adesione cieca e acritica alla teoria marxista e alla politica bolscevica, la rende, suo malgrado, un outsider a prescindere dal fatto che fosse donna e, in aggiunta, un’ebrea non tedesca. Prova ne è la sottovalutazione totale della sua grande opera L’accumulazione del capitale (1913) che Arendt, al contrario, considera uno dei più lucidi lavori sulle origini economiche dell’imperialismo. Nel suo contraddire i principi astratti della dialettica hegeliana e marxiana, Rosa Luxemburg descrive fedelmente il processo di riproduzione capitalistico inserendo tra la tesi e l’antitesi un terzo fattore. L’accumulazione si crea per l’esistenza necessaria di strati o paesi non capitalistici. Se nell’idea di Marx la società era organizzata secondo uno schema astratto che postulava da una parte i capitalisti e dall’altro i proletari, il processo di accumulazione rimaneva senza una fondata risposta. Il terzo fattore ipotizzato dalla Luxemburg spiega coerentemente il processo capitalistico in virtù del quale si accumula capitale sfruttando i mercati non capitalistici. Ora, questo meccanismo è, secondo Luxemburg, alle origini dell’imperialismo.
Come nota Arendt, nella seconda parte de Le origini del totalitarismo, l’imperialismo è innanzitutto un fenomeno economico che nasce dal contrasto che si crea tra i limiti spaziali dello Stato nazionale e l’inesauribile volontà di espansione del capitale. Ma ci sono anche altri motivi teorici per cui Luxemburg ha subito un destino di denigrazione. Il principale è il giudizio che lei ha espresso sulle contraddizioni che emergevano nella rivoluzione bolscevica e che riguardava in modo particolare la questione della libertà: la libertà, diceva Luxemburg, è sempre la libertà di chi pensa diversamente e il suo esercizio plurale è condizione stessa dell’azione politica. Le misure di restrizione della libertà messe in atto dai bolscevichi andavano in tutt’altra direzione. Un altro elemento che Luxemburg esprimeva nelle sue analisi e che è stato lungamente frainteso e su cui Arendt si sofferma riguarda la spontaneità dell’azione politica. Per entrambe spontaneità significa libertà e non ha nulla a che fare con quelle forme di spontaneismo o di improvvisazione che sono divenute le pratiche politiche del nostro tempo.
Quando Rosa Luxemburg dice che la rivoluzione non si fa ma si intercetta, non sta criticando la funzione dell’organizzazione nel processo rivoluzionario, ma sta elaborando un criterio al quale avrebbero dovuto attenersi i cosiddetti rivoluzionari di professione nel seguire il flusso degli eventi senza determinarli aprioristicamente. Da questo pensiero possiamo escludere che la storia abbia un volto evenemenziale e messianico al tempo stesso: la storia è, come diceva anche Hannah Arendt, fatta dai liberi e spontanei atti di volontà umana. Nella sua interpretazione sono state le contingenze del mondo a spingere Rosa Luxemburg a prendere parte all’azione rivoluzionaria. Se lo stato degli affari umani non avesse offeso il suo senso di giustizia e di libertà avrebbe potuto occuparsi di tutt’altro: aveva un talento talmente versatile che la spingeva verso la storia, l’economia, le scienze e la natura. Anche questa sua attitudine naturalistica è stata a lungo oggetto di derisione.
Scambiata per una romantica e ingenua amante della natura, Luxemburg aveva invece un’idea drammatica di natura: in essa vedeva quella stessa oppressione che i suoi compagni di partito leggevano soltanto nella storia umana. Questa capacità di saper scorgere l’ingiustizia in ogni manifestazione della vita è, secondo Arendt, una delle eredità che veniva dall’appartenenza di Luxemburg al «gruppo di pari», ebrei assimilati provenienti dall’est Europa, in particolare dalla Polonia e dalla Lituania. Come scrive Nettl nella sua biografia, questo gruppo di pari e di paria aveva degli elevati standard morali, aveva un ethos condiviso che avrebbe dovuto guidare l’azione politica. Questa piccola comunità rappresentava per Arendt l’autentica promessa dello spirito rivoluzionario del XX secolo.
Che cosa rimane oggi di Rosa Luxemburg? Tramontate le velleità di emancipazione, liberazione, ispirate dai principi del socialismo, rimane una concezione molto ampia del concetto di vita e di vivente dove le «lacrime umane» stanno insieme alle nuvole, agli uccelli, alle piante. Significativa la chiusura della lettura arendtiana, quando spera che a Rosa Luxemburg venga riconosciuto prima o poi il posto che le spetta nella storia della politica occidentale. E significativa è anche la chiusura della postfazione in cui si riprende l’epitaffio che Luxemburg aveva inviato alla sua segretaria, Mathilde Jacob, in cui scriveva che come le cinciallegre da lei tanto amate, anche lei confidava, dopo un lungo e solitario inverno nella «primavera che viene».
(il manifesto, 2 ottobre 2022)
Domenica 2 ottobre 2022, ore 10.30-13.00
Invito alla redazione aperta di Via Dogana 3
Libreria delle donne, via Pietro Calvi, 29 – Milano
Sulla maternità
Oggi la maternità non è più un destino. Grazie alle precedenti generazioni di femminismo, si colloca nell’orizzonte della libertà femminile come un desiderio e una possibilità che una donna può cogliere o no, senza esserne definita. Tuttavia in questione c’è il valore simbolico dell’essere tutte e tutti nati di donna, che non sembra ancora riconosciuto dalla società nel suo insieme.
Nel dibattito pubblico, di maternità si parla in caso di allarmi denatalità più o meno fondati, oppure per le alterne vicende dell’interruzione volontaria di gravidanza nel mondo, oggi sotto attacco in primis negli USA; o ancora a proposito di controverse tecnologie riproduttive. Parallelamente, da alcuni anni sui social sta circolando una vera e propria misoginia nei confronti delle madri, che vengono trattate con ironia e disprezzo.
Sentiamo l’urgenza di superare gli specialismi e i luoghi comuni per far emergere un pensiero femminista sulla maternità fondato sull’esperienza, la parola e l’autorità delle dirette interessate: le donne, madri e no.
Introducono Silvia Baratella, Marta Equi e Daniela Santoro
Gli incontri di VD3 contano sullo scambio in presenza. Si consiglia la mascherina.
Poiché i posti sono limitati, prenotatevi all’indirizzo: info@libreriadelledonne.it.
È possibile anche il collegamento in Zoom, sempre su prenotazione.
Appuntamento: domenica 2 ottobre 2022 ore 10.30 presso la Libreria delle donne, via Pietro Calvi 29, Milano, tel. 02 70006265.
Introduzione di Laura Minguzzi della Comunità di storia vivente di Milano
Controra di Katia Ricci è una storia senza aggettivi. La storia è tempo, narrazione del tempo e voglio attirare l’attenzione sul titolo per me molto significativo perché ci dà il là, il punto di vista soggettivo: Controra è il tempo proprio della madre di Katia, quello che lei, Anna, si prende tutto per sé nel paese di Rignano, dove è andata a vivere. Un tempo che tutti sapevano di dovere rispettare. Un intero capitolo porta questo titolo. La storia della madre è già stata scritta da Katia in un libro collettaneo, La Spirale del tempo. Storia vivente dentro di noi. Moretti&Vitali,2018, nel racconto Per amore della vita.
In Controra il focus si sposta sul padre, sulla sua “metamorfosi”. Le immagini della copertina rimandano a un dettaglio di un luogo domestico, uno spazio/tempo del secolo scorso. Come prima impressione, un tempo/spazio patriarcale. Il focolare acceso, in primo piano una damigiana per conservare il vino eccetera. Ma non lasciamoci ingannare. Subito come reazione immediata, io ho pensato alla mia infanzia in una casa di contadini, piccoli proprietari, dove c’era il medesimo focolare, il camino dove mia madre cucinava.
La mia relazione con Katia è di lunga data e confesso che la prima volta che l’ho incontrata, mi ha colpito la malinconia del suo sguardo, i suoi occhi verdi e misteriosi. Un enigma che ho sempre desiderato indagare. In questo libro continua l’opera di svelamento. Leggendo il capitolo Il rumore del grano ho rivissuto sentimenti comuni, legati agli eventi della campagna (la trebbiatura nell’aia per esempio) e ai tempi stagionali dell’agricoltura con le incertezze, i timori per il raccolto, le ansie, le sofferenze, a volte le tragedie in un’epoca di mutazioni per la storia italiana, nel dopoguerra.
Voltando pagina e procedendo nella lettura scopriamo che l’autrice ha messo in atto uno dei presupposti teorici della pratica della storia vivente, cioè rompere il silenzio, non è più da parte ma si fa parte, svelando le origini di una relazione tormentata col padre Pasqualino, e l’io narrante si apre a un altro sguardo. È un passo in più. Il libro ci fa fare esperienza del tempo, un’esperienza materiale. La porosità dei differenti linguaggi agiti, immagini incluse, di cui ci parlerà l’artista e amica Donatella Franchi (il libro è corredato da alcune sue immagini), comunicano in modo non nettamente separato i diversi piani del racconto.
Il racconto di una trasformazione interiore
Ne risulta nell’insieme una grande libertà nel narrare una trasformazione dell’autrice rispetto allo scontro col padre, muro contro muro anche su complesse questioni politiche ed economiche che attraversavano l’Italia in quel periodo. Lei, femminista e comunista, vista dal padre come nemica. Solo dopo avere affrontato le asperità e le contraddizioni nel ripercorrere ed elaborare la relazione con la madre, le è stato possibile andare al nodo col padre: con lo sguardo amorevole della madre, conquistato, adottato, cambiato. Infatti a monte di Controra sta un addestramento, un esercizio per decifrare il sentire proprio con le amiche della Comunità di storia vivente di Foggia.
Senza questo processo di presa di parola e ascolto intimo, questo libro non sarebbe stato scritto, non avrebbe preso forma. Una storia che attraversa luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza, rivista, ripercorsa attraverso ricordi scambiati, relazioni con zie, e zii, lettere, fotografie, poesie, in cui l’autrice ci porge tutti gli elementi per approfondire e comprendere le origini del conflitto in un piccolo paese della Puglia, Rignano, dove la madre Anna va a vivere col “principe azzurro”. Un amore reciproco ma contrastato dalla famiglia. Mi ha colpito la lettura delle pagine in cui Katia descrive la felicità del padre, giovane ufficiale a Potenza, quando viene accolto nel cerchio amoroso della famiglia di Anna, la giovane maestra dagli occhi verde smeraldo che portano luce nella sua vita arida di sentimenti, quasi un grembo materno. Trovò nell’amore di Anna, il calore e l’allegria che nella casa paterna non esisteva.
Per amore di lei
Emerge un padre che si ribella per amore di lei alle regole dei matrimoni combinati, un costume diffuso all’epoca fra i proprietari di latifondi nel mondo agropastorale, per accumulare e non disperdere i patrimoni. In famiglia nascono ostilità e contrasti per la disubbidienza di Pasqualino alle regole patriarcali. Una sofferenza causata dalla sua non accettazione del ruolo impostogli dal padre, in quanto unico figlio maschio dopo la morte del fratello maggiore, a cui toccava il compito di portare avanti e incrementare il patrimonio. Scrive Katia: «Mio padre in quella circostanza si rivelò forte e coraggioso. Il soggiorno a Milano gli aveva aperto nuovi orizzonti. Ho sempre apprezzato questo gesto di mio padre, una scelta esistenziale che aveva rotto con l’antica consuetudine. Anche nonna Lucietta aveva fatto lo stesso, un matrimonio di interesse così come la zia, la sorella del padre, causando altre sofferenze e ingiustizie per via della dote. In una lettera Pasqualino scrive dell’ingiustizia subita e accusa il padre, don Pietro, donnaiolo e ignavo, contrario ad ogni iniziativa del figlio, un vero padre/padrone, di averlo trattato come un servo della gleba, per averlo costretto a restare nel latifondo legato a lui da un rapporto di schiavitù […]»
Un gesto di autonomia, così Katia è in grado di leggere oggi la scelta del padre, intraprendendo con libertà e coraggio la scrittura di Controra. È la verità delle donne. Può farlo, penso io, perché si sente inserita in un orizzonte più grande; in un percorso in cui sono impegnate altre comunità di storia vivente e non solo, una pratica che sfida con qualsiasi strumento, linguistico, fotografico o altro, la storia oggettiva e si assume la scommessa di narrare la storia a partire da sé, dalla esperienza femminile dando voce alla storia annidata in ciascuna/o di noi. Un evento memorabile da collocare nell’orizzonte simbolico della madre.
Katia Ricci, da sempre femminista, ha insegnato a lungo Storia dell’Arte, è cofondatrice dell’Associazione culturale La Merlettaia di Foggia e della Comunità di storia vivente. Ha curato mostre e cataloghi di artisti contemporanei. Tra le sue pubblicazioni più recenti: La lezione delle tessitrici del Bauhaus, in “Lingua bene comune”, a cura di Vita Cosentino (Città Aperta Edizione, 2006); Charlotte Salomon, i colori della vita (Palomar, 2006); Séraphine de Senlis. Artista senza rivali (Luciana Tufani, 2015); Per amore della vita in “La Spirale del tempo” a cura della Comunità di storia vivente di Milano, (Moretti e Vitali, 2018); Lupini violetti dietro il filo spinato. Artiste e poete a Ravensbrück (Luciana Tufani, 2020)
Donatella Franchi dagli anni ’80 crea libri d’artista e installazioni che ha esposto in Italia e all’estero (Istituto Italiano di Cultura di Washington 2001, Università di Barcellona 2004). Alcuni suoi libri d’artista sono presenti in collezioni come il National Museum of Women in the Arts di Washington, e alla Rhode Island School of Design (Providence, USA). Parallelamente al lavoro visivo svolge un’attività di ricerca e insegnamento sul cambiamento che il femminismo ha portato nel mondo dell’arte contemporanea e nel pensiero sull’arte. Ha pubblicato nei Quaderni della Libreria delle donne Matrice, sull’arte relazionale. È docente al Master di politica delle donne all’Università di Barcellona al centro di ricerca delle donne Duoda. Il suo corso di ricerca attuale si intitola La novità fertile. Esperienza femminile e pratiche artistiche.
(www.libreriadelledonne.it, 12 ottobre 2022)
Controra di Katia Ricci, ed. Les Flâneurs, 2022, “è un’esplorazione fatta di scoperte di ciò che era rimasto sepolto nell’inconscio o nelle viscere…”. L’autrice, cofondatrice dell’Associazione Culturale La Merlettaia e della Comunità di storia vivente di Foggia, dialoga con Laura Minguzzi sui modi di una narrazione che investe la storia, i suoi nodi irrisolti e si fonda sulla soggettività di chi la scrive. Sarà presente l’artista Donatella Franchi che ha corredato il testo con alcune sue foto.
Per acquistare online Controra: https://www.bookdealer.it/goto/9791254510582/607
di Angelo Mastrandrea
Compie 60 anni il libro Silent Spring (Primavera Silenziosa) di Rachel Carson ritenuto il manifesto del movimento ambientalista mondiale. Pubblicato nel settembre del 1962 negli Stati Uniti previde con forte anticipo sui tempi gli effetti sull’uomo e la natura degli insetticidi utilizzati in agricoltura. Tanto fu il clamore intorno al libro che anni dopo la pubblicazione venne vietato l’impiego del DDT in agricoltura e vennero emanati una serie di provvedimenti legislativi in materia di tutela ambientale. «L’idea centrale di Silent Spring, ovvero che gli esseri umani siano parte di un delicato e complesso ecosistema, implicava un radicale mutamento culturale, un rovesciamento completo del pensiero, ancora oggi dominante, che pone gli umani al di fuori e al di sopra della natura e dà loro il diritto di sfruttarla, manipolarla, dominarla», afferma Bruna Bianchi, professoressa di Storia delle donne e del pensiero politico contemporaneo presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ora in pensione. «E il pensiero di Carson è rivoluzionario. Nel 1990 Grace Paley, scrittrice e attivista contro il nucleare, ha affermato: Rachel Carson pensava che era necessario amare la natura per poterla comprendere. Non era sentimentalismo. Sapeva che era pericoloso acquisire una conoscenza senza quell’amore. Ci ha insegnato che la vita di un insetto non può essere annientata senza uccidere gli uccelli canori. E che la voce di un uccello canoro non può essere ridotta al silenzio senza avvelenare un bambino. «Se coglieremo a fondo questo messaggio – continua Bianchi – forse potremo arrestare il processo distruttivo che sta devastando il mondo».
Bianchi, è corretto dire che Carson è stata la madre dell’ambientalismo contemporaneo?
La frase, che può suonare enfatica, dà rilievo all’influenza di una donna di scienza e una letterata che ha ispirato generazioni di attivisti, ha avuto un ruolo fondamentale nella presa di coscienza di un vasto pubblico della crisi ambientale, ha indicato un modo diverso di percepire e studiare la natura e di concepire la scienza».
Lei ha scritto che «una donna con una formazione scientifica accusava la scienza di aver imboccato una strada che conduceva alla distruzione della vita, che considerava la natura come ostile…». Su quali argomentazioni si basava Carson?
La critica di Carson si rivolge al concetto di natura statica, alla concezione rigida causa/effetto che non tiene conto della dinamicità dell’ambiente, della continua e complessa interrelazione di forze fisiche, chimiche e biologiche. La chiara illustrazione del principio ecologico dell’interconnessione offriva a lettori e lettrici gli strumenti per opporsi alla direzione imboccata dalla scienza che Carson interpretava come un arresto nell’evoluzione della conoscenza. Silent Spring terminava con queste parole: «Il controllo della natura è una frase concepita nell’arroganza, nata dall’età di Neanderthal della biologia e della filosofia, quando si credeva che la natura esistesse per l’utilità degli esseri umani. È per noi una sfortuna allarmante che una scienza ancora così primitiva si sia dotata delle più moderne e terribili armi e che nel rivolgerle contro gli insetti le ha rivolte anche contro la terra».
Nel 1962 il libro fu osteggiato negli Stati Uniti da molti scienziati…
Questo accadde perché criticava l’economia e il diritto indiscusso «di guadagnare un dollaro a qualsiasi costo» e perché la sua visione ledeva gli interessi degli scienziati strettamente legati all’industria chimica. Inoltre, criticando dalle fondamenta il sapere scientifico, metteva in discussione la figura dello scienziato, «isolato come sacerdote nel suo laboratorio», detentore di una verità impartita dall’alto e indiscutibile. Scrisse nel 1952: «Questo non è vero. Non può essere vero. La materia della scienza è la materia della vita stessa. La scienza è parte della realtà del vivere».
Nel giudizio degli scienziati di quel tempo pesò il fatto che era una donna?
Il dibattito che seguì alla pubblicazione di Silent Spring assunse forti connotazioni di genere e il libro fu attaccato violentemente attraverso l’autrice: negli interventi di autorità politiche e di esponenti dell’industria chimica, nelle vignette apparse sulla stampa, Carson è stata descritta come una zitella emotiva, irrazionale, regressiva, dedita al culto dell’equilibrio della natura. Una donna inutile, perché non sposata e senza figli, che si occupava di cose inutili come gli uccelli, osava sfidare gli uomini di scienza e con essi la razionalità, l’oggettività, il progresso.
Come fu accolto il libro in Italia?
Manca ancora uno studio sulla ricezione di Silent Spring, che apparve in traduzione italiana nel maggio del 1963. L’opera è stata costantemente menzionata nelle sintesi del pensiero e del movimento ecologista, è stata messa in rilievo la sua denuncia dell’uso indiscriminato dei pesticidi, ma non mi pare sia stata analizzata a fondo. Nel 2012, il cinquantesimo di Silent Spring in Italia è passato quasi inosservato. Inoltre, non è stata fatta una lettura integrata con il complesso dei suoi scritti.
In effetti non era la prima pubblicazione di Carson sui temi ambientali…
Al mare Carson dedicò tre opere scientifiche e di grande valore letterario: Under the Sea-Wind del 1941; The Sea Around Us del 1951 e The Edge of the Sea del 1955. In esse lettori e lettrici sono invitati/e a superare il confine tra il mondo umano e naturale, tra mondo terrestre e marino, a pensarli dalla prospettiva delle creature che lo abitano. Nel Mare intorno a noi, una vera e propria biografia del mare, ha anticipato le critiche al paradigma scientifico. Nel 1956 apparve un articolo dal titolo Help Your Child to Wonder, un manifesto pedagogico e letterario sull’esperienza dell’infanzia nella natura che Carson, dopo la pubblicazione di Silent Spring, avrebbe voluto ampliare. Verso la fine della vita era più che mai convinta che il senso della meraviglia, se coltivato fin dall’infanzia, avrebbe favorito quel rispetto che non avrebbe tollerato la distruzione.
Il suo impegno non era rivolto anche all’emancipazione delle donne…
Carson non si definiva femminista, eppure, con il suo modo di intendere la scienza sfidò le divisioni gerarchiche, l’idea che l’oggettività e il distacco fossero superiori alla soggettività e all’emozione, che la sfera pubblica fosse più importante di quella privata, che gli uomini fossero superiori alle donne. Nei suoi scritti mise in discussione le ideologie dell’oppressione ed esercitò una rilevante influenza su scienziate, movimenti femminili e donne comuni. Un forte messaggio di liberazione ci viene anche dalla sua stessa vita: una donna che manteneva la sua famiglia, che non permise mai al sessismo di condizionare il suo agire, determinata ad affermare il diritto di essere ascoltata e che riuscì a dimostrare che le sue idee erano importanti e meritavano attenzione.
Chi è l’erede di Rachel Carson?
Tra coloro che hanno raccolto l’eredità di Carson, ricordo Rosalie Bertell, scienziata scomparsa nel 2012, ma che è oggi un punto di riferimento importante. La sua opera, No Immediate Danger del 1985, è considerata la continuazione di Silent Spring. Al «forte grido di battaglia» lanciato da Carson contro i pesticidi, Bertell univa il suo grido contro le radiazioni. Come Carson sfidò la nozione di oggettività scientifica, accusò di arroganza la scienza moderna che legittimava l’introduzione nell’ambiente naturale di sostanze tossiche prima di averne verificato la pericolosità. Il suo ultimo libro Pianeta terra. L’ultima arma di guerra, pubblicato nel 2000 e aggiornato al 2010, in cui affronta la questione della geoingegneria, ha la stessa forza di denuncia del libro di Carson, esprime lo stesso senso di urgenza e rivolge lo stesso appello alla democrazia, al diritto di cittadini e cittadine di essere informati/e sulle attività che distruggono il pianeta.
(Extraterrestre – il manifesto, 29 settembre 2022)
di redazione sito Libreria
Al Festivaletteratura di Mantova, il 9 settembre 2022 Giordana Masotto e Luisa Pogliana hanno parlato in una sala affollata e partecipe di Vita e lavoro: cambio di scena. A partire da due libri appena usciti: Dalla servitù alla libertà. Vita lavoro politica per il XXI secolo, del Gruppo lavoro della Libreria delle donne di Milano, a cura di Giordana Masotto (Moretti&Vitali), e Una sorprendente genealogia. L’autorità femminile nel management dall’800 a oggi, di Luisa Pogliana (Guerini Next). Pensieri, pratiche ed esperienze per dare forza, idee e radicamento a chi vuole cambiare il lavoro a partire dal nesso vita/lavoro. La scommessa chiave dell’oggi, aperta a donne e uomini che vogliono ritrovare senso e libertà in tutto il loro tempo. Quando le donne prendono pubblicamente la parola a partire da sé e dalla propria esperienza di vita/lavoro diventano soggetti di un processo di cambiamento che riguarda tutti e tutte.
Guarda e ascolta l’incontro (30 minuti): https://youtu.be/LZVAR4flAyc
(YouTube, 9 settembre 2022)