di Comitato contro la guerra, Milano
Siamo donne e uomini amanti della Pace, per questo esprimiamo una forte solidarietà con il popolo ucraino e con il popolo russo, i quali, come in tutte le guerre, sono i primi a pagarne le conseguenze. Ora il nostro obiettivo principale è l’immediata cessazione delle ostilità.
Stiamo dalla parte della maggioranza del popolo italiano che è contrario all’invio delle armi in Ucraina e non crede che la guerra si possa fermare con la guerra. Stiamo con la nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza al nazifascismo e ne ricordiamo il suo articolo 11 che recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali…”.
Riteniamo offensivo che si chiamino in causa i nostri Partigiani a sproposito, solo per legittimare la spinta alla guerra, denigrandone la memoria.
L’Italia e i Paesi dell’Unione Europea si sono piegati al volere degli Stati Uniti, abdicando così a qualsiasi ruolo di possibile mediazione per la cessazione del conflitto. Hanno tralasciato i propri interessi economici e strategici, abbandonando la propria sovranità e si sono invece uniti nel fomentare nonché prolungare questa guerra fratricida.
Quasi tutti i mezzi di informazione non approfondiscono le cause della guerra, mentre tanti statisti nel tempo sono stati consapevoli dei pericoli che avrebbe comportato l’allargamento ad Est della NATO. Pericoli ben compresi anche da Papa Francesco, il quale li espresse con questa frase: “L’abbaiar della NATO alla porta della Russia”. Inoltre gli stessi mezzi d’informazione si prestano a megafono di propagazione dell’odio verso il “nemico”, contribuendo così anche alle vergognose censure verso la letteratura, la musica, l’arte e la cultura russe, riportandoci alla memoria i tristi roghi di libri nella Germania nazista, azioni che in un Paese che si definisce “democratico” non vorremmo mai più vedere.
Questa guerra è iniziata dal colpo di stato del 2014. Da allora Stati Uniti, Unione Europea e NATO hanno speso almeno 100 miliardi di dollari per armare e sostenere l’Ucraina. Prima del 24 febbraio 2022 la popolazione russofona del Donbass, nel silenzio complice dei nostri media, è stata vittima di bombardamenti indiscriminati e di atti criminali, anche da parte di battaglioni militari filonazisti addestrati ed armati dall’Occidente, i quali hanno causato tra le 14 e le 16 mila vittime. Oggi in Ucraina tutta l’opposizione politica è bandita, il collaborazionista delle SS naziste, Stepan Bandera, è divenuto “eroe nazionale” e gli ucraini russofoni sono divenuti cittadini di serie B.
Sulle spalle della NATO, a guida statunitense, pesa la responsabilità di una guerra per procura: il popolo ucraino è mandato al macello.
Siamo consapevoli di ritrovarci in una fase di escalation, la quale continua ad essere fomentata dall’invio di armi sempre più sofisticate e di soldi verso una delle parti in conflitto, volto ad una impossibile sconfitta militare di una superpotenza nucleare, come lo è la Russia: a meno che non si pensi alla fine della vita sul nostro Pianeta. Temiamo che di questo passo esista il rischio concreto di inviare i nostri giovani al fronte o che il nostro Paese divenga un legittimo obiettivo militare: siamo cobelligeranti senza aver dichiarato alcuna guerra ed ospitiamo sul nostro territorio oltre 100 basi militari NATO e statunitensi, con decine di ordigni nucleari presenti in almeno 2 di queste basi.
Le sanzioni sono state presentate da Stati Uniti ed Unione Europea come strumento di pressione per indebolire la Russia e terminare la guerra in poche settimane, cosa che prevedibilmente non è avvenuta, mentre nei fatti sta emergendo che l’obiettivo strategico sia quello di troncare i rapporti energetici e commerciali tra la Russia e l’Unione Europea, così da erigere una nuova cortina di ferro per i prossimi decenni.
L’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, anche come conseguenza diretta delle sanzioni contro la Russia, si sta rivelando devastante per il nostro Paese, per i lavoratori e per i pensionati, dove già i salari reali nel 2021 sono diminuiti del 2,9% rispetto al 1990 (unico Paese in Europa), mentre nel solo 2022 il potere di acquisto è crollato a fronte di un’inflazione a doppia cifra e ben 11 milioni di italiani non riescono a curarsi. Non ci saranno aumenti salariali che andranno a compensare la corsa dei prezzi, bisognerà arrangiarsi per sopravvivere e nel bilancio dello Stato mancherà il denaro per sanità, scuola e tutti quei servizi già oggi largamente insufficienti, mentre si troveranno le risorse per aumentare al 2% del PIL le spese militari, così come richiesto dall’Alleanza Atlantica.
Oggi è prioritaria la necessità di unirsi in un ampio fronte plurale che sia in grado di far avanzare un forte movimento per la Pace nella direzione di un mondo che sia caratterizzato da rapporti di non ingerenza, di reciproco rispetto e di mutuo beneficio fra Stati, pacifici e in contrapposizione ad un mondo unipolare dove regnano la sopraffazione e la rapina. Mai come in questo momento è giusto gridare:
l’Italia ripudia la guerra
L’ONU PROMUOVA LA TRATTATIVA DI PACE
non un uomo, non un soldo, non un’arma per la guerra
No alla propaganda di guerra
SÌ ad una corretta informazione
Per informazioni e adesioni scrivere a: comitatocontrolaguerramilano@gmail.com
(Verdi Ambiente Società, https://www.vasroma.it/appello-per-la-costituzione-di-un-coordinamento-milanese-per-la-pace/, 9 marzo 2023)
di Anna Di Salvo e Adriana Sbrogiò
Invito a convegno
Care amiche e cari amici,
con alcune e alcuni delle Città Vicine e dell’associazione Identità e Differenza di Spinea (VE), abbiamo pensato di chiedere alla Libreria delle donne di Milano di poterci incontrare in presenza nel Circolo della rosa per il Convegno annuale delle Città Vicine sabato 3 giugno 2023 pomeriggio (18-20) e domenica 4 giugno mattina (10-13), in via Pietro Calvi 29.
Desideriamo dare seguito e continuità alla pratica politica delle relazioni di differenza tra donne e uomini portata avanti da Identità e Differenza durante i numerosi incontri svoltisi ad Asolo (TV) e a Torreglia (PD). Il 3 e 4 giugno vorremmo approfondire tale pratica, mettendo al centro le questioni più pressanti del nostro presente: la pace, la guerra, la convivenza tra i sessi nelle città, la crisi ambientale, il conflitto tra economia del desiderio ed economia del profitto… con attenzione all’esperienza artistica che si esprime con sguardi al presente, alla natura, a nuovi spazi. Anche a partire da interventi, articoli e interviste pubblicate nel numero speciale della rivista “Autogestione e Politica prima” della MAG di Verona dedicato al convegno delle Città Vicine “Chi ha paura della libertà delle donne?” e nel numero doppio “Mi prenderò cura di te e di me”.
Testi di riferimento per questo convegno: la nuova edizione del libro di Lia Cigarini La politica del desiderio e altri scritti (Orthotes 2022); il libro di Teresa Lucente Il luogo accanto. Identità e Differenza, una storia di relazioni (Effigi 2020); i quaderni pubblicati nel corso degli anni da Identità e differenza che rendono conto del vivace confronto tra donne e uomini durante gli incontri di Asolo e di Torreglia. Tutti i libri, i quaderni e i numeri della rivista si trovano in Libreria delle donne.
Nei locali del Circolo della rosa verrà esposta la mostra mail-art Donna, vita, libertà a cura dell’associazione La Merlettaia di Foggia e delle Città Vicine, coordinata da Katia Ricci.
La sera del sabato 3 sarà possibile cenare insieme al Circolo: per favore prenotatevi una settimana prima a info@libreriadelledonne.it
Per altre informazioni rivolgetevi a Anna Di Salvo, tel. 333 2083308, email annadisalvo9@gmail.com
(www.libreriadelledonne.it, 11 maggio 2023)
di Judith Butler
Che mondo creiamo mettendo a rischio le opere d’arte, e come può aiutarci l’arte a creare un mondo in grado di contrastare le enormi forze di distruzione? Credo che la soluzione a questo problema stia nel chiamare a raccolta le arti – sia dentro che fuori dai musei, sia di persona che online – per far fronte al negazionismo dilagante e cominciare a immaginare modi per salvare il pianeta. Concordo con la filosofa Anna Longo, che di recente ha scritto: «Nei tempi in cui viviamo […] l’arte sembra non solo impossibile ma anche frivola, impotente. È proprio in momenti simili che abbiamo più bisogno dell’arte, o piuttosto di diventare artisti: non creatori di nuove maschere per i valori che indurranno le masse a desiderare la propria schiavitù, ma agenti vivi, capaci di affermare la vita contro ciò che, col pretesto di renderla possibile, la mutila».
Di seguito una serie di punti. Primo, lo spettacolo pseudo-situazionista del danneggiamento di opere d’arte dipende dalla capacità dei musei di proteggere l’arte. Pertanto gli attivisti vedono, e promuovono, il museo come un luogo dove l’arte viene tutelata. La loro sarà anche una critica al mercato, ma almeno implicitamente è un plauso ai musei, e costituisce una – pur obsoleta – pratica estetica. Secondo, ci sono buone ragioni per criticare l’elitismo dei musei, perciò più il museo viene integrato nello spazio pubblico, meglio è. Anzi, rendere gratuito l’ingresso ai musei, portare la danza, i film, l’improvvisazione all’interno degli spazi museali, comprese le soglie inutilizzate, le fondamenta e i tetti, va sempre bene, a mio parere. Il museo, se è veramente aperto, può ampliare la sfera pubblica e persino evitarne il completo collasso nel digitale.
Terzo, è giusto sostenere che il mercato distorce il valore dell’arte, e che è quasi impossibile avere esperienza di un’opera al di fuori della cornice del mercato. La mercificazione influenza il nostro modo di vedere, sentire, avere esperienza delle opere d’arte e di installazioni e spettacoli in generale, e talvolta lo impedisce tout court. Resta ancora da capire se il valore di mercato esaurisca completamente il valore di un oggetto. E comunque, un conto è dire che il valore di mercato non esaurisce il valore di un oggetto in tutte le sue accezioni, un altro è concludere che il valore della vita è superiore a quello dell’arte. Saltare a una conclusione così affrettata significa dare per scontato che il valore dell’arte non abbia nulla a che vedere con il valore della vita: al contrario, tra arte e vita possono esserci connessioni profonde, e l’arte – di qualunque tipo, compresi i documentari e la sperimentazione digitale – può aiutarci a immaginare e a concepire una catastrofe climatica di cui, quando non la neghiamo del tutto, troviamo intollerabile il pensiero. Se l’arte è un modo per rendere pensabile l’intollerabile e l’impensabile, allora l’oggetto artistico – oggetto in senso winnicottiano – diventa un’occasione di contemplazione che ci induce a comprendere il legame reciproco tra mondo oggettuale e vita organica, un’interdipendenza simile a quella dei processi vitali nelle biosfere terrestri. Winnicott sosteneva che lo spazio, il tempo, l’oggetto affidabile e ricettivo consentono di sopportare e riflettere su passioni altrimenti intollerabili.
La maggior parte dei suoi esempi comincia con il desiderio di distruggere, un desiderio che risulta intollerabile anche perché, se rivolto alla madre o alla figura di accudimento, il bambino o giovane rischia di distruggere l’Altro da cui dipende la sua vita. Dovrà quindi imparare che il suo desiderio di distruggere in realtà non ha il potere di distruggere. Perdendo tale presunzione di onnipotenza, il bambino riconosce la capacità di sopravvivenza dell’Altro, la sua durevolezza. Naturalmente i gruppi di persone, specie se numerosi, sono diversi dai bambini, eppure non riusciamo a superare la dipendenza dalle vite altrui, né ad ammetterne la profondità. Se l’oggetto legittima la possibilità di provare sentimenti intollerabili – compreso l’odio assassino, il dolore irreparabile –, è perché consente la riorganizzazione del materiale psichico.
Nel caso della psicoanalisi, l’oggetto terapeutico – vale a dire il terapeuta – acconsente a farsi prendere a pugni dal paziente, fino a esserne «mutilato», per dirla con Christopher Bollas. Il consenso a diventare destinatario di rabbia e dolore, persino a essere temporaneamente «mutilato» dal paziente, rientra nel contratto psicoterapeutico. Il paziente riesce a sopportare i sentimenti senza paura che si trasformino in azioni, che provare rabbia o odio corrisponda a commettere un omicidio, o che il dolore logori le persone fino ad assimilarle, nella perdita, a chi hanno perduto. Facendo emergere tale distinzione, l’oggetto rende tollerabili i pensieri di distruzione, desiderio, dolore o invidia: se l’espressione di questi sentimenti è tale da poterla osservare e rifletterci, allora le si può sopravvivere e, idealmente, dare inizio al processo di elaborazione dell’intollerabile.
La catastrofe climatica rappresenta una nuova declinazione dell’intollerabile, ed è per questo che abbiamo bisogno dell’arte, ora più che mai. Stephanie LeMenager, docente di Letteratura e Studi ambientali, scrive del lutto preventivo tipico della cultura del petrolio che definisce la nostra modernità, l’angosciante previsione della perdita del mondo che conosciamo, un mondo che annienta il proprio futuro. In un modo o nell’altro, questo mondo è destinato a scomparire a causa del cambiamento climatico, e noi ne piangiamo la perdita, perché insieme al mondo perdiamo anche i ricordi lì incarnati e, per certi versi, tutte le nostre vite. L’industria petrolifera e i combustibili fossili coincidono ormai con il nostro senso del mondo e al contempo ne costituiscono la fonte di distruzione: vivere in un mondo simile, trarne beneficio rappresenta una distruzione che non riusciamo né a vedere né ad arrestare senza prima elaborarne il lutto – cosa che molti reputano impossibile, perché ormai le nostre vite sono diventate inimmaginabili senza il petrolio.
Secondo LeMenager e Catriona Sandilands, «la melanconia ambientale non è che un meccanismo di negoziazione della perdita e della responsabilità ambientale». Prevediamo la perdita del mondo che conosciamo, la distruzione della terra, ma non possiamo ancora elaborarne il lutto. Come sostiene Sandilands, «l’oggetto della perdita è “indegno di lutto” all’interno di una società incapace di riconoscere gli esseri non umani, gli ambienti naturali e i processi ambientali come oggetti degni di un lutto sincero». Non ci limitiamo a prevedere un lutto che subiremo in futuro, ammesso che vivremo abbastanza da assistere alla completa distruzione del clima e del pianeta: probabilmente non ci saremo già più, perciò viviamo con la prospettiva di quel giorno, o manciata di giorni, la svolta finale e irreversibile. Il vero problema è che continueremo a perdere il pianeta giorno dopo giorno, se non ci rassegniamo a dire addio alla nostra dipendenza dal petrolio.
È una perdita continua, perché siamo nel pieno della catastrofe climatica, costretti a ripensare il significato dell’elaborazione del lutto a fronte di una perdita ancora incompiuta, che, per definizione, non avrà testimoni del suo compimento. L’arte può dare una scossa solo se dimostra e documenta la normalizzazione della distruzione. La normalizzazione del consumo e della produzione di petrolio è un processo di distruzione, e come tale andrebbe presentata. Abbiamo bisogno di forme d’arte che lottino per la vita nel mezzo della distruzione, e al contempo smascherino gli stratagemmi attraverso i quali la rovina si spaccia per progresso o, peggio ancora, per normalità.
La teorica ambientale Heather Davis ha coniato la perfetta definizione di «archivio performativo di presente». «Una testimonianza», scrive Davis, «che documenta non la condizione delle cose perdute, ma il lutto preventivo e il sentimento perturbante di un mondo ormai scomparso». E, aggiungerei, la scomparsa del mondo si verifica proprio mentre cerchiamo di capire come elaborare il lutto quando la perdita è ancora in corso, come resistere alla perdita nel bel mezzo del lutto.
(il manifesto, 10 maggio 2023)
di Emi Monteneri
Il 10 maggio 1924 nasceva a Catania Goliarda Sapienza. Dai genitori, entrambi figure di spicco della sinistra italiana, riceve un’educazione alternativa alle scuole del regime fascista, improntata ad un forte senso di libertà. Scrittrice e attrice, ha lavorato con Luchino Visconti e Citto Maselli, suo compagno per tredici anni. Per celebrare quello che sarebbe stato il suo novantanovesimo compleanno, proponiamo un estratto dal volume collettaneo “Le personagge sono voci interiori”,
dove Emi Monteneri immagina una intervista impossibile a Goliarda Sapienza, a partire dai luoghi e dalle persone della sua infanzia.
Goliarda non è stato un amore a prima vista. L’ho conosciuta con colpevole ritardo. Inizialmente non riuscivo a superare le prime cinquanta pagine de L’arte della gioia: troppi delitti, troppo dolore. Non capivo. Non ero pronta. Poi l’incontro “vero”, che mi ha ricondotta alla lettura del romanzo, cioè a Modesta, legandomi a lei inesorabilmente. Ma l’esplosione amorosa è avvenuta con Io, Jean Gabin. Goliarda mi parlava, e si raccontava, costringendomi a ripercorrere la sua esistenza, e quindi la sua scrittura dove si ricomponeva un sistema che creava mondo, che creava un nuovo senso di vita. Allora ho dovuto superare un senso di colpa divorante: cosa facevo, cosa leggevo mentre lei si dibatteva tra mille difficoltà? Mi dava angoscia scoprire in me la stessa indifferenza, o ignoranza, che ha contraddistinto persone che la circondavano e che non ne hanno scoperto il giusto valore. Il riconoscimento di disparità agiva in me in modo imprevisto e infantile, ma scoprire le fragilità di colei che sempre più si configurava come una “madre simbolica” me la rendeva affettivamente vicina, anche se il tributo alla sua autorità mi imponeva un doveroso distacco.
È stata proprio la scrittura di Goliarda a consentirmi di riequilibrare le distanze e accostarmi a lei per un confronto sereno.
Oggi mi piace ritrovarla nei luoghi della sua infanzia e percorrerli insieme: la Civita, il cinema Mirone… Dialogo dai toni diversi, ora ciarliero, ora pacato, o muto, quasi interiorizzato, seguendo con pensieri sospesi la sua voce resa unica da quella inflessione catanese che tanto la fece penare all’Accademia d’Arte Drammatica, e che adesso fa eco e si dilata dentro di me. Goliarda, scrittrice, attrice e donna di spettacolo si è sempre rivolta al suo pubblico di lettrici e lettori in un dialogo continuo, come con un pubblico teatrale. Goliarda artista poliedrica ma semplice ed essenziale.
Alla radice della sua arte sta la ricerca inesausta di “purezza” che conduce alla libertà. Goliarda scrittrice e personaggia, mente e corpo della sua scrittura, che porta in giro e mostra sempre la sua essenza di donna libera, la cui origine siciliana, profondamente radicata, non coincide mai con alcuno stereotipo, che, anzi, irrispettosa, nella vita come nella scrittura, di tutti gli schemi preordinati, rompe e attraversa tutti i modelli stereotipati. Lei “odia” – come si può odiare un nemico, o, ciò che è lo stesso, un ostacolo alla libertà dell’esistenza – tutte le manifestazioni di miseria femminile: vittimismo, rinuncia, dipendenza affettiva e materiale, mansuetudine, e, come fa Virginia Woolf con l’angelo del focolare, semplicemente “le uccide” perché mortifere e indegne della grandezza femminile. Grandezza che lei riconosce alla sua magnifica e inafferrabile madre, la socialista rivoluzionaria Maria Giudice. In tutti i romanzi di Goliarda Sapienza, almeno in quelli che ho letto, individuo una ricerca ed un omaggio continuo alla grandezza materna, a partire da quella della propria madre.
La madre e la galera, argomenti non tanto lontani come potrebbero sembrare, saranno i temi brevemente trattati in questa “intervista impossibile”.
Ma ecco Goliarda mi/ci parla, attraversando il tempo e giungendo a noi con la ricchezza del suo pensiero e dell’amore di vita che trasmettono sempre le sue parole.
Goliarda Sapienza è nata a Catania nel 1924 e morta a Gaeta nel 1996. Dai genitori, entrambi figure di spicco della sinistra italiana, riceve un’educazione alternativa alle scuole del regime fascista, improntata ad un forte senso di libertà.
A partire dai sedici anni visse a Roma, dove studiò all’Accademia di Arte Drammatica. Negli anni Cinquanta e Sessanta recitò come attrice di teatro e di cinema, lavorando, tra gli altri, con Luchino Visconti (in Senso), Alessandro Blasetti, Citto Maselli, di cui fu la compagna per tredici anni. Al suo primo romanzo, Lettera aperta (1967), seguirono Il filo di mezzogiorno (1969), L’Università di Rebibbia (1983), Le certezze del dubbio (1987) e, postumi, L’arte della gioia (1998), romanzo di tutta una vita, a cui si dedicò per oltre dieci anni senza trovare alcun editore disposto a pubblicarlo; i racconti Destino coatto (2002), il romanzo Io, Jean Gabin (2010), Il vizio di parlare a me stessa (2011), raccolta significativa di appunti tratti dai suoi numerosi e famosi taccuini.
Intervistatrice: Che bello il tuo nome, Goliarda, bello e raro.
Goliarda: Mi hanno messo nome Goliarda. Mio padre me lo mise, essendo ateo, perché era un nome senza santi. Con questo nome, da bambina, mi sentivo sola: non c’era nessuna Goliarda o Goliardo in tutta Catania e, per me, in tutto il mondo. Cominciai a dire che mi chiamavo Maria: era il nome di mia madre, e quindi non doveva essere un furto troppo rilevante.
I.: Grande famiglia, la tua.
G.: Mio padre, l’avvocato Sapienza, era un socialista con il vizio dell’assistenza. I più lerci delinquenti lui li raccoglieva all’uscita dal carcere e li sistemava o a casa propria o in qualche ufficio così noi avevamo sempre qualche avanzo di galera che puliva i vetri, lucidava le scarpe o accendeva il fuoco. Anche donne. La nostra Tina, per esempio. Aveva una voce dolce e cucinava favolose frittate, ma nella sua giovinezza gloriosa aveva ucciso a colpi di lupara, mentre facevano l’amore, il fidanzato e la sorella. E poi c’era Zoe che di tanto in tanto la sostituiva e di notte si aggirava con un coltellaccio nascosto in seno. Aveva ucciso, a coltellate, la madre e ferito il fidanzato.
I.: E i tuoi fratelli?
G.: Ogni tanto venivano i fascisti a strapazzarli un po’ e papà correva in questura per farli rilasciare, ma quando zoppicando tornavano a casa, trovavano pronto brodo, bollito, e una bella bistecca da mettere sull’occhio nero. Troppe ne ho viste di queste visite.
I.: Il quartiere della Civita, denso di storia e di misteri, ti ha vista attraversarlo spavalda, imitando il passo di Jean Gabin, il tuo eroe. Oggi della Civita, cioè il quartiere di S. Berillo, sventrata nel 1954, resta ben poco.
G.: Quello che non hanno fatto i fascisti, lo hanno fatto i democristiani. La Civita, di notte, quando i bassi erano chiusi, svegliava i suoi mostri scolpiti in quella pietra affilata e nera, e cominciava a risonare di gemiti, grugniti, fiati lunghi di serpenti, meduse e melusine…
I.: Dove abitavi?
G.: In via Pistone. Di notte c’era sempre una scusa per far baldoria. La gente attiva, piena di vita, magra e scattante, insomma, antifascista, dorme poco e non si annoia mai. E se qualcuno del palazzo osava replicare, allora la lama del mio stocco verbale usciva dal legno a graffiare: non viviamo di marcia rendita borghese, noi! Né lasciamo che il Duce o un santo qualsiasi pensi a noi. Prova a vivere libero, e vedrai il tempo che ti resta per dormire.
I.: Come vissuto la tua infanzia? Andavi a scuola?
G.: I miei genitori non volevano che frequentassi la scuola fascista. La mia divisa di piccola italiana è stata bruciata sul terrazzo. Passavo lunghi pomeriggi al Cinema Mirone o all’Arena Bellini. In fondo a casa preferivano sapermi al sicuro dentro un cinema, al riparo dalle incursioni fasciste che devastavano la nostra biblioteca. È lì che ho visto La regina Cristina con Greta Garbo. Lì ho conosciuto Charlot, artista anarchico e libertario, lì ho cominciato a identificarmi in Jean Gabin, l’eroe della Kasbah.
I.: Ti conosco solo attraverso i tuoi libri, in cui esprimi un forte bisogno d’amore.
G.: Senza sale l’organismo muore, e in fondo non è grande danno, ma senza amore si diventa assonnati, fragili, avari, larve d’uomo. Ma non era facile parlarne in famiglia. Tutti a casa mia, anche le donne, erano contrarie a quella parola da donnette. L’unica ad ammettere che l’amore era degno di essere preso in considerazione era mia madre, ma la faceva così complicata! Doveva essere un amore libero da convenzioni, da ricatti psicologici o finanziari… Insomma era meglio stornare il discorso sulla Grecia antica, la politica o la filosofia…
I.: Tua madre, Maria Giudice! Grande intellettuale rivoluzionaria.
G.: Su Maria non mi soffermo perché, come mio padre, è conosciutissima: era stata pure lei in galera per il bene degli oppressi. Studiava, e allora dovevo studiare anch’io per diventare come lei. Ecco la donna che Jean non avrebbe potuto non amare, se l’avesse incontrata. È stato mio fratello Ivanoe che si è preso cura di me in modo materno. La zia Grazia si indignava: Povera figlia, che unghie! Non è possibile che tua madre non te le tagli mai! Diceva. Oh, ma che razza di mutandoni porti? Sembri incinta, povera figlia! È possibile che tua madre… Mia madre chi? Rispondevo. Ivanoe? Ma Ivanoe deve dare tre esami…
I.: Ma come ti vedevi, cosa volevi realizzare da grande?
G.: La mamma mi diceva: potresti diventare medico, avvocato, come tuo padre: preparati a diventare sindacalista come me, per quando il fascismo finirà.
I.: Lei in fondo era la tua difesa da un destino di donna chiusa in casa a fare figli, di una donnetta come diceva lei.
G.: Quando ho saputo che alla mia amica Nica era venuto il sangue e doveva stare a casa ad aspettare un marito, ho avuto orrore. Mi chiedevo se veniva a tutte le femmine. Anche mia madre l’aveva? Mia madre non aveva detto sono donnette che non sanno fare altro che aspettare un marito? E aveva anche detto tu Goliarda, non sei una donnetta. Infatti io non volevo un marito, ma un compagno, come lei…Sarei stata come mia madre e se non aspettavo un marito, il sangue non sarebbe venuto.
I.: Tu hai sempre manifestato distacco nei confronti di figure, legate alla tradizione del sud, che rimandano un’immagine di miseria femminile.
G.: Sono modelli pericolosi per le donne, ma anche per tutta la società. Donne come la signora Bruno, sacco nero sformato che apre la porta di casa con le mani umide di farina, che prega o frigge; o come la madre di Modesta che urla o tace; o come madre Leonora, la superiora del convento, che ricamava e pregava perché abitua all’umiltà e all’obbedienza. Diventerò anch’io una dotta? Domandavo. Pazzerella che sei! A che ti servirebbe se sei una donna? Rispondeva. La donna non può arrivare mai alla sapienza dell’uomo.
I.: Tua madre è stato per te il più straordinario modello di forza femminile. Mi chiedo quanta di questa forza contenga la tua personaggia Modesta.
G: Maria Giudice fa una fugace apparizione in L’arte della gioia, la cito tra le donne di riconosciuta autorità della nostra storia. Modesta ha la forza che conduce alla libertà, è il sogno realizzato di una vita libera.
I.: Ma l’equilibrio psichico di tua madre crollerà.
G.: Pazzia… Le è scoppiata tra le mani proprio quando il suo nemico cadde distrutto. Cadendo lui, si ruppe la tensione per la quale aveva vissuto estraniandosi da se stessa.
I.: L’hai assistita nella sua malattia per tre anni.
G.: Diventai madre di mia madre. Ora provo grande rimorso, ma mi vendicavo facendole vedere come si cura una figlia, lei che occupandosi solo della mia mente, mi aveva trascurata in tutti i modi.
I.: La fine tragica, segnata dalla pazzia, ha contraddistinto donne forti e autorevoli.
G.: Penso a Virginia Woolf suicidatasi dopo avere scritto Orlando: come può stare vicina a quest’atto assurdo tanta freschezza e fantasia gioiosa: cosa l’ha tradita? Io so cosa. Ha pagato il suo osare entrare tra i grandi senza tradire il suo essere donna. Spero di farlo anch’io col tempo. La follia sembrerebbe quasi un porto per tutte le donne che falliscono; allora perché anche per Virginia e per mia madre lo è stato? Probabilmente la loro riuscita non appagava il tribunale antico di donna che le giudicava traditrici per aver osato uscire dai limiti concessi. Per loro era una condanna che le faceva sentire in colpa e le rendeva infelici anche mietendo grandi successi. Quanto a me, probabilmente non diventerò mai pazza, ma disertrice mi sento già.
I.: Sei stata in carcere per un breve periodo. Che avevi fatto?
G.: Ti rispondo come a Giovannella, una piccoletta incinta incontrata a Rebibbia: sai cosa ho fatto per finire qui? Un lungo viaggio in Russia e in Cina che ha spazzato quel poco d’etica che mi era rimasta… Da dodici anni non riuscivo più a pubblicare una riga; per dieci anni ho lavorato a un lungo romanzo e nel frattempo tutto cambiava: amici, situazioni, rapporti. Ero scivolata da ultimo in un ambiente pseudo-libero, pseudo-elegante, e così ho rubato a una di queste pseudo-signore per punirla. O per punirmi? Insomma un bell’acting-out da manuale.
I.: In carcere hai imparato in fretta, suppongo.
G.: Lì sai subito chi sarai nella vita, non ti è concesso crogiolarti nel falso problema di cercare la tua identità. Non c’è differenza fra dentro e fuori. Le donne conosciute sono comuni, come quelle che si incontrano per strada. Il carcere è sempre stato la febbre che rivela la malattia del corpo sociale: continuare ad ignorarlo può farci ripetere il comportamento del buon cittadino tedesco che ebbe l’avventura di esistere nel non lontano regime nazista.
I.: La tua ricerca di verità cosa ti ha fatto scoprire in carcere?
G.: Queste donne conoscono l’arte dell’attenzione all’altro, sanno che dalla condizione di una dipende quella delle altre: attenzione e solidarietà a chi ti è amica, ostruzionismo a chi ti è nemica. Impossibile trovare sfumature in questo consorzio: lingue, dialetti, diversità di classe e di educazione sono spazzati via come inutili mascherature dei veri moventi del profondo. Questo fa di Rebibbia una grande università cosmopolita dove chiunque può imparare il linguaggio primo.
I.: Credi ancora che tenersi stretti al sogno sempre, e sfidare anche la morte per non perderlo mai, come affermi in Io, Jean Gabin, sia l’unica via possibile?
G.: Sento ancora la sua voce: La vita è lotta, ribellione e sperimentazione, di questo ti devi entusiasmare giorno per giorno e ora per ora. Vedi me, sono morto tante volte combattendo, eppure sono qui con te tranquillo a ricordare e gioire delle mie lotte, pronto a rinascere e a ricominciare…
questo è il segreto … da lui solo sgorga quella che comunemente chiamiamo Vita.
I.: Ti ringrazio Goliarda per la tua grandezza che arricchisce tutte e tutti noi e per quel grande amore di vita che trasmettono sempre le tue parole.
Estratto a cura di Emi Monteneri in “Le personagge sono voci interiori” a cura di Gisella Modica. Vita Activa, Trieste, 2016
(Letterate Magazine, 10 maggio 2023)
di Davide Re
Asse tra Lega e Partito democratico contro la procreazione assistita. Al Comune di Milano, le consigliere comunali Deborah Giovanati (del Carroccio) e la consigliera Roberta Osculati (eletta nelle fila dei dem) hanno presentato un documento congiunto per chiedere all’amministrazione guidata dal sindaco Beppe Sala di fare chiarezza sull’evento “Wish for a baby” (desiderare un bambino), il cui scopo è, scrivono gli organizzatori della manifestazione, «far incontrare gratuitamente i migliori esperti di fertilità di tutto il mondo», ma in pratica per offrire servizi e informazioni sulle varie tecniche di procreazione assistita.
L’evento è in programma nello stesso periodo (sabato 20 e domenica 21 maggio), negli stessi spazi, con le stesse finalità di quello programmato e poi sospeso un anno fa a Milano e per questo le consigliere hanno depositato un ordine del giorno «che invita l’amministrazione comunale a fare chiarezza sulla manifestazione e ad attivarsi con la questura e le forze dell’ordine per evitare che venga pubblicizzata la maternità surrogata, in palese violazione della legge italiana».
«Non possiamo accettare – hanno spiegato Giovanati e Osculati – che vengano surrettiziamente passati contenuti contrari alle norme in vigore nel nostro Paese, che con l’art. 12 della Legge 40/2004 vieta e sanziona qualsiasi forma anche solo di pubblicizzazione della maternità surrogata».
«Noi ci opponiamo totalmente ad una manifestazione che, utilizzando gli strumenti tipici del marketing e della pubblicità più accattivante, propone di fatto una idea di bambini trasformati in merce e del corpo delle donne in contenitore – ha detto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella –. È una grave offesa alle donne. Perciò ho rivolto una interrogazione al ministro della Salute Schillaci per chiedere: iniziative per impedire lo svolgimento della fiera “Wish for a baby”; se l’evento violi la legge sulla fecondazione; se risulta che la fiera abbia usufruito di sovvenzioni dirette e indirette da parte di soggetti pubblici; se non ritenga che la fiera, pubblicizzando il mercato globalizzato di gameti e di embrioni non sponsorizzi di fatto la surrogazione di maternità». “Wish for a baby” è presentato nei siti, ha detto ancora Zanella, come «primo evento gratuito interamente dedicato alla fertilità e alla genitorialità. In realtà è una fiera della maternità in provetta e delle tecniche di procreazione assistita che si è già svolta in altre capitali europee».
Contraria alla manifestazione, definita senza troppi giri di parole: «La fiera della provetta», anche la rete di associazioni femministe e Lgbt, che tra le sue fila annovera realtà come Arcilesbisca e Resistenza Femminista e molte altre: «La pratica dell’utero in affitto consiste nel disporre di corpi di donne per avere bambine e bambini su ordinazione».
(Avvenire, 9 maggio 2023)
di Annalisa Ambrosio
Ci sono vite che vengono raccontate più spesso di altre e quella di Hannah Arendt è certamente tra queste. Forse il suo personaggio letterario è così interessante perché è polifonico e attraversa i generi in maniera libera e anticonvenzionale: europea naturalizzata americana, filosofa che finisce per passare alla storia come reporter, in pochi anni allieva prediletta di Martin Heidegger e pure di Karl Jaspers, è intellettuale e due volte moglie, ha svariate lingue all’attivo e amici famosi sparsi in tutto il mondo. Come materiale è piuttosto ghiotto per desiderare di scriverne, ma anche un ginepraio dal punto di vista storiografico, perché la sua esistenza interseca di continuo la Storia, e di lei si potrebbe dire senza troppa esitazione che – talvolta suo malgrado – si trovava là dove le cose accadevano e, quando non capitava, prendeva un aereo per andarci. Così, infine, se il romanzo di Hildegard E. Keller racconta di nuovo Hannah, il compito principale di ogni recensore è quello di chiedersi che cosa c’era da aggiungere ancora e qual è la qualità essenziale di questo racconto.
Prima di rispondere alla domanda, meglio spiegare brevemente com’è fatto il libro di 508 pagine, che è uscito da poco per Guanda. Intanto si parte dalla fine, perché il primo capitolo prende il titolo di L’ultima estate (trad. di Silvia Albesano), e si ambienta in effetti durante il viaggio per Tegna, meta svizzera della residenza estiva di Hannah Arendt, che poi è morta lo stesso anno a New York di un attacco cardiaco. Da qui, dall’ultimo anno di vita, si saltabecca nel passato e di nuovo nel futuro in un grande slalom che va da Manhattan a Colonia, da Berkeley a Gerusalemme e così via. Nonostante la mobilità sia spaziale sia temporale, il perno del romanzo resta l’estate svizzera, e questo non è un dettaglio da poco perché conferisce alla biografia una specie di stadio parallelo, di tempo non tempo, di calma, di lentezza particolare, come se paradossalmente il punto migliore dal quale osservare una vita come quella di Arendt non fosse il lavoro o l’opera, il segno che ha lasciato nel mondo, la vita activa, ma semmai il suo respiro intimo, il ritiro, la solitudine matura. In fin dei conti è in questo spazio non congestionato dal calendario o dalla corsa del mondo, contemplativo, che un intellettuale si mostra come tale di fronte a sé stesso, cioè sceglie liberamente di dedicare le sue ore a pensare, perché così si sente in vita, o sereno, al riparo dai colpi della fortuna. Oltre a non fare del romanzo un thriller, una simile impostazione scelta da Keller ha significato per lei affrontare una difficoltà tecnica spaventosa: non è semplice rappresentare l’affioramento del pensiero, spingersi a mostrare come ha pensato una persona realmente esistita, e farlo non tanto ripercorrendo il suo ragionamento, quanto invece simulando quel che capita quando flash, intuizioni, considerazioni nuove sorgono negli attimi di pausa, si affacciano da una balaustra apparentemente vuota.
Qui siamo di nuovo a Tegna, è il 1° agosto del 1975: «Alle sue spalle sentiva le auto che sfrecciavano sul ponte e una sorta di crepitio proveniente da Tegna, come fuochi d’artificio. Si riscosse, si sporse in avanti con cautela e aspirò a pieni polmoni la frescura che saliva verso di lei dall’orrido gorgogliante. I fiumi sono fondamentali, cari fiumi. È davvero un grande mistero come un piccolo torrente di montagna possa trasformarsi nel Colorado River. Senza fiumi la terra sarebbe perduta, ma l’orrido della Maggia è davvero unico. Nella sua ultima estate lì, anche Heinrich aveva sgranato gli occhi, quando si era trovato accanto a lei su quel ponte». Non è che un esempio di come Keller, che ora insegna storytelling all’Università di Zurigo, ha scelto di procedere e di gestire il palcoscenico.
Hannah guarda il panorama della valle e la sua meraviglia arriva dai sensi, pensare a tutti i fiumi del mondo è un bisogno che fa tutt’uno col respiro, ma tutti i fiumi del mondo con le loro ragioni si fondono fino a ritornare a coincidere con quell’unica visione dell’orrido davanti ai suoi occhi, perché qualcosa di più carsico affiora, ed è il ricordo di Heinrich. Oltre a essere ragionevolmente credibile e autentica, questa ricostruzione dell’andamento del pensiero ha il vantaggio, per l’autrice, di fare risvegliare visioni nelle visioni, ricordi nei ricordi. Al passato più lontano o più prezioso di Hannah, nel corso del libro, si accede la maggior parte delle volte così, con la tecnica dell’affioramento, casuale e non causale – dopotutto arriviamo a conoscerci abbastanza da comprendere che le figure della nostra mente ricorrono, si riverberano tra loro e non escono mai dal nulla. Anche se a prima vista una simile strategia di racconto potrebbe apparire lenta, una volta compreso il gioco, lo spazio contemplativo diventa confortevole per il lettore perché il più delle volte è caldo, sentimentale, è il luogo privilegiato degli amori presenti e passati di Hannah Arendt, ma anche dei suoi problemi più espressamente filosofici.
Questa descrizione dello stile e del taglio scelto da Keller per affrontare Arendt nel suo primo libro potrebbe indurre a pensare che il testo sia statico, seduto: non è così, non è un genere di romanzo in forma di terra desolata, senza altre persone eccetto la protagonista, è bello anzi notare come sia pieno di dialoghi con amici, mariti, ma anche con estranei o nuovi incontri che tra le pagine finiscono per brillare e diventare qualcosa. Tra questi svettano soprattutto le amicizie femminili, come quella con la poetessa Ingeborg Bachmann o con la giovane Annemarie, una ragazza che Hannah incontra per la prima volta alla redazione del giornale per cui lavora e di cui farà la fortuna, convincendo suo padre a lasciarle frequentare l’Università. Negli scampoli diffusi di abitudine e di mondanità si avverte il piglio pragmatico di Arendt, la sua capacità di tenere insieme le cose, i pensieri e le persone, di istituire cerchie di legami, nonché il suo stile di scrittura e di insegnamento.
Proprio all’insegnamento è dedicata una delle scene più vivide di tutto il libro.
Siamo a Berkeley, nei primi anni Cinquanta, e dopo la presentazione del corso in Political Science un ragazzo chiede alla professoressa Arendt di illustrare per cortesia le modalità d’esame, lei risponde: «Chi vuole un buon voto, nel mio corso, dovrà imparare a pensare, al di là dell’argomento, ma naturalmente possiamo pensare sempre e solo sulla base di contenuti concreti. Sarete voi a proporre gli esempi, non io». Di lì a poco si parlerà di totalitarismo, di comunismo, di lager, di democrazia, ovviamente di Europa e di America. Alla fine, Hannah dirà anche che cosa è strettamente necessario consegnare per superare l’esame, e diventerà un’insegnante piuttosto amata, per quanto divisiva. Tra le richieste più spiazzanti ai suoi studenti, poi, si registra quella di presentarsi in aula portando una poesia.
E proprio la poesia è un’altra grande protagonista di questo romanzo, che prende il titolo da alcuni versi di Hannah stessa: «Quel che siamo e sembriamo / oh, a chi importa. / Quel che facciamo e pensiamo / non toglie il sonno a nessuno». I suoi stessi versi le sovvengono mentre parla alla nuova amica Barbara del legame che aveva maturato con Walter Benjamin, negli anni prima che per lui fosse troppo tardi. È come un problema di matematica o di geometria di cui questi versi rappresentano solo la necessaria premessa senza poi fornire la conclusione e la soluzione, anche perché la poesia è appena iniziata e non finisce qui, come se l’invito di Hannah, nella strategia di Keller, fosse quello di sfidare i lettori ad andarla a cercare, a ritrovare la poesia, a leggerne il finale. È questa la fatica del biografo, prima, dopo e durante la ricerca: scontrarsi con una materia al tempo stesso incandescente e completamente inutile o indifferente, un sacro fuoco di paglia. Andare sempre più vicino al posto in cui brucia una vita, e trovarsi con un pugno di mosche, cioè a toccare con mano che alle fine tutte le vite si assomigliano e si esauriscono nel rapporto evanescente tra «quel che siamo e quel che sembriamo», appunto. Eppure, Keller ha scelto la seconda parte del verso per il titolo del suo libro, forse perché gli altri, per quanto di noi sappiano o abbiano studiato, non possono che limitarsi a dire quello che a loro è apparso.
Tra le pagine sono molto diffuse le citazioni di Arendt, delle sue poesie, degli articoli, dei saggi, delle lettere: sono preceduti e seguiti da un cambio di paragrafo come una piccola riverenza. Sono utili per dare ritmo e aria al testo, ma anche estremamente eloquenti rispetto alle scene raccontate. È evidente che sono stati disseminati con precisione laddove era importante dire qualcosa senza giri di parole, andando dritti alla fonte.
Un’ultima cosa da dire su questa biografia riguarda il suo rapporto con le urgenze del lettore, che hanno sempre un tratto morboso: sentire e vedere l’amore con Martin Heidegger, sentire e vedere il processo a Adolf Eichmann, magari sentire e vedere la paura di una giovane donna ebrea di fronte al Vecchio Continente in fiamme. Keller ha grande riserbo nei confronti degli aspetti più delicati o spettacolari della vita di Arendt, ce li fa arrivare illuminati da una luce circonfusa. Ci sono ma non sono il vettore principale, non sono il compimento di nessuna parabola. È un punto forte del libro che, una volta arrivati alla conclusione, un’illuminazione di altro tipo, più diretta, non ci sia mancata per niente. Abbiamo guadagnato anzi dei ritratti più delicati e altrettanto coinvolgenti, come nei capitoli iniziali dedicati al rapporto di Hannah con sua madre Martha. È un piacere sentirle parlare, vedere una figlia affezionata ma schiva e una mamma innamorata della sua figlia eccezionale. È un conforto, infine, accorgersi che anche per le più grandi personalità vale la regola che «Quel che facciamo o pensiamo», la gran parte delle volte, «non toglie il sonno a nessuno» eccetto che a nostra madre.
(Doppiozero, 9 maggio 2023)
di Naomi Klein
I CEO del settore tecnologico vogliono farci credere che l’IA generativa porterà benefici all’umanità. Si stanno prendendo in giro da soli.
Tra i molti dibattiti che ruotano intorno alla rapida diffusione della cosiddetta intelligenza artificiale, c’è un conflitto relativamente oscuro incentrato sulla parola “allucinazione”.
Questo è il termine scelto da architetti e fautori dell’intelligenza artificiale generativa, per descrivere le risposte del tutto inventate o sbagliate fornite dai chatbot. Come per esempio quando si chiede a un bot la definizione di qualcosa che non esiste e lui, in modo piuttosto convincente, ce ne dà una, completa di note a piè di pagina inventate. «Nessuno del campo ha ancora risolto i problemi di allucinazione», ha dichiarato recentemente a un intervistatore Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet.
È vero, ma perché chiamare gli errori “allucinazioni”? Perché non “spazzatura algoritmica”? O glitch (problema tecnico)? L’allucinazione si riferisce alla misteriosa capacità del cervello umano di percepire fenomeni che non sono presenti, almeno non in termini convenzionali e materialistici. Appropriandosi di una parola comunemente usata in psicologia, nella psichedelia e in varie forme di misticismo, i sostenitori dell’IA, pur riconoscendo la fallibilità delle loro macchine, stanno contemporaneamente alimentando la mitologia più cara al settore: quella secondo cui, costruendo questi grandi modelli linguistici e addestrandoli su tutto ciò che noi umani abbiamo scritto, detto e rappresentato visivamente, i fautori dell’IA stanno mettere al mondo un’intelligenza animata che è sul punto di innescare un salto evolutivo per la nostra specie. Altrimenti come farebbero bot come Bing e Bard a volteggiare nell’etere?
Certamente nel mondo dell’intelligenza artificiale sono in atto allucinazioni distorte, ma non sono i bot ad averle; sono i CEO delle imprese tecnologiche che li hanno scatenati, insieme a una falange di loro fan, a essere in preda ad allucinazioni selvagge, sia individualmente che collettivamente. Definisco l’allucinazione non in senso mistico o psichedelico, ovvero stati di alterazione della mente che possono effettivamente aiutare ad accedere a verità profonde e non percepite in precedenza. No. Queste persone sono semplicemente in trip: vedono, o almeno sostengono di vedere, prove che non ci sono affatto, persino evocando interi mondi che metteranno i loro prodotti al servizio del nostro miglioramento e della nostra istruzione universale.
L’intelligenza artificiale generativa porrà fine alla povertà, ci dicono. Curerà tutte le malattie. Risolverà il cambiamento climatico. Renderà i nostri lavori più significativi ed emozionanti. Scatenerà vite piene di contemplazione e svago, aiutandoci a recuperare l’umanità che abbiamo perso a causa della meccanizzazione del tardo capitalismo. Metterà fine alla solitudine. Renderà i nostri governi razionali e reattivi. Temo che queste siano le vere allucinazioni dell’IA e le abbiamo sentite in continuazione da quando Chat GPT è stato lanciato alla fine dell’anno scorso.
Esiste un mondo in cui l’IA generativa, come strumento potente di ricerca predittiva e come esecutore di compiti noiosi, potrebbe essere davvero utilizzata a beneficio dell’umanità, delle altre specie e della comunità. Ma perché ciò accada, queste tecnologie dovrebbero essere impiegate all’interno di un ordine economico e sociale molto diverso dal nostro, ovvero di un sistema che abbia come scopo la soddisfazione dei bisogni umani e la protezione di tutto l’ecosistema a sostegno della vita. E come sanno bene quelli di noi che al momento non stanno incappando in errori, il nostro sistema attuale non è affatto così. Piuttosto, è costruito per massimizzare il ricavo di ricchezza e profitto, sia dagli esseri umani che dal mondo naturale, una realtà che ci ha portato a quella che potremmo definire la fase tecno-necro del capitalismo. In questa realtà fatta di potere e ricchezza iper-concentrati, l’intelligenza artificiale, lungi dall’essere all’altezza di tutte quelle allucinazioni utopiche, è molto più probabile che diventi un temibile strumento di ulteriore espropriazione e razzia.
Approfondirò il perché di questa situazione. Ma prima è utile riflettere sul perché e a chi siano utili le allucinazioni utopiche sull’IA. Che operazione stanno facendo nella cultura queste storie benevole, nel momento in cui ci imbattiamo in questi nuovi e strani strumenti? Ecco un’ipotesi: si tratta di storie di copertura potenti e allettanti, per quello che potrebbe rivelarsi il furto più grande e ambizioso della storia umana. Perché stiamo assistendo all’appropriazione unilaterale della totalità della conoscenza umana che esiste in forma digitale, raggiungibile da chiunque, da parte delle aziende più ricche della storia (Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon…) per blindarla all’interno di prodotti proprietari, molti dei quali prenderanno di mira direttamente gli esseri umani, che con il lavoro di una vita hanno istruito le macchine senza dare il loro permesso né consenso.
Questo non dovrebbe essere legale. Nel caso di materiale protetto da copyrigh (compreso questo giornale) che, come sappiamo, ha addestrato i modelli, sono state intentate diverse cause per sostenere che si tratta di una pratica chiaramente illegale. Perché, ad esempio, una società a scopo di lucro dovrebbe essere autorizzata a inserire i dipinti, i disegni e le fotografie di artisti viventi in un programma come Stable Diffusion o Dall-E 2, che può generare copie delle opere di quegli stessi artisti, con profitti vanno a tutti tranne che agli autori?
La pittrice e illustratrice Molly Crabapple sta contribuendo a guidare un movimento di artisti che sfidano questo furto. «Le IA generatrive nel campo dell’arte sono addestrate su enormi insiemi di dati, contenenti milioni e milioni di immagini protette da copyright, raccolte senza che i loro creatori ne siano a conoscenza, tanto meno con un compenso o un consenso. Si tratta di fatto del più grande furto d’arte della storia. Perpetrato da aziende dall’apparenza rispettabile, sostenute dal capitale di rischio della Silicon Valley. È una rapina alla luce del sole.», si legge in una nuova lettera aperta di cui lei è una delle autrici.
Il trucco, naturalmente, è che la Silicon Valley è solita chiamare il furto “disruption” [crollo del sistema], e troppo spesso la fa franca. Conosciamo questa mossa: avanzare in un territorio non ancora regolamentato; sostenere che le vecchie regole non si applicano alla nuova tecnologia; urlare che la regolamentazione aiuterà solo la Cina – il tutto mentre hai il tuo solido tornaconto. Quando tutti noi saremo oltre la novità di questi nuovi giocattoli e inizieremo a fare un bilancio dei danni sociali, politici ed economici, la tecnologia sarà già così onnipresente che i tribunali e i politici non potranno che tirarsi indietro. Lo abbiamo visto con la digitalizzazione di libri e opere d’arte di Google. Con la colonizzazione dello spazio di Musk. Con l’assalto di Uber all’attività dei taxi. Con l’attacco di Airbnb al mercato degli affitti. Con la promiscuità di Facebook con i nostri dati. Non chiedete il permesso, dicono i distruttori, chiedete scusa (e oliate le domande con generosi contributi agli ingranaggi delle campagne elettorali).
In The Age of Surveillance Capitalism (“Il capitalismo della sorveglianza”), Shoshana Zuboff descrive minuziosamente il modo in cui Google ha aggirato le norme sulla privacy per fare le mappe di Street View, inviando le sue auto dotate di telecamere a fotografare le vie e gli esterni delle nostre case. Quando sono iniziate le cause in difesa dei diritti alla privacy, Street View era già così onnipresente sui nostri dispositivi (e così bella, e così comoda…) che pochi tribunali sono stati disposti a intervenire, tranne in Germania.
Ora la stessa cosa che è accaduta all’esterno delle nostre case sta accadendo alle nostre parole, alle nostre immagini, alle nostre canzoni, alle nostre intere vite digitali. Oggi tutti vengono sequestrati e utilizzati per addestrare le macchine a simulare il pensiero e la creatività. Queste aziende sanno di essere impegnate in un furto, o perlomeno sanno che è possibile dimostrarlo. Sperano solo che il vecchio copione funzioni ancora una volta, cioè che la portata del furto sia già così grande e che si stia svolgendo con tale rapidità da indurre tribunali e politici ad alzare le mani di fronte alla presunta inevitabilità di tutto questo.
È anche per questo che le allucinazioni su tutte le cose meravigliose che farà l’IA per l’umanità sono così importanti. Perché le loro nobili affermazioni travestono da dono questo furto di massa, e intanto aiutano a razionalizzare gli innegabili pericoli dell’IA.
Ormai la maggior parte di noi ha sentito parlare del sondaggio che ha chiesto a ricercatori e sviluppatori di IA di stimare la probabilità che i sistemi avanzati di IA causino «l’estinzione umana o una grave e permanente riduzione della specie umana». In modo agghiacciante, la risposta media è stata che c’era una probabilità del 10%.
Come si fa a razionalizzare il fatto che si vada a lavorare per realizzare strumenti che comportano tali rischi per l’esistenza? Spesso, la ragione addotta è che questi sistemi presentano anche enormi vantaggi potenziali, solo che questi vantaggi sono, per la maggior parte, allucinazioni. Analizziamo alcuni di dei vantaggi più bizzarri.
Allucinazione n. 1: l’IA risolverà la crisi climatica
Quasi sempre in cima agli elenchi dei vantaggi dell’IA c’è l’affermazione che risolverà in qualche modo la crisi climatica. Lo abbiamo sentito dire da tutti, dal World Economic Forum al Council on Foreign Relations, fino al Boston Consulting Group, che spiega che l’IA «può essere utilizzata per supportare tutte le parti interessate ad adottare un approccio più informato e guidato dai dati per combattere le emissioni di carbonio e costruire una società più verde. Può anche essere impiegata per riequilibrare gli sforzi globali per il clima verso le regioni più a rischio». L’ex CEO di Google, Eric Schmidt, ha riassunto il caso quando ha dichiarato all’Atlantic che vale la pena di correre i rischi dell’IA, perché «se si pensa ai problemi più grandi del mondo, sono tutti molto difficili: il cambiamento climatico, le organizzazioni umane e così via. Quindi, voglio che le persone siano sempre più intelligenti».
Secondo questa logica, l’incapacità di “risolvere” grandi problemi come il cambiamento climatico è dovuta a un deficit di intelligenza. Non importa che persone intelligenti, con tanto di dottorati e premi Nobel, abbiano detto ai nostri governi per decenni che cosa si deve fare per uscire da questo pasticcio: ridurre le emissioni, non estrarre combustibili fossili, affrontare il sovraconsumo dei ricchi e il sottoconsumo dei poveri perché nessuna fonte di energia è esente da costi ecologici.
Questo consiglio molto intelligente è stato ignorato non per un un problema di comprensione, o perché in qualche modo abbiamo bisogno di macchine che pensino per noi. È perché fare ciò che la crisi climatica ci richiede significherebbe bloccare trilioni di dollari di risorse di combustibili fossili e sfidare il modello di crescita basato sul consumo, che è alla base delle nostre economie interconnesse. La crisi climatica non è, infatti, un mistero o un enigma che non abbiamo ancora risolto a causa di dati non sufficientemente robusti. Sappiamo cosa sarebbe necessario, ma non è una soluzione rapida: è un cambio di paradigma. Aspettare che le macchine sfornino una risposta più appetibile e/o redditizia non è una cura per questa crisi, ma un ulteriore sintomo.
Elimina le allucinazioni, e ti sembrerà più probabile che l’IA è introdotta sul mercato in modi che aggravano attivamente la crisi climatica. In primo luogo, i server giganti che rendono possibile la produzione istantanea di saggi e opere d’arte da parte dei chatbot sono una fonte enorme e crescente di emissioni di carbonio. In secondo luogo, dal momento che aziende come Coca-Cola iniziano a fare ingenti investimenti per utilizzare l’intelligenza artificiale generativa per vendere più prodotti, sta diventando fin troppo chiaro che questa nuova tecnologia sarà utilizzata nello stesso modo in cui è stata utilizzata l’ultima generazione di strumenti digitali: ciò che inizia con promesse altisonanti circa la diffusione della libertà e della democrazia finisce per spedirci pubblicità mirate, per indurci a comprare sempre più cose inutili, che producono emissioni di carbonio.
C’è poi un terzo fattore, un po’ più difficile da individuare. Più i nostri canali mediatici vengono inondati da deep-fake (notizie profondamente false) e cloni di vario genere, più abbiamo la sensazione di sprofondare nelle sabbie mobili dell’informazione. Geoffrey Hinton, spesso definito “il padrino dell’IA” perché la rete neurale che ha sviluppato più di dieci anni fa forma gli elementi costitutivi degli attuali modelli linguistici di grandi dimensioni, lo sa bene. Ha appena lasciato un ruolo dirigenziale in Google per poter parlare liberamente dei rischi della tecnologia che ha contribuito a creare, tra cui, come ha dichiarato al New York Times, il rischio che le persone «non siano più in grado di sapere cosa è vero».
Questo è molto importante in relazione all’affermazione secondo cui l’IA aiuterà a combattere la crisi climatica. Perché quando diffidiamo di tutto ciò che leggiamo e vediamo i nostri media come sempre più inquietanti, ci ritroviamo ancora meno attrezzati per risolvere i pressanti problemi collettivi. La crisi di fiducia è precedente a ChatGPT, ovviamente, ma è indubbio che la proliferazione di deep-fake sarà accompagnata da un aumento esponenziale delle culture cospirative già ora fiorenti. Che differenza farà, quindi, se l’intelligenza artificiale si inventerà delle scoperte tecnologiche e scientifiche? Se il tessuto della realtà che condividiamo si sta disfacendo nelle nostre mani, ci troveremo incapaci di rispondere con coerenza.
Allucinazione n. 2: l’IA ci governerà con saggezza
Questa allucinazione evoca un futuro prossimo in cui i politici e i burocrati, attingendo alla vasta intelligenza aggregata dei sistemi di IA, saranno in grado di «vedere i modelli di bisogno e sviluppare programmi basati sull’evidenza» che produrranno maggiori benefici per i loro elettori. Questa affermazione proviene da un documento pubblicato dalla fondazione del Boston Consulting Group, ma trova eco in molti think-tank e società di consulenza manageriale. Ed è significativo che proprio queste società – quelle assunte da governi e aziende per individuare i risparmi sui costi, spesso licenziando un gran numero di lavoratori – siano state le più veloci a salire sul carro dell’IA. PwC (ex PricewaterhouseCoopers) ha appena annunciato un investimento di un miliardo di dollari, mentre Bain & Company e Deloitte sarebbero entusiaste di utilizzare questi strumenti per rendere i loro clienti più “efficienti”.
Come per le affermazioni sul clima, è necessario porsi un interrogativo: il motivo per cui i politici impongono politiche crudeli e inefficaci è che soffrono per mancanza di evidenze? Sarebbe un’incapacità di “vedere gli schemi”, come suggerisce il documento del BCG? Davvero non comprendono i costi umani quando tolgono risorse all’assistenza sanitaria pubblica in mezzo alle pandemie, o quando non investono in edilizia pubblica viste le tende che riempiono i nostri parchi urbani, o quando approvano nuove infrastrutture per i combustibili fossili mentre le temperature salgono? Hanno bisogno che l’intelligenza artificiale li renda “più intelligenti”, per usare il termine di Schmidt, o sono abbastanza intelligenti da sapere chi finanzierà la loro prossima campagna elettorale e che, se si allontanano dalle sue aspettative, finanzierà i loro rivali?
Sarebbe molto bello se l’intelligenza artificiale fosse davvero in grado di recidere il legame tra il denaro delle aziende e la politica sconsiderata, ma questo legame ha completamente a che fare con il motivo per cui aziende come Google e Microsoft sono state autorizzate a rilasciare i loro chatbot al pubblico, nonostante la valanga di avvertimenti e i rischi noti. Schmidt e altri hanno condotto per anni una campagna di lobbying per dire a entrambi i partiti di Washington che se non fossero stati liberi di andare avanti con l’IA generativa, senza essere intralciati da una seria regolamentazione, le potenze occidentali non sarebbero state al passo con la Cina. L’anno scorso, le principali aziende tecnologiche hanno speso la cifra record di 70 milioni di dollari per fare pressione su Washington – più del settore petrolifero e del gas – e questa somma, osserva Bloomberg News, si aggiunge ai milioni spesi «per la loro vasta gamma di gruppi commerciali, organizzazioni non profit e think-tank».
Eppure, nonostante la conoscenza di come il denaro plasmi la politica nelle nostre capitali nazionali, sembra tutto dimenticato quando si ascolta Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI (produttrice di ChatGPT), parlare degli scenari migliori per i suoi prodotti. Sembra che lui abbia l’allucinazione di un mondo completamente diverso dal nostro, un mondo in cui i politici e l’industria prendono le decisioni migliori basate sui dati e non metterebbero mai a repentaglio vite umane per profitto e vantaggio geopolitico. Il che ci porta a un’altra allucinazione.
Allucinazione n. 3: fidarsi che i giganti tecnologici non distruggano il mondo
Alla domanda se è preoccupato per la frenetica corsa all’oro che ChatGPT ha già scatenato, Altman ha risposto che lo è, ma ha aggiunto fiduciosamente: «Speriamo che tutto si risolva». Dei suoi colleghi amministratori delegati del settore tecnologico – quelli che competono per far emergere i loro chatbot rivali – ha detto: «Penso che gli angeli migliori vinceranno».
Angeli migliori? A Google? Sono abbastanza certa che l’azienda abbia licenziato la maggior parte di loro perché pubblicavano articoli critici sull’IA o denunciavano il razzismo e le molestie sessuali sul posto di lavoro. Altri “angeli migliori” si sono dimessi allarmati, da ultimo Hinton. Questo perché, contrariamente alle allucinazioni delle persone che traggono maggior profitto dall’IA, Google non prende decisioni in base a ciò che è meglio per il mondo, ma in base a ciò che è meglio per gli azionisti di Alphabet, che non vogliono perdersi l’ultima bolla, non quando Microsoft, Meta e Apple sono già tutti dentro.
Allucinazione n. 4: l’intelligenza artificiale ci libererà dal lavoro
Se le benevole allucinazioni della Silicon Valley sembrano plausibili a molti, il motivo è semplice. L’IA generativa si trova attualmente in quella che potremmo definire la fase del finto socialismo. Questo fa parte di una procedura ormai familiare alla Silicon Valley. Per prima cosa, si crea un prodotto attraente (un motore di ricerca, uno strumento di mappatura, un social network, una piattaforma video, un servizio di ride sharing…); lo si mette a disposizione gratuitamente o quasi per alcuni anni, senza un modello di business percorribile («Giocate con i bot», ci dicono, «vedrete che cose divertenti potrete creare!»); si fanno un sacco di dichiarazioni altisonanti sul fatto che lo si sta facendo solo per creare una “piazza cittadina” o un “bene comune dell’informazione” o “per connettere le persone”, il tutto diffondendo la libertà e la democrazia (e non “per cattiveria”). Poi si sta a guardare come la gente si appassiona a questi strumenti gratuiti e i come i propri concorrenti dichiarano bancarotta. Una volta che il campo è libero, si introducono gli annunci mirati, la sorveglianza costante, i contratti con la polizia e i militari, la vendita di dati black-box e tariffe di abbonamento sempre più alte.
Molte vite e settori sono stati decimati da precedenti versioni di questo schema, dai tassisti ai mercati degli affitti ai giornali locali. Con la rivoluzione dell’IA, questo tipo di perdite potrebbe sembrare un errore di arrotondamento: insegnanti, programmatori, artisti visivi, giornalisti, traduttori, musicisti, operatori sanitari e molti altri si troveranno di fronte alla prospettiva di veder sostituito il proprio reddito da un codice difettoso.
Non preoccupatevi, gli appassionati di IA hanno le allucinazioni: sarà meraviglioso. A chi piace lavorare? L’IA generativa non sarà la fine del lavoro, ci dicono, ma solo del “lavoro noioso”, con i chatbot che si occuperanno di tutti i compiti ripetitivi che distruggono l’anima e gli umani che si limiteranno a supervisionarli. Altman, da parte sua, vede un futuro in cui il lavoro «può essere un concetto più ampio, non qualcosa che si deve fare per poter mangiare, ma qualcosa che si fa come espressione creativa e un modo per trovare appagamento e felicità».
Si tratta di una visione entusiasmante di una vita più bella e piacevole, condivisa da molti esponenti della sinistra (tra cui il genero di Karl Marx, Paul Lafargue, che aveva scritto un manifesto intitolato Il diritto all’ozio). Ma noi di sinistra sappiamo anche che se guadagnare denaro non deve più essere l’imperativo della vita, allora ci devono essere altri modi per soddisfare i nostri bisogni naturali di riparo e sostentamento. Un mondo senza lavori di merda significa che l’affitto deve essere gratuito, che l’assistenza sanitaria deve essere gratuita e che ogni persona deve avere diritti economici inalienabili. E allora improvvisamente non si parla più di IA, ma di socialismo.
Perché non viviamo nel mondo razionale e umanista ispirato allo Star Trek dell’allucinazione di Altman. Viviamo sotto il capitalismo e, in questo sistema, l’effetto dell’inondazione del mercato con tecnologie che possono plausibilmente svolgere i compiti di innumerevoli lavoratori non significa che queste persone siano improvvisamente libere di diventare filosofi e artisti. Significa che queste persone si ritroveranno a guardare l’abisso – e gli artisti veri e propri saranno tra i primi a cadere.
Questo è il messaggio della lettera aperta di Crabapple, che invita «gli artisti, gli editori, i giornalisti, i direttori e i leader dei sindacati del giornalismo a prendere un impegno per i valori umani contro l’uso di immagini generative-AI» e a «impegnarsi a sostenere l’arte editoriale fatta dalle persone, non dalle server farm». La lettera, ora firmata da centinaia di artisti, giornalisti e altri, afferma che tutti gli artisti, tranne quelli più elitari, trovano il loro lavoro «a rischio di estinzione». E secondo Hinton, il “padrino dell’IA”, non c’è motivo di credere che la minaccia non si diffonderà. I chatbot «tolgono il lavoro di fatica», ma «potrebbero togliere molto di più».
Crabapple e gli altri firmatari scrivono: «L’arte generativa dell’IA è vampirica, si nutre delle generazioni passate di opere d’arte mentre succhia la linfa vitale dagli artisti viventi». Ma ci sono modi per resistere: possiamo rifiutarci di usare questi prodotti e organizzarci per chiedere che anche i nostri datori di lavoro e i governi li rifiutino. Una lettera di importanti studiosi di etica dell’IA, tra cui Timnit Gebru, licenziata da Google nel 2020 per aver contestato la discriminazione sul posto di lavoro, illustra alcuni strumenti normativi che i governi possono introdurre immediatamente, tra cui la piena trasparenza su quali set di dati vengono utilizzati per addestrare i modelli. I firmatari scrivono: «Non solo dovrebbe essere sempre chiaro quando ci troviamo di fronte a media non-umani, ma le organizzazioni che costruiscono questi sistemi dovrebbero anche essere tenute a documentare e divulgare i dati di addestramento e le architetture dei modelli […] Dovremmo costruire macchine che lavorano per noi, invece di “adattare” la società per renderla leggibile e scrivibile dalle macchine».
Sebbene le aziende tecnologiche vorrebbero farci credere che sia già troppo tardi per ritirare questo prodotto di imitazione di massa che sostituisce l’uomo, ci sono precedenti legali e normativi molto rilevanti che possono essere applicati. Ad esempio, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha costretto Cambridge Analytica ed Everalbum, proprietaria di un’applicazione fotografica, a distruggere interi algoritmi che risultavano essere stati addestrati sulla base di dati e foto di provenienza illecita. Nei suoi primi giorni di vita, l’amministrazione Biden ha fatto molte affermazioni audaci sulla regolamentazione delle grandi tecnologie, compreso un giro di vite sul furto di dati personali per costruire algoritmi proprietari. Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, sarebbe il momento giusto per mantenere queste promesse e scongiurare la prossima serie di licenziamenti di massa prima che si verifichino.
Un mondo di deep fake, loop di mimetismo e peggioramento della disuguaglianza non è inevitabile. È un insieme di scelte politiche. Possiamo regolamentare l’attuale forma di chatbot vampirici e iniziare a costruire un mondo in cui le promesse più eccitanti dell’IA siano qualcosa di più che allucinazioni della Silicon Valley.
Perché abbiamo addestrato le macchine. Tutti noi. Ma non abbiamo mai dato il nostro consenso. Si sono nutrite dell’ingegno, dell’ispirazione e delle rivelazioni collettive dell’umanità (e insieme dei nostri tratti più venali). Questi modelli sono macchine chiuse e predatorie, che divorano e privatizzano le nostre vite individuali e le nostre eredità intellettuali e artistiche collettive. E il loro obiettivo non è mai stato quello di risolvere il cambiamento climatico o di rendere i nostri governi più responsabili o le nostre vite quotidiane più serene. È sempre stato quello di trarre profitto dall’immiserimento di massa che, nel capitalismo, è la conseguenza logica e lampante della sostituzione delle funzioni umane con i bot.
Tutto eccessivamente drammatico? Una resistenza soffocante e di testa rispetto a un’innovazione stimolante? Perché aspettarsi il peggio? Altman ci rassicura: «Nessuno vuole distruggere il mondo». Forse no. Ma come ci dimostrano ogni giorno la crisi climatica e il rischio di estinzione, in continuo peggioramento, un sacco di persone e istituzioni potenti sembrano ben consapevoli che stanno contribuendo a distruggere la stabilità dei sistemi di supporto vitale del mondo, pur di continuare a fare profitti record che credono proteggeranno loro e le loro famiglie dagli effetti peggiori. Altman, come molte creature della Silicon Valley, è lui stesso un prepper. Già nel 2016 si vantava: «Ho armi, oro, ioduro di potassio, antibiotici, batterie, acqua, maschere antigas dell’esercito israeliano e un grande pezzo di terra nel Big Sur dove posso volare».
Sono dell’idea che questa dichiarazione ci dica molto di più su ciò che Altman pensa realmente del futuro che sta contribuendo a scatenare rispetto a tutte le visioni fiorite che sceglie di condividere nelle interviste alla stampa.
Naomi Klein è editorialista e scrittrice del Guardian USA. È autrice dei bestseller No Logo e Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri, nonché docente di giustizia climatica e co-direttrice del Centro per la giustizia climatica presso la University of British Columbia.
(theguardian.com, 8 maggio 2023 – articolo originale)
Staffetta dell’umanità
Appello a uomini e donne, alla società civile e ai leader politici contrari all’invio di armi in Ucraina, per dar vita domenica 7 maggio 2023 a una Staffetta dell’umanità che parte da Aosta, Bolzano e Trieste in un percorso che attraversa tutte le regioni d’Italia arrivando a Lampedusa. Una persona per chilometro, con una torcia in mano, camminerà per un chilometro all’unisono con le altre, unendo il paese in un desiderio di pace e di speranza contro la folle corsa alle armi dei governi. Contro la subalternità agli Stati Uniti e per difendere gli interessi degli italiani e dell’Europa. Questo il link dell’appello https://michelesantoro.it/2023/04/appello-ai-cittadini-alla-societa-civile-e-ai-leader-politici/
Alla staffetta hanno partecipato anche Odifreddi, Revelli e il “vescovo comunista” Bettazzi.
.
di Melania Mazzucco
Nel gennaio del 1971, sulla rivista Art News, la storica dell’arte Linda Nochlin pubblicò un saggio dal titolo polemico: Perché non ci sono state grandi artiste? Benché l’autrice fosse una femminista, la domanda non era retorica, e nemmeno ironica, a sbeffeggiare la misoginia dominante nel pensiero occidentale. In effetti, fino al XX secolo, non si incontrano pittrici del valore di Giotto, Raffaello, Dürer, Caravaggio, Vermeer o van Gogh. Nochlin dimostrava che la risposta non stava in qualche carenza biologica, intellettuale o di talento. Bensì nelle condizioni materiali in cui le donne vissero e operarono. Il pamphlet, cui fece seguito nel 1976 la mostra Women Artists 1550 – 1950, curata dall’autrice con Ann Sutherland, ha dato l’abbrivio al dibattito sulla disparità di genere in arte e alla rivisitazione dell’arte creata dalle donne: ha stimolato le ricerche che hanno permesso via via la riscoperta di innumerevoli artiste cadute nell’oblio. Le «ignorate, scomparse, rintanate, morte o disperse […], ormai ignare di se stesse», come ha scritto Giorgio Manganelli, in occasione della mostra curata da Lea Vergine nel 1980, L’altra metà dell’avanguardia, che disseppelliva dall’anonimato le protagoniste dei movimenti artistici del XX secolo – da Bice Lazzari a Popova, Marevna, Udal’kova e Carol Rama – anche loro, come le antenate dei secoli precedenti trascurate o relegate a ruoli ancillari.
Tuttavia la questione era nota da più di quattrocento anni. Nel 1568, compilando per la seconda edizione delle Vite quella di suor Plautilla Nelli, monaca domenicana a Firenze e pittrice sua contemporanea, Giorgio Vasari aveva già posto con estrema lucidità la questione. Ammirava le opere della concittadina, ma – da collega e intenditore – non poteva non sottolinearne i limiti. Plautilla «avrebbe fatto cose meravigliose» – scrive – «SE come fanno gli uomini, avesse avuto commodo di studiare et attendere al disegno e ritrarre cose vive e naturali». Sapeva dunque il Vasari che Nelli NON poteva studiare, né conoscere il mondo e la natura, che NON poteva aggiornarsi né muoversi fuori dalle mura del convento in cui era rinchiusa, che NON poteva ideare pittura dalla vita e dal vero, ma doveva utilizzare materiali di repertorio altrui. Quel SE è il presupposto che ha influenzato la visione – e la valutazione – delle opere delle artiste fino a poco tempo fa.
Esiste un affascinante filone della storiografia, detta controfattuale, o storia alternativa. Per illuminare la casualità degli eventi, e destrutturarne i nessi, essa individua, nella storia, dei turning point, o dei punti di divergenza, e pone una domanda molto semplice: WHAT IF? Cosa sarebbe accaduto se suor Plautilla Nelli – o dopo di lei Elisabetta Sirani, Antonella De Rosa, Plautilla Bricci, Giulia Lama, solo per citare alcune italiane – avessero potuto studiare nella bottega di un grande maestro e non del loro (talvolta modesto) padre, se avessero potuto viaggiare per istruzione come qualunque altro pittore, soggiornare in qualche corte, competere sul mercato, ideare vaste composizioni e non quadretti di devozione privata? Se le loro opere fossero state pubbliche, visibili a coloro che poi scrivono le storie della pittura per tramandarle, se le loro invenzioni fossero state imitate, riprese, replicate? Se oggi i loro quadri fossero esposti nei maggiori musei del mondo, visitati da milioni di spettatori, riprodotti su cartoline, manifesti, pubblicità fino a diventare parte del nostro patrimonio collettivo? Ma non è stato così. Provate a chiudere gli occhi e a ricordare a mente l’opera di una pittrice. È improbabile che la memoria ve la proponga come i Girasoli, la Ragazza con l’orecchino di perla, una Madonna con bambino di Bellini, un nudo di Modigliani… La storia alternativa cambia il passato e lo fa deragliare su un binario diverso solo per ipotesi: non agisce sul presente. Non è quella la strada.
Per poter creare un nuovo canone della storia dell’arte, la cui necessità è denunciata dalla simultanea apparizione di volumi pubblicati in vari paesi dell’occidente, eterogenei per forma e struttura ma sintonici nel fine (fra essi includo anche il mio recente Self portrait. Il museo del mondo delle donne), oggi non possiamo limitarci a riscoprire qualche dimenticata, ridotta a nome di un elenco o a nota a piè di pagina, e a dedicarle una personale. Come pure sempre più spesso accade (solo all’inizio di questo 2023 si contano fra l’altro le mostre di Alice Neel, Faith Ringgold, Berthe Morisot, le espressioniste astratte). Non è più questione di risarcimento, come forse è stato sul finire del Novecento, ma di prospettiva. Dobbiamo trasformare quel SE ipotetico di Vasari in NONOSTANTE. Dobbiamo includere l’avversativa nel nostro sguardo. Soltanto così le esitazioni, i limiti anatomici e culturali, le imitazioni delle opere delle pittrici diventeranno una nuova e altra bellezza.
Allora avremo davvero la possibilità di considerare tutte le artiste per ciò che effettivamente furono – non solo figlie o sorelle d’arte, epigone obbligate di maniere e iconografie altrui; non solo ispiratrici, muse e amanti di geni e maestri acclamati, ma compagne di strada e talvolta -penso alle astrattiste come Rozanova, alle surrealiste, a Meret Oppenheim – perfino precorritrici. Allora forse supereremo il rischio romantico che tuttora ci limita: di far prevalere la biografia tragica, infelice o ribelle dell’artista sulla sua opera. Di innamorarci della vittima della storia e non del lavoro della sua mente e del suo pennello. Quanto il culto di Artemisia o Frida Kahlo devono al processo per stupro o all’incidente in tram e agli amori selvaggi e quanto al modo in cui la prima interpretò le eroine forti e la seconda la sua doppia cultura india e bianca?
Giorgio Vasari però ci dice soprattutto un’altra cosa. Che un uomo del Cinqucento era perfettamente consapevole del vero punto della questione: le donne avrebbero potuto creare come gli uomini, se ne avessero avuto le possibilità. Ciò su cui dobbiamo interrogarci è dunque il fatto che queste possibilità continuarono a essere loro negate, ben oltre il XVI secolo. Impedito l’accesso alle botteghe, e poi alle accademie e alle scuole; ostacolata la formazione; offuscata l’opera dal pregiudizio, e poi dal paternalismo. Questa resistenza è stata secolare, e in alcune parti del mondo è ancora fortissima. Essa testimonia la paura degli uomini detentori del potere, del sapere e del controllo sociale di perdere l’uno e gli altri. Non è questione di estetica, ma di politica. Scrivere il nuovo canone è inverare finalmente il cambiamento.
(Robinson – La Stampa, 6 maggio 2023)
A cura della redazione Cronaca
Tre ciotole, l’ultimo libro di Michela Murgia, esce il 16 maggio. Il primo racconto si apre con la diagnosi di un male incurabile. Ed è una vicenda autobiografica in modo “pedissequo”, spiega la stessa Murgia in un’intervista al Corriere della Sera. Perché l’autrice di Accabadora, la vincitrice del premio Mondello, la barricadera di Istruzioni per diventare fascisti e Stai zitta, la cronista impegnata di Il mondo deve sapere, la cattofemminista di Ave Mary. E la chiesa inventò la donna, God save the Queer. Catechismo femminista, ha un tumore al quarto stadio, uno stadio da cui “non si torna indietro”. Sta per morire, sottolinea. Le restano pochi mesi. E ha deciso di raccontarlo. Spiegando che «le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello». Racconta anche che «il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono. Me l’ha spiegato bene il medico che mi segue, un genio. Gli organismi monocellulari non hanno neoplasie; ma non scrivono romanzi, non imparano le lingue, non studiano il coreano. Il cancro è un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere. Non posso e non voglio fare guerra al mio corpo, a me stessa. Il tumore è uno dei prezzi che puoi pagare per essere speciale. Non lo chiamerei mai il maledetto, o l’alieno».
Nel libro Tre ciotole la protagonista di uno dei racconti rifugge la definizione di tumore come appunto di qualcosa di alieno, da combattere, «perché non mi riconosco nel registro bellico. Parole come lotta, guerra, trincea… Il cancro è una malattia molto gentile. Può crescere per anni senza farsene accorgere. In particolare sul rene, un organo che ha tanto spazio attorno». E in più «non mi riconosco nel registro bellico. Mi sto curando con un’immunoterapia a base di biofarmaci. Non attacca la malattia; stimola la risposta del sistema immunitario. L’obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti».
Murgia racconta anche della sua passione per il coreano e la Corea. Nata in un momento di estrema difficoltà e di depressione, seguito allo shit storm che le si era scaraventato addosso quando, all’inizio del lockdown, in una trasmissione televisiva, aveva criticato la retorica di guerra costruita intorno a quella malattia, «l’uso del registro lessicale militare e dei simboli bellici – medaglie, armi e divise – nella comunicazione della gestione dell’emergenza covid», la stessa che la infastidisce anche oggi rispetto alla malattia che le vive accanto. L’attacco fu violentissimo e nessuno la sostenne, alcuni ritenendo di avere troppo pochi follower rispetto a lei da non avere in fondo nessuna voce.
A tirarla fuori da quella situazione fu il video della star coreana Kim Tae-hyung dei BTS che si accascia sul red carpet: era l’aprile del 2021. Casca e un suo compagno di band per non lasciarlo solo si accascia insieme a lui, come lei stessa ricorda in un suo articolo: «In quei sette secondi di video i BTS hanno messo in atto una consapevolezza comportamentale di cui avrei avuto estremo bisogno nella mia vita: il fatto che nessuna persona possa rimettersi in piedi al tuo posto non le impedisce di inginocchiarsi al tuo fianco. Quel video mi dimostrava che davanti alla fragilità non esiste solo la risposta dei rapporti di forza, dove sei costretta a chiederti chi è più potente, chi lo è meno, chi può aiutare chi e chi non può farlo. Esisteva da qualche parte nel mondo anche la categoria della parità fragile, della capacità non innata di flettersi insieme allo stesso vento finché il vento non passa, durasse anche solo i pochi secondi di un calo di pressione davanti ai fotografi».
Michela Murgia racconta poi che si è preparata a quella che sarà: si sposa ma non «solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono». E si sposa con «un uomo, ma poteva essere una donna. Nel prenderci cura gli uni degli altri non abbiamo mai fatto questione di genere». Ha comprato una casa con dieci posti letto «dove stare tutti insieme» io e «la mia queer family» cioè «un nucleo familiare atipico, in cui le relazioni contano più dei ruoli».
Non ha paura della morte, Michela Murgia, anche se annuncia che la visiterà entro poco. «Spero solo di morire quando Giorgia Meloni non sarà più presidente del Consiglio», dice. «Perché il suo è un governo fascista. Non ho mai pensato di mostrarmi diversa da come sono per compiacere qualcuno. Anche a quelli che mi odiano credo di essere stata utile, per autodefinirsi. Me ne andrò piena di ricordi. Mi ritengo molto fortunata. Ho incontrato un sacco di persone meravigliose. Non è vero che il mondo è brutto; dipende da quale mondo ti fai. Quando avevo vent’anni ci chiedevamo se saremmo morti democristiani. Non importa se non avrò più molto tempo: l’importante per me ora è non morire fascista».
Proprio su questo aspetto ha risposto la premier Giorgia Meloni: «Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei. E io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più Presidente del Consiglio, come auspica, perché io punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo».
(la Repubblica, 6 maggio 2023)
di Franca Fortunato
Tina Anselmi come tante donne della sua generazione ha fatto della passione politica la ragione della sua vita, restando sempre fedele a sé stessa, alla ragazza che a diciassette anni nel 1944 scelse di entrare nella Resistenza, pronta come altre/i “a morire” battendosi “contro il nemico, a morire detestando la morte, a morire per la pace e la libertà”. È così che racconta la sua scelta nel libro Storia di una passione politica scritto con Anna Vinci e tornato da poco in libreria con la prefazione di Dacia Maraini (Chiarelettere 2023). Dal libro è stata tratta la fiction Tina Anselmi. Una vita per la democrazia, interpretata da Sarah Felberbaum, andata in onda il 25 Aprile su Rai1. Ragazzina di campagna, nata a Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927, conobbe l’antifascismo attraverso il padre, Ferruccio, socialista che “portava sempre con sé la tessera del partito firmata da Matteotti” e “schedato e controllato, quando c’erano manifestazioni, raduni, visite di gerarchi da Roma, lo prelevavano per portarlo nella farmacia dove lavorava e lo costringevano a bere l’olio di ricino”. Da lì il suo sentimento contro l’ingiustizia che l’accompagnerà per tutta la vita. Dalla madre, Norma, imparò ad essere contro la guerra. “Lei, la nonna e una mia zia dovettero andare profughe in Piemonte, per avere un lavoro, perché da noi la miseria era tanta. Erano state impiegate a cucire le ali dei piccoli aeroplani. La mamma aveva paura perché gli aeroplani portano la morte, quindi, partecipare, seppure indirettamente, a costruire quegli strumenti di guerra la faceva stare male. E il suo malessere, la sua paura io li ho vissuti, ne ho fatto un motivo per rifiutare la guerra”. Dalla nonna materna, Maria, imparò il coraggio, l’amore per la vita, la libertà di donna. È con gratitudine e riconoscenza che parla dei loro insegnamenti che l’hanno “messa in condizione di stare bene al mondo”, l’hanno aiutata “ad amare, stimare, avere fiducia nelle persone”. A quella prima scelta di adolescente ne seguirono altre e ogni volta scelse con coraggio da che parte stare, partendo sempre da sé, dal suo desiderio profondo di “esserci”, di “agire” per rendere il mondo migliore, prima di tutto per le donne. Vuole essere protagonista della ricostruzione del paese. Si laurea, entra nella Dc, nel sindacato per battersi con le operaie tessili, entra in Parlamento (1968) poi nel governo, ministra del Lavoro, prima, e della Salute, poi. A lei si deve la legge sulla parità salariale e di trattamento al lavoro, ma anche il Servizio Sanitario Nazionale. Quando la presidente della Camera Nilde Iotti le affida la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, lei sceglie di stare dalla parte della verità. Sarà ostacolata da molti e isolata dal suo stesso partito. A distanza di anni si rammaricherà che quella inchiesta non si sia voluta portare fino in fondo in quanto “faceva paura a molti”. Lega i suoi ricordi “più belli alla risoluzione dei problemi, alle risposte che” ha “saputo dare ai bisogni della gente”, il che fa capire il senso per lei della politica e del potere. Una donna coraggiosa, battagliera, autorevole, che a ragione dopo Tangentopoli ha potuto dire: “Personalmente io mi sento con le mani pulite”. Attraverso il racconto della sua vita ci si immerge nella storia del nostro Paese dal 1944 al 1992, quando lascia il Parlamento. Un racconto che si chiude con un dolce ricordo della nonna: “La ventata di leggerezza che nell’infanzia ha tante volte spazzato via la malinconia mi accompagnerà fino alla fine, e avrà per me l’odore del cocomero e del panino con le ulivette di nonna Maria”. È morta il 1° novembre 2016.
(Il Quotidiano del Sud, 6 maggio 2023)
di Enciclopedia delle donne
Care e cari,
il direttivo della Società per l’enciclopedia delle donne aps vi informa che ha deciso di partecipare alla rete mai più lager – NO ai CPR che da anni lavora sul monitoraggio delle condizioni dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio e ne chiede la chiusura.
Luoghi ai confini del diritto, impermeabili al mondo esterno, in cui si moltiplicano episodi di autolesioinismo da parte dei detenuti per uscire dalla condizione di isolamento in cui vivono; luoghi della cosiddetta “detenzione amministrativa” che non sono compatibili con la nostra costituzione né con alcuna sedicente democrazia.
Il nostro contributo sarà soprattutto di sensibilizzazione e partecipazione alle iniziative che intendono mobilitare tutte e tutti le cittadine e i cittadini per chiedere la chiusura di questi centri, e opporsi alla apertura di nuovi, prevista dal decreto Cutro appena approvato.
A Milano, Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo (GO), Macomer (NU), Palazzo San Gervasio (PZ), Roma, Torino, Trapani esistono questi luoghi di detenzione amministrativa, appaltati a società private, in cui vigono condizioni vergognose che ledono la dignità dei reclusi e delle recluse, e che esprimono solo una volontà punitiva nei confronti di persone migranti (ma anche di persone rom nate e cresciute in Italia) che non hanno commesso alcun delitto.
Per chi volesse restare informato suggeriamo di iscriversi alla mail noaicpr@gmail.com o di visitare la pagina facebook NOaicpr.
Aggiungiamo alcuni link che potranno facilmente illustrare l’emergenza che questi centri costituiscono, reclamando una presenza civile non più procrastinabile.
a) il report Delle pene senza delitti, stilato in seguito all’accesso del senatore De Falco al CPR di via Corelli nel giugno 2021 (scarica il pdf).
b) l’Inchiesta Rinchiusi e sedati di “Altreconomia” dove si analizzano le condizioni e la questione della sedazione obbligata come forma di contenimento del disagio che la detenzione induce.
https://altreconomia.it/rinchiusi-e-sedati-labuso-quotidiano-di-psicofarmaci-nei-cpr-italiani/;
c) il link all’articolo Da hospes a captivus: le basi psicopatogene della criminalizzazione delle persone migranti e della detenzione amministrativa a cura di #No ai CPR uscito su medicinademocratica:
https://www.medicinademocratica.org/wp/wp-content/uploads/2023/05/PAG-23-33-NoCPRSalute.pdf.
Un caro saluto, sperando che ciascuna e ciascuno di voi vorrà far sua questa causa.
Rossana, Margherita, Verena
(da redazione@enciclopediadelledonne.it – newsletter del 5 maggio 2023 – http://www.enciclopediadelledonne.it/)
di Marina Terragni
Alla bambina lasciata dalla madre nella Culla per la Vita a Bergamo – una volta si chiamava Ruota – è stato dato il nome di Noemi. Noemi avrà presto una famiglia e una casa, per lei ci si augura “tutto il bene e la felicità del mondo”, come se l’è augurato sua madre in un biglietto toccante che in poche righe riesce a raccontare una vita: «Nata stamattina 3/5/2023, a casa. Solo io e lei come in questi 9 mesi. Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre (dalla mamma). Vi affido un pezzo importante della mia vita che sicuramente non dimenticherò mai».
Le culle per la vita sono un presidio importante ed è bene che ne sia data pubblicità. Così come è bene che si sappia che ogni donna può partorire in ospedale in anonimato – ovvero senza riconoscere il neonato/a che verrà posto in stato di adottabilità – evitando i rischi di un parto domestico e spesso in solitudine com’è stato per la madre di Noemi.
Ma almeno in alcuni casi, probabilmente in questo caso, partiamo dal testo del suo biglietto, forse la donna – che si è voluta autonominare come “mamma”, ancorché tra parentesi, dicendo “io e lei” e parlando di “un pezzo importante della mia vita” – non avrebbe voluto separarsi dalla creatura. Forse quel “non posso” avrebbe potuto diventare un “posso” e quel “mamma” uscire dalla parentesi se non fosse mancato l’aiuto necessario. In quel biglietto si legge un desiderio destinato a restare inappagato.
Non sempre è così. Forse solo in una minoranza dei casi è così. Ma capita, come in questo caso, che il desiderio non manchi e che siano le circostanze a renderlo impraticabile.
E allora ai due presidi – il parto in anonimato, le culle per la vita – forse se ne dovrebbe aggiungere un terzo, un luogo in cui le madri in difficoltà che lo desiderano e non vorrebbero separarsi dai propri figli possano incontrare l’aiuto necessario: un sostegno economico continuativo, un lavoro quando manca, qualcuna/o, un/una single o una famiglia, che si impegni ad affiancare la madre nell’impegno e nella gioia di crescere la creatura. Le soluzioni possono essere variamente declinate, ogni storia è diversa.
Forse alcuni luoghi del genere esistono già, in parte i Centri Aiuto alla Vita – come il CAV Mangiagalli di Milano fondato da Paola Bonzi – assolvono questa funzione. Ma occorrerebbe de-ospedalizzarli, istituzionalizzarli e “laicizzarli”, rendendoli luoghi di incontro e di relazione.
Si può fare?
(FeministPost, 5 maggio 2023)
di Donatella Di Cesare
Un incontro fra 600 aziende italiane e 150 ucraine in vista di una fantomatica “ricostruzione” dell’Ucraina, mentre di giorno in giorno si moltiplicano i bombardamenti e i raid, aumentano le stragi e i morti. È difficile immaginare qualcosa di più subdolo e ipocrita. L’unico risultato della politica meloniana di fronte alla catastrofe della guerra non è che la messa in scena di uno sciacallaggio cinico e ripugnante. Continuino pure le carneficine, le distruzioni e le rovine – noi siamo qui che ci freghiamo le mani, pronti a investire in una “ricostruzione” su quel che resterà di edifici e persone. Intanto eleviamo inni patriottici alla libertà, o meglio, alla “nostalgia della libertà”, che gli alleati europei, da Macron a Scholz, con i loro sbandamenti e le loro indecisioni, sembrano aver dimenticato. Barra dritta, dunque, verso la “vittoria”, in attesa ovviamente del “dividendo della libertà”, dei profitti e degli utili, ammantati persino da una “scelta etica”: quella di una guerra da far combattere ad altri, per delega e per procura. D’altronde Meloni – si sa – viene dal fior fiore della tradizione democratica. Chi meglio di lei, e del suo governo postfascista, potrebbe rappresentare i valori europei? Chi meglio, insieme al premier polacco Morawiecki, potrebbe capeggiare la nuova Europa belligerante, il vecchio continente ancora una volta in armi? La partita sarebbe, com’è noto, democrazie contro autocrazie.
Questo scenario parrebbe semplicemente grottesco, se non avesse le conseguenze tragiche che sono già sotto gli occhi di tutti e che si moltiplicheranno se questo conflitto continuerà a essere avallato e supportato. L’Italia, tra i paesi europei più colpiti, e più coinvolti, sembra un caso emblematico. Il draghismo liberista e atlantista ha fatto la sua parte imprimendo sin dall’inizio della guerra una violenta sterzata. Meloni si è collocata nel solco di quel fondamentalismo atlantista. Niente di meglio per far digerire, nel contesto internazionale e in quello interno, il suo indigeribile postfascismo. Così un paese a maggioranza pacifista, che da subito ha espresso – come poteva – la propria opposizione all’invio di armi, è stato tradito. Avrebbe potuto svolgere un decisivo ruolo diplomatico, in consonanza con la propria storia, la propria geografia, la propria vocazione, mentre è costretto al ruolo opposto, nel fronte anti-europeo di America e Inghilterra, con l’appoggio delle forze più oscure e retrive, tra polacchi e baltici. Eppure l’Italia ha una Costituzione che nell’articolo 11 la dovrebbe preservare da ogni guerra e non permetterebbe in nessun modo l’invio di armi a Paesi non alleati, cioè una cobelligeranza a tutti gli effetti. Quell’articolo è stato calpestato, insieme con la Costituzione. Non la si venga a sbandierare nei discorsi pubblici, inneggiando a una immaginaria “identità italiana” fondata sulla guerra. Qualche incauta giornalista – non mancano davvero quelli proni alla peggiore propaganda militarista – ha sostenuto di recente che sarebbero “marginali” coloro che si prodigano per la pace o che la auspicano. Si sbaglia. È la maggioranza del Paese, che da tempo non riesce a farsi sentire. Questa maggioranza è favorevole all’invio di aiuti umanitari al popolo ucraino, ma è contraria alle armi. Non per indifferenza, bensì per ragioni politiche ed etiche. Quando manca una rappresentanza, e si viene consegnati all’impotenza, si può e si deve ricorrere a tutti quei mezzi che, mentre restituiscono ai cittadini la capacità di cambiare le cose, riattivano la democrazia. Perciò marceremo insieme per la pace nella “Staffetta dell’umanità” programmata il prossimo 7 maggio, un grande flash mob che, passando simbolicamente per la via Francigena, attraversa tutta l’Italia fino alle coste ioniche. E firmeremo per il referendum che, richiamando ai principi della Costituzione, chiede lo stop all’invio di armi.
Ogni giorno i pacifisti continuano a essere dileggiati. Inaccettabili sono i distinguo di coloro che, tacciandoli di irrealismo o utopismo, pretendono di navigare nell’ambiguità. È il caso purtroppo di Elly Schlein e di gran parte del Pd. Non si può parlare di pace mentre si avalla la guerra. Le parole hanno un valore e non possono essere deturpate e costrette a significare il contrario. Pace vuol dire pace. Ci chiediamo piuttosto che cosa voglia dire la “vittoria” preannunciata da Meloni e dal fronte atlantista. L’Ucraina, armata fino ai denti dall’Occidente, forte di nuovissimi mezzi militari, tra carrarmati e missili (ha ricevuto il 98% del materiale richiesto), si appresta alla controffensiva. Per riprendere il Donbass? La Crimea? Per una campagna di Russia? Per una guerra protratta? Qual è la strategia politica dell’Italia in questo scenario in cui l’arma nucleare – a detta degli Usa – può essere ormai un’arma preventiva? Pretendiamo democraticamente di saperlo.
(Il Fatto Quotidiano, 4 maggio 2023)
di Gianpaolo Contestabile
La salute mentale è oggi uno degli argomenti più discussi, spiegati, promossi, venduti e raccontati dai mezzi di comunicazione. Esistono psicologhe influencer che forniscono consigli dai loro canali e pazienti che condividono le loro testimonianze attraverso video, libri e opere d’arte. Il boom della salute mentale è sicuramente una buona notizia se pensiamo al superamento dello stigma e alla possibilità di informare un pubblico ampio rispetto alla gestione di alcuni disturbi avvolti da pregiudizi. La sovraesposizione mediatica, però, porta con sé anche il rischio di “psicologizzare” la società, cioè spiegare tutti i fenomeni sociali a partire da processi mentali e di voler cambiare il mondo partendo dalla nostra psiche individuale.
Nel suo articolo La meditazione che fa bene al capitale, Ronald Purser spiega come la tecnica buddista della Mindfulness sia diventata la ricetta perfetta da vendere sul mercato perché ci rende pacifici, cioè “vuole convincerci che le cause della nostra sofferenza vanno ricercate soprattutto dentro noi stessi, e non nel contesto politico ed economico che determina il modo in cui viviamo”. In questo caso si tratta di una forma mercificata della mindfulness, che di per sé può invece essere un utile strumento per gestire lo stress, l’ansia e modificare alcuni automatismi mentali che ci fanno soffrire. Il problema si presenta quando viene ridotta a una ricetta per il successo e si trasforma nella panacea di tutti mali, o addirittura come una filosofia rivoluzionaria necessaria per cambiare il mondo.
Qualcosa di simile potrebbe succedere con le terapie psicologiche quando si paventa la possibilità di risolvere qualsiasi problema semplicemente iniziando una terapia. Quando problemi strutturali come la povertà, la violenza domestica, lo sfruttamento, la disoccupazione o la distruzione dell’ecosistema diventano questioni personali, allora il campo d’azione si riduce alla depressione, al self empowerment, allo stress da lavoro correlato, all’abuso di sostanze o all’ansia. Il contesto sociale rimane sospeso, lasciando spazio esclusivamente all’interpretazione e gestione dei sintomi della paziente. Il processo clinico della terapia è un’ottima risorsa che aiuta le persone a conoscersi e curarsi ma non può essere la bacchetta magica per risolvere i conflitti che riguardano la collettività. Per esempio, una campagna di sensibilizzazione sul burnout lavorativo lanciata su Instagram propone come unica soluzione rivolgersi a un servizio di psicoterapia online a prezzi calmierati. Organizzarsi per migliorare le condizioni di salubrità, i ritmi di lavoro, la cultura aziendale, ridurre i turni e la competizione sfrenata rimangono invece rimossi dai possibili scenari d’azione.
Se la radice di tutti i malesseri diventa un problema dell’individuo e della sua mente allora la scienza psichiatrica è in grado di fornire spiegazioni sempre più raffinate sul funzionamento dei processi chimici del nostro cervello. Nella serie televisiva italiana Tutto chiede salvezza vengono raccontati i sette giorni di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), a cui viene sottoposto il giovane Daniele. Durante il primo giorno di internamento coatto il protagonista chiede spiegazioni alla dottoressa responsabile del reparto psichiatrico; questa gli risponde chiedendogli se sa cos’è la serotonina: “è un neurotrasmettitore” gli spiega, Daniele potrebbe avere un deficit e quindi “si tratta di ripristinare i valori. A volte le cose sono più semplici di quelle che sembrano”.
La sovraesposizione mediatica porta con sé il rischio di spiegare tutti i fenomeni sociali a partire da processi mentali.
Semplificare è rassicurante, e agire sulle correlazioni chimiche può, in alcuni casi specifici, aiutare ad alleviare sintomi gravi e offrire un po’ di serenità per iniziare un percorso di cura, ma ridurre la sofferenza psichica a uno scompenso di valori comporta una serie di rischi. Primo fra tutti, quello di trasformare le persone nelle loro diagnosi, o in deficit da aggiustare meccanicamente. Non stupisce, quindi, che una volta trasformati i pazienti in macchine da riparare, li si possa, come succede nella serie e nella realtà degli ospedali italiani, sedare, legare, far reprimere dalla polizia, togliere la libertà, incarcerare e lasciar morire. La normalità dell’assistenza psichiatrica in Italia, infatti, è la contenzione meccanica dei pazienti in reparti a porte chiuse: solo in 19 dei 318 Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura sul territorio italiano non si legano le persone.
Proprio l’Italia, paradossalmente, è conosciuta nel mondo per aver esportato un modello di cura esattamente contrario a questa tendenza, cioè contrario alla patologizzazione di chi soffre di disturbi mentali. Uno dei mantra del movimento che ha lottato per la chiusura dei manicomi nel nostro Paese negli anni Settanta era quello di “mettere tra parentesi la diagnosi” per far emergere la persona con la sua storia e il suo contesto socioeconomico. Si trattava, cioè, di fare il contrario del manicomio, nel quale ci si interfacciava con la malattia mentale e il soggetto e le sue condizioni di vita rimanevano nell’ombra . Nelle parole di Franca Ongaro Basaglia, una delle principali intellettuali che guidarono quel movimento, il modello medico egemonico crea “un’organizzazione dell’assistenza ospedaliera tutta incentrata sulla «riparazione», atta a confermare e a trattare la malattia come semplice fenomeno naturale, non potendo interferire nel processo storico-sociale che la produce”.
Alla medicina relegata “al suo compito di rimedio dei danni”, Ongaro oppone un approccio capace di andare alla radice dei problemi per prendersi cura delle sue cause. In questo senso, negli anni Settanta, i manicomi, da luoghi di tortura e annichilimento, si trasformarono nello scenario di innumerevoli assemblee ed eventi culturali dove pazienti, medici, operatrici, artisti e attiviste partecipavano alla vita politica dell’ospedale e riflettevano sulle cause del proprio malessere. Quando Daniele, il protagonista della serie, fugge sul tetto dell’ospedale con la sua amante, inizia a riflettere ad alta voce: “A me le malattie di tutti quelli che stanno qui dentro mi sembrano come un’unica malattia. Però non nostra. Del mondo.”
Curarsi durante la catastrofe
Nel libro Cattive acque. Contaminazione ambientale e comunità violate, Marialuisa Menegatto e Adriano Zamperini raccolgono una serie di studi incentrati su uno dei più gravi disastri ambientali della storia d’Europa: il rilascio di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle falde acquifere venete. Una catastrofe ecologica che interessa le province di Verona, Padova e Vicenza e una popolazione di quasi 800mila abitanti. Nel volume si presentano gli effetti psicologici dei disastri ambientali, tra cui lo stress acuto, l’ansia, la depressione, i pensieri intrusivi, l’insonnia, l’aumento del consumo di tabacco e alcool, ma anche problematiche sociali come l’aumento dei conflitti coniugali, la sfiducia verso le istituzioni e la corrosione del tessuto sociale. Tra le comunità danneggiate dai Pfas serpeggia un sentimento di impotenza, di rassegnazione e incertezza riguardo al futuro, al proprio lavoro, alle condizioni di salute dei propri cari e delle future generazioni.
Una volta trasformati i pazienti in macchine da riparare, li si può sedare, legare, far reprimere dalla polizia, incarcerare e lasciar morire.
Di fronte a questo scenario sconfortante le comunità possono però decidere di reagire partecipando nella gestione collettiva della catastrofe. In Veneto, le cosiddette “Mamme NoPfas” hanno deciso di attivarsi per sensibilizzare la popolazione, chiedere giustizia di fronte alle istituzioni e far sì che “la rabbia individuale diventi legittimazione di azioni collettive e [restituisca] una quota di potere”. Come viene ripetuto spesso nel testo, la cura al malessere generato dalla contaminazione va oltre il trattamento individuale dei sintomi psicologici: “nei casi di contaminazione ambientale il recupero psicologico coincide, sovente, con il recupero ambientale del sito inquinato”. Detto in altre parole, per curare i nostri disturbi mentali abbiamo bisogno di incontrarci, partecipare attivamente e curare l’ecosistema in cui viviamo per evitare che le industrie sversino i propri veleni nelle nostre fonti idriche.
Un’altra organizzazione di madri è diventata famosa in tutto il mondo per aver trasformato il loro trauma personale in una battaglia sociale: le Madres de Plaza de Mayo. Le mamme argentine dei quasi 30mila desaparecidos del regime militare degli anni Settanta si sono trasformate in un emblema internazionale dei diritti umani quando hanno sfidato il coprifuoco iniziando a incontrarsi ogni giovedì pomeriggio nella piazza pubblica di Buenos Aires. La dittatura dei militari e il successivo regime democratico hanno implementato una vera e propria guerra psicologica nei loro confronti chiamandole locas (pazze), responsabilizzandole di non aver educato a dovere i propri figli, invitandole al silenzio, ad accettare la morte dei cari scomparsi e a dimenticare il passato per favorire un clima di riconciliazione nazionale.
Questo tipo di politiche ha generato una serie di sintomi come la dissociazione di fronte al messaggio che nega la violenza, la autocolpevolizzazione e la fantasia di non aver fatto abbastanza per salvare il proprio figlio. Le psicoterapeute Diana Kordon e Lucilia Edelman hanno lavorato al fianco de Las Madres durante diversi anni per aiutarle a gestire il trauma. Il loro intervento ha preso la forma di gruppi liberi e autogestiti di riflessione sull’esperienza comune delle madri. Facilitando questi spazi di discussione hanno notato che il riconoscimento di una situazione comune ha permesso l’identificazione e l’empatia reciproca per evitare una chiusura narcisistica in sé stesse e ha favorito la catarsi del trauma attraverso la drammatizzazione dei conflitti con le istituzioni. Organizzarsi in gruppi per cercare i propri figli ha significato partecipare attivamente nella tragedia, mantenendo il rispetto verso di sé e tutelando la propria autostima, riducendo l’angoscia e il sentimento di colpa. Focalizzarsi sulla storicizzazione della violenza e non unicamente sulle storie personali genera una comprensione intellettuale della situazione che funziona come una difesa dell’Io, evita cioè che una catastrofe sociale diventi una catastrofe psichica. Un’affermazione comune tra le madri argentine è: “sono passata dal preoccuparmi per mio figlio a preoccuparmi per i figli di tutte”.
La partecipazione attiva ha permesso non solo di limitare le conseguenze psicologiche individuali ma ha fatto sì che Las Madres dessero vita, negli anni, a un’università popolare, una casa editrice, una rivista, un caffè letterario e molteplici altri progetti. Anche se come dice una delle fondatrici, Hebe de Bonafini, “la maggior parte delle madri non siano mai andate in terapia”, il loro attivismo le ha portate e impegnarsi in prima persona per la chiusura dei manicomi psichiatrici e organizzare il Congresso Internazionale per la Salute Mentale e Diritti Umani in cui si afferma che “la salute mentale nel quadro della lotta per la difesa dei diritti umani ci invita a recuperare le nuove soggettività del nostro tempo puntando sulle pratiche di gruppo, istituzionali e collettive che riscattano l’essere storico sociale”.
Focalizzarsi sulla storicizzazione della violenza genera una comprensione della situazione che funziona come una difesa dell’Io, evita cioè che una catastrofe sociale diventi una catastrofe psichica.
È interessante notare che le dottoresse Kordon e Edelman hanno riscontrato dei tratti simili nei gruppi spontanei che sono sorti durante la crisi finanziaria estrema del 2001 quando in Argentina i conti correnti vennero congelati, i bancomat limitati, l’inflazione schizzò alle stelle e i risparmi di una vita di molte persone persero improvvisamente di valore. Le assemblee che sorsero nei quartieri, i gruppi organizzati di disoccupati e le fabbriche autogestite dalle lavoratrici permisero di sostenere le persone durante la crisi svolgendo una “funzione proteica”, cioè fornendo un grembo per lo sviluppo di nuovi aspetti della psiche che ancora non si erano costituiti. Il gruppo offre quindi una protezione durante le crisi limitando l’angoscia, il panico, il sentimento di impotenza e permettendo di mantenere i vincoli sociali che sostengono la nostra salute mentale.
Ripartire dal mondo
Nella serie Maid, ispirata alle memorie di Stephanie Land, Donna delle pulizie: Lavoro duro, paga bassa, e la voglia di sopravvivere di una madre, Alex, la protagonista, fugge nel cuore della notte con la sua neonata per sottrarsi a una relazione violenta con il proprio partner. Durante i 10 episodi in cui si sviluppa la trama, Alex si trova a fare i conti con condizioni di lavoro umilianti, con la degradazione dei servizi sociali statunitensi, una famiglia disfunzionale e i propri traumi infantili che rischiano di farla ritornare tra le braccia del suo ex. Un occhio “puramente” clinico e decontestualizzato potrebbe interpretare le sue continue ricadute come il risultato dei suoi modelli di attaccamento infantili, come la ripetizione di un trauma non elaborato, oppure la mancanza di autostima o del senso di autoefficacia così come un sintomo di un disturbo da stress post-traumatico.
L’originalità della serie, però, sta nell’introdurre un elemento contestuale fondamentale. In sovraimpressione, infatti, durante gran parte delle scene appare il bilancio dell’economia di Alex. Man mano che la cifra si avvicina agli zero dollari il suo campo d’azione si limita sempre di più e, per dare da mangiare a sua figlia, diventa sempre più verosimile chiedere aiuto a un padre abusante, alla madre manipolatrice o all’ex compagno violento. Come scriveva Freud già nel 1921, nel suo Psicologia delle masse e analisi dell’Io, quando si studia attentamente una situazione concreta i limiti tra i processi intrapsichici e le dinamiche sociali si sfumano: “Nella vita dell’individuo l’altro rappresenta sempre un modello, un oggetto, un amico od un nemico, e sin dall’inizio la psicologia individuale è anche, sotto un certo aspetto, una psicologia sociale”.
Nonostante da più di un secolo la tradizione psicoanalitica abbia messo la questione sociale e collettiva al centro del dibattito, il discorso istituzionale sulla salute mentale continua a ricostruire una fantasia in cui esistono solo sintomi individuali. La crisi economica, i disastri ambientali, la violenza politica o quella domestica si trasformano in fantasmi che rimangono fuori dal setting terapeutico, del reparto psichiatrico e anche dal centro di meditazione. Inoltre, la diagnosi, che dovrebbe essere uno strumento utile al processo di cura, diventa invece l’obiettivo finale dello specialista, un’etichetta che dà senso alla nostra identità o una certificazione per non dover competere con gli alti livelli di rendimento richiesti dal mercato.
La diagnosi, da strumento utile al processo di cura, diventa invece l’obiettivo finale, un’etichetta che dà senso alla nostra identità o una certificazione per non dover competere con gli alti livelli di rendimento richiesti dal mercato.
Nell’ottobre del 2022, l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) si è riunita a Roma per presentare il report intitolato Trasformare la salute mentale per tutti. Nel testo, i ricercatori dell’OMS scrivono che: “una cattiva salute mentale interferisce con la capacità di lavorare, studiare e apprendere nuove competenze. Essa ostacola i risultati scolastici dei bambini e può avere un impatto sulle prospettive occupazionali future”. Il danno economico provocato dalla depressione e l’ansia viene calcolato nell’ordine di mille miliardi di dollari annui a causa dell’assenteismo lavorativo, il presenzialismo e il turnover del personale.
Se, come scrive l’Assemblea Antipsichiatrica in Il capitalismo nuoce gravemente alla salute, ci si concentra sui sintomi perché “occuparsi delle cause non genera profitto” allora la salute mentale si riduce a una tecnica per renderci più adatti, competitive e funzionali a un mondo ingiusto, inquinato e violento. Il rischio è che le politiche di salute mentale promosse dalle istituzioni mediche abbiamo un obiettivo pacificatorio più che curativo. Come recitava uno striscione esposto al presidio di protesta durante la riunione dell’OMS a Roma: “non vogliono che stiamo bene, vogliono che stiamo buonə”. Al nuovo mantra della salute mentale individualista vale la pena rispondere recuperando le pratiche che hanno portato l’Italia al centro del dibattito internazionale e tornare a trasformare la nostra salute mentale trasformando il mondo.
Allucinazione n. 2: l’IA fornirà un governo saggio
Questa allucinazione evoca un futuro prossimo in cui i politici e i burocrati, attingendo alla vasta intelligenza aggregata dei sistemi di IA, sono in grado di “vedere i modelli di bisogno e sviluppare programmi basati su prove” che hanno maggiori benefici per i loro elettori. Questa affermazione proviene da un documento pubblicato dalla fondazione del Boston Consulting Group, ma trova eco in molti thinktank e società di consulenza manageriale. Ed è significativo che proprio queste società – quelle assunte dai governi e da altre aziende per individuare i risparmi sui costi, spesso licenziando un gran numero di lavoratori – siano state le più veloci a salire sul carro dell’IA. PwC (ex PricewaterhouseCoopers) ha appena annunciato un investimento di 1 miliardo di dollari, mentre Bain & Company e Deloitte sarebbero entusiaste di utilizzare questi strumenti per rendere i loro clienti più “efficienti”.
Come per le affermazioni sul clima, è necessario chiedersi: il motivo per cui i politici impongono politiche crudeli e inefficaci è che soffrono di una mancanza di prove? Un’incapacità di “vedere gli schemi”, come suggerisce il documento del BCG? Non capiscono i costi umani dell’affamare l’assistenza sanitaria pubblica in mezzo alle pandemie, o del non investire in alloggi non di mercato quando le tende riempiono i nostri parchi urbani, o dell’approvare nuove infrastrutture per i combustibili fossili mentre le temperature salgono? Hanno bisogno che l’intelligenza artificiale li renda “più intelligenti”, per usare il termine di Schmidt, o sono abbastanza intelligenti da sapere chi finanzierà la loro prossima campagna elettorale o, se si allontanano, finanzieranno i loro rivali?
Sarebbe molto bello se l’intelligenza artificiale fosse davvero in grado di recidere il legame tra il denaro delle aziende e la politica sconsiderata, ma questo legame ha tutto a che fare con il motivo per cui aziende come Google e Microsoft sono state autorizzate a rilasciare i loro chatbot al pubblico nonostante la valanga di avvertimenti e i rischi noti. Schmidt e altri hanno condotto per anni una campagna di lobbying per dire a entrambi i partiti di Washington che se non saranno liberi di andare avanti con l’IA generativa, senza essere gravati da una seria regolamentazione, le potenze occidentali saranno lasciate nella polvere dalla Cina. L’anno scorso, le principali aziende tecnologiche hanno speso la cifra record di 70 milioni di dollari per fare pressione su Washington – più del settore petrolifero e del gas – e questa somma, osserva Bloomberg News, si aggiunge ai milioni spesi “per la loro vasta gamma di gruppi commerciali, organizzazioni non profit e thinktank”.
Eppure, nonostante la loro intima conoscenza di come il denaro plasmi la politica nelle nostre capitali nazionali, quando si ascolta Sam Altman, l’amministratore delegato di OpenAI – creatore di ChatGPT – parlare degli scenari migliori per i suoi prodotti, tutto questo sembra essere dimenticato. Sembra invece che abbia un’allucinazione di un mondo completamente diverso dal nostro, in cui i politici e l’industria prendono decisioni basate sui dati migliori e non metterebbero mai a repentaglio innumerevoli vite per profitto e vantaggio geopolitico. Il che ci porta a un’altra allucinazione.
(Il Tascabile, https://www.iltascabile.com/societa/oltre-la-salute-mentale/, 4 maggio 2023)
di Isia Osuchowska
.
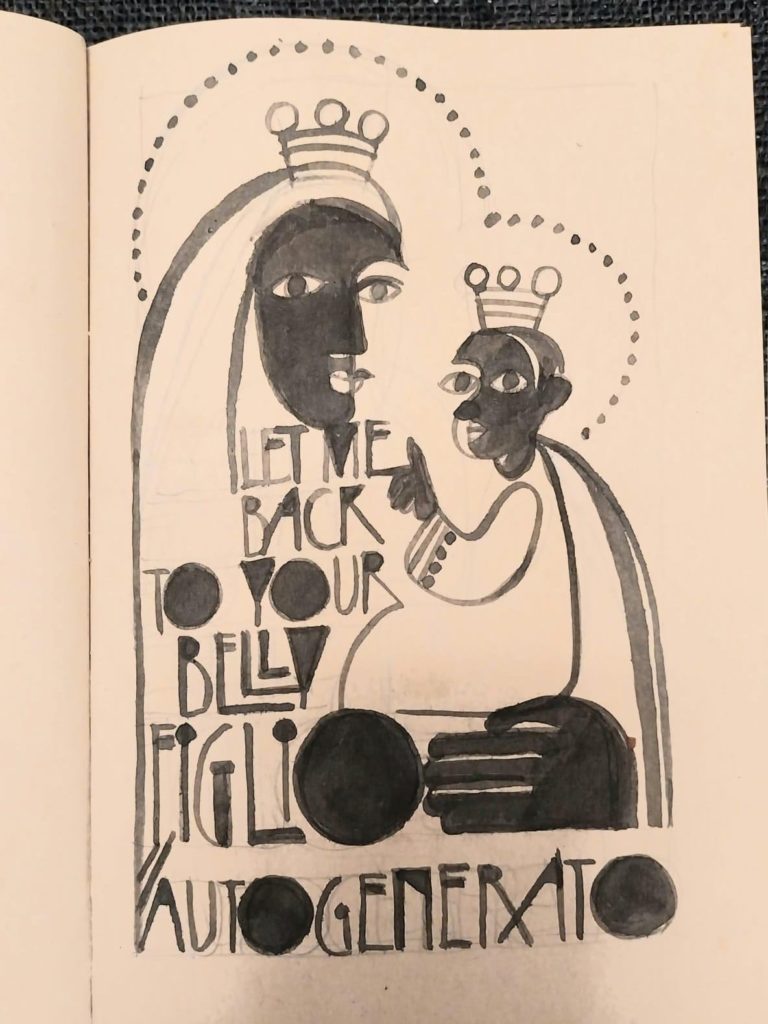
(www.libreriadelledonne.it, 3 maggio 2023)
di Antonella Nappi
Nel sito della Libreria delle donne si trovano due articoli scritti da me e Cifoletti, Un’altra resistenza, e uno firmato da molte altre donne, Vogliamo votare contro la guerra, fatto questo su esempio di un altro articolo ancora che era nello stesso sito: Possiamo votare contro la guerra?
Era l’anno passato, mettevamo in evidenza la diversità delle donne dai guerrafondai che conducono guerre di confine e per il governo dei Paesi, quelle per cui uomini vogliono vincere su altri uomini, e alcune donne sembrano appoggiarli per abitudine solidale. La guerra civile tra ucraina e russofoni era arrivata a vedere l’invasione del paese da parte della Russia e chi si riconosceva nel governo di Zelensky rispondeva con le armi.
Noi scriventi ricordavamo come le donne siano state sempre oppresse da governi maschili, da leggi maschili, da principi maschili e ben poco difese. Come le donne abbiano sempre cercato una via di sopravvivenza e fuga dalla violenza per poter essere più libere. Non è dunque la difesa dei governi né quella dei confini, tantomeno il desiderio di vincere su altri con le armi, il loro impegno, bensì quello di difendere la possibilità di vivere per sé stesse e per gli altri. Nella esperienza e nelle azioni, le donne e molti uomini preferiscono operare per conservare la salute, la natura, le città e le ricchezze relazionali conquistate. Preferiscono conservare i beni e i corpi, conservare la responsabilità nell’affrontare i conflitti e ragionarli.
La popolazione italiana si ribellò spontaneamente alla richiesta di Zelensky di entrare in guerra contro la Russia, e così quella europea, ma i nostri governi, subalterni a quello americano, presero ad appoggiare il paese attaccato, senza mantenere neutralità. Non fecero opera di mediazione ma al contrario iniziarono a bombardarci di ideologia guerresca, di ideologia schierata al vincere un nemico e ho l’impressione che abbiano reso mute e impotenti le persone che vorrebbero poter ragionare. Credo siano in parte riusciti a adeguare la popolazione all’aspettativa di qualsiasi possibile disfatta dell’economia e del proprio equilibrio personale, all’evenienza di una catastrofe che dipende dal conflitto russo-ucraino condotto dall’America e dall’Europa per colpire i confini russi e l’oriente tutto. Le nostre alleanze economiche proprio con quegli Stati sono state distrutte, così le nostre sicurezze. Le basi militari americane in Italia e negli Stati che circondano la Russia ci mettono in serio pericolo.
L’iniziativa della Staffetta per la pace, che pacifisti e pacifiste hanno organizzato, e di cui il sito della libreria delle donne dà conto, è un’occasione di alzare lo sguardo e vedere che ci siamo, noi che non vogliamo inviare armi ai paesi in guerra. Dobbiamo risvegliare la speranza che la popolazione possa difendere la vita e la relazionalità pacifica, discutere e contenere i conflitti tra stati e popoli, e non scivolare in una guerra mondiale che colpisce, proprio in Italia, e già sta portandoci anche contro la Cina, per Taiwan (già in quei pressi si esercita la portaerei italiana Cavour).
Spero questa manifestazione riesca bene e spero il piccolo sforzo di iscriversi e raggiungere i sentieri che verranno indicati, dove camminare per un chilometro soltanto, sia alla nostra portata.
La Staffetta per la pace, qui l’appello, è stata promossa da Michele Santoro e il suo percorso è stato realizzato dall’Associazione Compagnia dei Cammini. L’iniziativa, che unisce su strade pedonali tutte le regioni d’Italia da nord a sud, si svolgerà domenica 7 maggio per lanciare un messaggio di pace e un segnale alla politica. Per aderire è necessario scrivere alla mail: staffetta.pace@gmail.com.
Maggiori dettagli al seguente link.
(www.libreriadelledonne.it, 4 maggio 2023)
di Redazione
«Nel 1988, un anno dopo l’uscita di Aspirina, Isia telefonò o forse scrisse alla Libreria delle donne di Milano, editrice della rivista, per proporci i suoi fumetti. In un attimo apparve a casa mia, lavorava nella redazione grafica di Repubblica che era a due passi, mi disse che si era appena trasferita da Roma, si era separata, sua figlia Sara studiava medicina a Varsavia dove viveva con la nonna scienziata… e mi raccontò da allora il suo nomadismo dalla Polonia a mezzo mondo e le sue molte vite, come recita la lapide qui pubblicata, che ha disegnato a titolo di curriculum nel 2015, in occasione di una mostra di Aspirina. Da subito diventò una collaboratrice fissa della rivista su carta e online, fino a quando nel 2019 prese il nome di Erbacce. Spediva dall’indirizzo mail Foreverhappiness@… Che siano fumetti o illustrazioni, nelle sue mani ogni argomento, dalla fine del PCI a un caso di stupro, dalle proteste delle femministe polacche al militarismo, riesce a farci ridere», ricorda Pat.
Nata il 2 settembre 1941 a Cracovia, nella prima infanzia Isia si trasferisce con la famiglia a Varsavia e ventenne in Italia, dove si sposa e ha una figlia. Vive a Roma, a Milano, nella comunità buddhista di Pomaia, a New York, a Vilnius in Lituania, poi a torna a Varsavia. Fa viaggi con lunghi soggiorni in Tibet e Nepal, in Grecia, negli Stati Uniti e a Istanbul. In realtà tutti questi luoghi sono un continuum di andate e ritorni nella sua vita nomade. Muore nel sonno a Varsavia, nella casa che era stata di sua madre, all’alba di venerdì 28 aprile.
«Ha frequentato con me la scuola di iconografia buddhista tibetana e di tangke a Katmandu dal 1999 al 2004. A Volos in Grecia ha studiato con un maestro per disegnare le icone ortodosse e cristiane. A Istanbul con un maestro sufi ha imparato la calligrafia dei nomi di Allah», racconta l’amica buddhista Pierdionigia.
«Isia si sposta da una tradizione religiosa all’altra, prima monaca buddhista, poi dagli anni ’90 si avvicina al sufismo e diventa allieva di Gabriele Mandel Khan, maestro sufi in Italia. Amica di tutte le tradizioni religiose, buddhista, cristiana, islamica-sufi, alla fine si sentiva spiritualmente più islamica. La pittura dei 99 nomi di Allah era la sua pratica di meditazione: pittura sacra come veicolo, come ricerca di perfezione e spiritualità. Cercava una trasformazione spirituale non attraverso le dottrine, piuttosto utilizzava elementi meditativi che metteva nella pittura. Su una parete del nostro monastero a Graglia, abbiamo due opere di Isia, una tangka e un quadro con calligrafia che rappresenta la resurrezione di Cristo», così la descrive Lama Paljin Rinpoce del Centro Tibetano Mandala, di cui Isia era simpatizzante.
«Oriente. La IV Conferenza mondiale delle donne buddhiste nei suoi disegni, acquarelli e appunti fu un regalo di Isia, un Quaderno da noi pubblicato come dono alle abbonate 1996 di Via Dogana, la rivista della Libreria delle donne di Milano che già lei arricchiva con i suoi disegni. Oriente resta il prezioso e profondo resoconto artistico di uno storico scambio tra donne che cercano e sperimentano la libertà femminile nel buddhismo», sono le parole di Clara della Libreria.
«In camera mia ho una tangka dipinta da Isia e una sua icona. Un’altra icona dipinta su una tavola di legno si trova nel corridoio. Isia è presente nella nostra casa e ogni giorno le sue opere ci parlano», questo è il ricordo dell’amica Claudia.
Ricordi di Erbacce
Anna
Isia ci ha mandato un suo lavoro qualche giorno fa da pubblicare: 20 disegni di incroci stradali, piste ciclabili e semafori; da prospettive particolari e con colori vivaci. Ero stupita rispetto alla scelta del soggetto, ma neanche tanto, perché sapevo che per Isia tutto diventava un pretesto per disegnare, poteva trovare interessante anche la segnaletica stradale. Spesso quando sceglieva un soggetto sfornava 10 o 20 disegni sul tema: i nostri ritratti, i tavolini del bar visti dalla sua finestra, i paesaggi a lei cari, le lotte femministe… con i colori accesi delle matite, il segno vivo e quasi sempre accompagnati dalla sua calligrafia inconfondibile.
La sua era proprio fame di disegno, forse si nutriva più di carta e grafite che di acqua e pane.
Quando mi regalò il mio ritratto ero così contenta e le scrissi ringraziandola e lodando la sua vulcanica creatività, mi rispose così: «Per quanto riguarda la creatività ho alcune cose che faccio ogni giorno. Questo diventa “tanto”. La mia regola è che devo praticare. Happiness. Funziona».
Piera
Non è facile per me scegliere qual tra le illustrazioni di Isia per Erbacce o Aspirina siano le mie preferite, mi piacciono tutte. E sono tante. Non si tirava indietro se c’era l’urgenza di un’illustrazione che mancava ad un racconto, con generosità contribuiva alla nostra impresa. Per me Isia era una donna molto originale e spiritosa, mi piacevano i racconti della sua vita sempre in movimento che mi faceva Pat, i messaggi che mandava su WhatsApp in un italiano contaminato da altre lingue. Mi piaceva come coltivava e nutriva il suo talento artistico. Accanto alla conoscenza dell’arte legata alle varie filosofie/religioni spirituali che la spingevano a viaggiare e a vivere in molti paesi c’era un’arte più “profana” che a me piaceva moltissimo. Le illustrazioni per Erbacce sono un segno fortissimo del suo sguardo sulla realtà: il suo segno commentava ironicamente un testo o descriveva la situazione a lei più vicina dal bar sotto casa a Varsavia in lockdown.
Delle calligrafie ho capito che erano la sua ricerca artistica più raffinata e difficile: un foglio e un segno, scrittura, disegno, pensiero.
Manu
Giovedì 27 aprile, Pat mi ha portato il mio ritratto fatto da Isia nel 2020, «Era rimasto solo il tuo» mi dice. Stupendo, vibrante di colore nella busta in cui è stato spedito insieme ai ritratti delle altre Erbacce. Ho sempre percepito le illustrazioni di Isia come familiari, un tratto originario che in qualche maniera conosco da sempre.
Dopo qualche giorno la telefonata di Pat con la notizia e i racconti di tutte le cose che Isia aveva in progetto di fare, adesso, domani, tra un mese, sei mesi.
Ho chiuso la telefonata e sono andata a guardare quella busta, il suo nome dal lato del mittente, con la sua inconfondibile grafia.
Laura
Ho conosciuto Isia nel 2015 a una riunione di redazione di Aspirina, ero molto curiosa e grata: era lei che illustrava Le Sofistiche, i dialoghi tra me e Francesca Maffioli.
Ci siamo messe a parlare di sufismo. Era un tema che appassionava parecchio entrambe. Le altre ci prendevano un po’ in giro per l’argomento, ma io continuavo indefessa a farle domande: non mi era mai capitato di condividere questo genere di discorsi nell’ambito del femminismo. E non mi è mai più successo infatti. Senza interrompere il nostro dialogo uscimmo da casa di Livia e ci dirigemmo insieme verso la stazione, solo io e lei. Ho un’immagine di Isia, col sole e Milano Centrale dietro le sue spalle, mentre mi spiega l’evidenza del fatto che se bevi non puoi meditare o pregare e che quindi chi persegue la via del sufismo ragionevolmente deve seguire i pilastri dell’Islam, tra cui quello di astenersi dall’alcol.
Varie volte mi è tornata in mente, nella mia lotta tra il vizietto di bere e il desiderio di essere santa e sana, la sua eccentricità così sapiente.
La redazione di Erbacce nella sua newsletter del 2 maggio 2023, Forever Isia, presente sul pianeta Terra fino al 28 aprile 2023, ha dedicato al ricordo di Isia Osuchowska una raccolta di articoli, uno suo e tutti da lei illustrati, di cui vi riportiamo qui i link:
Isia Osuchowska della redazione di Erbacce
Una testarda leggerezza di Margherita Giacobino
Nalla cane femmina di Isia Osuchowska
Le sofistiche in analisi di Francesca Maffioli e Laura Marzi
(Erbacce.org, 2 maggio 2023)
di Marco Cesario
«Sono incredibilmente onorata di ricevere questo premio, penso che ogni generazione abbia il dovere di prendere il testimone e di passarlo a quelle successive». La Napoli multirazziale si stringe intorno a Stella Moris, moglie di Julian Assange, e alla sua vicenda giudiziaria e umana. Lo fa in un ricolmo di etnie provenienti da tutto il mondo, conferendo all’avvocata e difensora dei diritti umani il Premio Pimentel Fonseca, che ha aperto giovedì scorso l’ottava edizione di “Imbavagliati”, il Festival Internazionale di Giornalismo Civile, ideato e diretto da Désirée Klain, che dal 2015 dà voce a quei giornalisti sottoposti a censura e perseguitati nei loro paesi. Durante la stessa cerimonia è stato assegnato anche il Premio Pimentel Fonseca Honoris Causa alla preside Annalisa Savino e all’attivista Fatou Diako.
Un’onorificenza che viene conferita nella città prima in Italia a deliberare in consiglio comunale la cittadinanza onoraria del fondatore di Wikileaks, detenuto da quattro anni in Gran Bretagna. Nel corso dell’incontro la consegna alla Moris della significativa tessera del Sindacato unitario giornalisti della Campania e quindi della Federazione nazionale della stampa (Fnsi) da parte di Claudio Silvestri, consegretario generale aggiunto, con il presidente Vittorio Di Trapani e l’intervento di Giuseppe Giulietti, coordinatore di Articolo21.
Signora Moris, quali sono le condizioni di Julian Assange?
Julian è imprigionato ingiustamente, è detenuto da quattro anni in un carcere di massima sicurezza ma in realtà è privato della libertà dal 2010. Fisicamente è molto provato ma anche la sua salute psichica e mentale si deteriora giorno dopo giorno proprio perché pende su di lui la minaccia dell’estradizione verso lo stato che lo ha privato e vuole privarlo dei suoi diritti, che vuole metterlo in prigione per 175 anni. Tenere Julian in prigione significa inviare un messaggio chiaro al mondo che non è possibile dire la verità.
Come si affronta e come si supera un sopruso umano e giudiziario di questo tipo?
Questo è un caso strettamente politico perché nel momento in cui Julian ha voluto rendere pubblici i crimini compiuti da diversi stati, crimini prontamente insabbiati dagli stessi stati coinvolti, l’onda d’urto delle sue rivelazioni si è rivoltata contro di lui, attraverso accuse politiche volte a provocarne l’arresto e la prigione perpetua. È importante per il pubblico avere la consapevolezza che a volte anche se all’esterno c’è un’apparenza di legalità, questa legalità non è altro che fumo negli occhi creato artificialmente per nascondere la verità. Per questo è fondamentale considerare il caso di Julian come prettamente politico e non farsi distrarre dall’iter e dai dettagli tecnici del processo.
L’Italia lo riconosce come giornalista. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana gli ha attribuito un tesserino. Stessa cosa hanno fatto altre federazioni europee. Questo statuto può aiutare Assange nella sua battaglia per la libertà?
È assolutamente cruciale che la comunità di giornalisti mostri solidarietà a Julian e lo riconosca come giornalista. Ricordiamo che Julian in Australia è stato membro dell’ordine dei giornalisti dal 2007. Gli attacchi rivolti contro di lui, negando il suo ruolo di giornalista, miravano a isolarlo da questa comunità. Il governo degli Stati Uniti ha sempre negato la natura giornalistica del suo lavoro, ma quale governo può decidere chi è giornalista e chi no? Chiaramente Julian è un giornalista ma anche in quanto tale è stato accusato di aver acquisito informazioni provenienti da fonti che non ha voluto svelare e di averle rivelate al grande pubblico. È incoraggiante che ci sia una dimostrazione di unità da parte di decine di paesi nel mondo. Non è assolutamente in discussione che Julian sia un giornalista. Non è solo un giornalista, ma uno dei più importanti giornalisti viventi.
(il manifesto, 30 aprile 2023)
di Sarantis Thanopulos
La morte di Barbara Padovani, psichiatra, per mano di un paziente autore di ripetuti atti di violenza, ha riacceso le polemiche sulla sicurezza e le critiche nei confronti della riforma Basaglia, che, per inciso, con l’assassinio non c’entra nulla.
L’ossessione della sicurezza ha cambiato la qualità e il senso della nostra vita. L’esistenza votata alla sicurezza si deprime. Diventa paranoica per tenersi viva sul piano dell’eccitazione e dell’allerta, visto che non può esserlo su quello del desiderio, delle emozioni e dei sentimenti.
La ricerca della sicurezza ci ha ipnotizzati, nonostante l’evidenza che, oltre a rendere miserabile il nostro vivere, produce contrariamente a quello che ci prefiggiamo, molti più problemi di quanti risolve. Creiamo nuove, ingegnose modalità di adattamento a pericoli reali, potenziali o immaginari. Tuttavia, poiché l’adattarsi alla realtà piuttosto che conoscerla, esplorando le sue diverse possibilità e dimensioni, non ce la rende più vicina e accogliente, ma al contrario lontana e minacciosa, il risultato finale è l’acuirsi del nostro senso di precarietà e di incertezza.
La domanda di sicurezza non produce sicurezza, ma ulteriore domanda di sicurezza. È una delle grandi mistificazioni della nostra epoca, perché prende il posto della prevenzione e della manutenzione. Che non sono equivalenti della «messa in sicurezza». Il sentirsi al sicuro non lo creiamo con un assetto difensivo nei confronti del mondo, ma abitandolo con un senso di libertà che deriva da una intima, attenta relazione con esso, fondata sulla cura. Prendere cura di noi e degli altri, degli ambienti in cui viviamo, degli oggetti che usiamo o costruiamo, è una cosa complessa e di per sé appagante.
Si prevengono i danni delle alluvioni costruendo argini sulle rive del fiume o si evita il logorio del legno impregnandolo di olio che lo protegge dalla pioggia. Si riparano le scarpe risuolandole. Si potano gli alberi per aumentare la qualità del loro prodotto. Si scelgono con attenzione le parole di una dichiarazione d’amore o di una poesia perché esprimano nel miglior modo i sentimenti che li animano. Si sperimentano diverse possibilità espressive sul taccuino di un pittore o di un architetto o sulla tastiera di un pianoforte. Si prende la giusta misura della distanza per godere di un panorama o per fare un salto, o del tempo per coordinarsi nel ballo con il proprio partner. Si valutano, con l’aiuto della prudenza e della moderazione, le conseguenze dei propri gesti e ci si affida alla potenza intuitiva dell’immaginazione per indovinare passaggi che la più potente capacità di misurazione e osservazione non potrebbe inquadrare.
Perché queste modalità di costruire la nostra relazione con ciò che ci fa sentire vivi e dà significato alla nostra esistenza, la cui composizione variabile fa la cura, dovrebbero essere assenti dal campo della salute mentale e dalla prospettiva con cui lo guardano le istituzioni nel loro insieme? Cosa si può aspettare se il campo della sofferenza umana più destabilizzante, quella che più ci interroga sul senso della vita, è lasciata all’incuria?
La sofferenza psichica non è più comprimibile in modo massivo all’interno di recinzioni murarie, non solo perché ciò sarebbe una violenza insopportabile per la società democratica, ma anche perché il suo spazio si è esteso così tanto che invade diffusamente l’intera società e si interseca con il crescente disagio della collettività e della civiltà. L’area dell’intersezione è il luogo dove maggiormente si estrinseca la violenza anonima, la più distruttiva (dalla guerra in Ucraina, all’assassinio di Pisa). Bisogna riformare radicalmente il sistema della salute mentale, fondandolo sulla riforma Basaglia e sull’investimento forte della psicoterapia e del lavoro nella comunità. Usare i farmaci per controllare, silenziare il malessere, è istigazione alla violenza.
(il manifesto, “Verità nascoste”, 29 aprile 2023)