di Aldo Cazzullo
Nel 1965, Franca Viola, che non aveva ancora compiuto diciotto anni, fu violentata dal nipote di un boss mafioso. Secondo le consuetudini del tempo, avrebbe dovuto sposarlo: il matrimonio riparatore. Lei rifiutò, e i genitori si schierarono dalla sua parte. Il padre chiese l’aiuto della polizia. L’aggressore non vide estinto il reato, come sarebbe accaduto se Franca si fosse piegata al matrimonio; finì in carcere. «L’onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce» disse la ragazza. Fu aperta una via che tante altre giovani donne, non soltanto del Sud, hanno seguito. Quando Franca si sposò con un uomo che amava e la amava, il presidente della Repubblica Giuseppe Saragat inviò un dono di nozze, papa Paolo VI ricevette la coppia. Fu uno spartiacque nella storia d’Italia.
È possibile che l’assassinio di Giulia Cecchettin e il discorso di suo padre ieri siano un altro di quei tornanti nella vicenda nazionale.
Il padre non ha puntato il dito contro nessuno. Non ha neppure escluso che in futuro maturino le condizioni per il perdono. Ma le sue parole più importanti non sono quelle rivolte all’assassino di sua figlia; sono quelle che risuonano per tutti gli uomini. Che non sono ovviamente colpevoli in modo indiscriminato, ma che portano una responsabilità. Tocca agli uomini educare i figli a rifiutare la violenza e a denunciarla. Tocca agli uomini parlare agli altri uomini. Non minimizzare le piccole violenze, perché talora è da lì che nascono le grandi. Rispettare sempre e comunque le donne, molte delle quali portano come un peso nascosto il ricordo di tante piccole prevaricazioni. Non avere paura della libertà della donna, non considerarsi mai proprietari del suo corpo e della sua anima. Non girare la testa di fronte alle violenze e alle ingiustizie.
Infine, l’invito forse più importante: accettare le sconfitte. I dinieghi e gli abbandoni, i no e i basta. L’ultima parola spetta alle donne. Giulia Cecchettin non ha potuto dire la sua. L’ha detta il padre per lei. A noi tocca ascoltarla, metterla in pratica, e ripeterla a chi verrà dopo.
(Corriere della Sera, 6 dicembre 2023)
di Jennifer Guerra
Sono tanti anni che si parla di come contrastare la violenza sulle donne e di genere ma, per la prima volta, il femminicidio di Giulia Cecchettin ha consentito di porsi una domanda diversa dalle solite. Non più rivolta alle istituzioni affinché aumentino le pene o alle donne affinché stiano più attente, ma all’intera società. Cosa possiamo fare e in cosa abbiamo sbagliato noi, come collettività, e nello specifico gli uomini di questa collettività? A porla è stata prima una giovane donna, Elena Cecchettin, da subito derisa e attaccata con accuse senza senso, e poi suo padre, Gino Cecchettin. Non è per niente scontato che un uomo, a maggior ragione in quello che possiamo presumere sia uno dei momenti più dolorosi della sua vita, si faccia carico di questo peso. Perché è un peso dire agli uomini che hanno un problema, e che questo problema non si può risolvere solo con l’educazione, la prevenzione o la minaccia della punizione. Queste sono le soluzioni di cui si possono e di cui si dovrebbero fare carico le autorità, ma c’è dell’altro, qualcosa che riguarda la vita intima delle persone e il modo in cui si relazionano con gli altri. Gino Cecchettin, nella sua orazione funebre per la figlia, è entrato in questo ambito privato e, come nella migliore tradizione femminista, l’ha portato sul piano politico, parlando di un’assunzione di responsabilità. Un genitore che ha appena perso la figlia per un omicidio non solo non ha citato nel suo discorso al funerale della figlia Giulia vendetta, pena o perdono, ma addirittura riconosce che la responsabilità è collettiva, includendo anche sé stesso nel discorso. Molti commentatori in questi giorni hanno attribuito la violenza di genere a una presunta crisi della paternità, sostenendo che la mancanza della sua autorevolezza possa causare comportamenti violenti nei figli maschi. Ma di fronte a un padre come Gino Cecchettin è difficile riuscire a sostenere ancora questa tesi: il problema piuttosto sta nella mancanza di modelli di mascolinità alternativa a quella egemonica, che non incarni solo un ruolo predeterminato ma anche e soprattutto la volontà di cambiare. Nell’omonimo libro, la femminista bell hooks scrive che «il primo atto di violenza che il patriarcato chiede agli uomini di commettere non è la violenza contro le donne, ma piuttosto l’automutilazione psicologica, la loro repressione emotiva». Non è il padre permissivo e debole a causare la violenza, ma è l’uomo – che sia padre o meno non importa – che non prende atto dei propri sentimenti.
Questa presa di consapevolezza non si limita al perimetro del sé, ma diventa contagiosa nel momento in cui è condivisa: i sentimenti non si possono cambiare o cancellare con la sola forza di volontà, ma è sempre possibile agire sulle conseguenze che questi sentimenti hanno sugli altri. Riconoscendo sé stessi e poi i propri simili come portatori di sentimenti, «guardando negli occhi degli altri» per citare il discorso di Cecchettin, si può costruire un’alternativa. Al funerale di sua figlia, ma anche in tutti i giorni precedenti fatti di dichiarazioni precise e chiare, Gino Cecchettin ha mostrato che è possibile essere uomini vulnerabili, affranti, arrabbiati, ma allo stesso tempo anche lucidi e concreti. Sempre bell hooks nel suo libro La volontà di cambiare scrive che nella società patriarcale gli uomini rinunciano a “essere integri”. Il loro mostrarsi “tutti di un pezzo” si traduce in realtà nel mostrare di volta in volta le parti di sé che si adattano al ruolo che viene loro richiesto di ricoprire. Cecchettin si è mostrato integro, accogliendo in sé il bene e il male di questo momento a ogni livello: personale, umano, politico. Non solo, ha mostrato anche che è possibile riconoscere i propri limiti. Annunciando di volersi prendere una pausa dal lavoro, il padre di Giulia ha messo un altro tassello nella sua opera di decostruzione, sottraendosi al ruolo di breadwinner, di perfomatività a tutti i costi. Un’altra analisi gettonata della cosiddetta crisi della mascolinità vuole che sia proprio la perdita di prestigio economico dell’uomo, minacciata dalla crescente emancipazione della donna, a causare il sentimento di vendetta che porta alla violenza di genere. Gino Cecchettin, con questa sua scelta, ha in qualche modo mostrato che soffiare sul fuoco della competizione non può essere una soluzione praticabile, proprio perché è in quella competizione che si nasconde la trappola della mascolinità.
L’“impegno civico” che Gino Cecchettin sente di doversi assumere è già stato svolto con questa incredibile presa di coscienza. Non una lezione calata dall’alto, non la predica di un padre, ma le parole di un uomo che ha deciso di non restare a guardare il proprio dolore.
(Fanpage.it, 6 dicembre 2023)
di Arianna Premoli
Sabato 11/11 si è tenuto nella sede della Libreria delle donne di Via Pietro Calvi 29 un altro incontro della serie #LIBERAmente, questa volta a tema social network: quanto li usiamo, perché li usiamo, cosa ci riserva il futuro?
Che i social stiano occupando una posizione sempre più di rilievo nella nostra vita è cosa assodata, ormai.
Ci colpisce come, nella nostra vita lavorativa, una eventuale presenza social possa essere il discrimine di un’assunzione o di un congedo ingessato e goffo: non siamo abbastanza visual, non siamo abbastanza trendy. Non abbiamo curato a sufficienza l’immagine di noi che vendiamo al mondo, a dispetto magari di curricula stellari alle spalle. L’immagine diventa il non plus ultra, il biglietto da visita supremo, che nessuna persona può permettersi di ignorare. E quello che succede a chi non si presta al gioco è presto detto: un completo e totale isolamento.
Non si batte ciglio oggigiorno per come le interazioni umane, in carne e ossa, stiano venendo coattamente rimpiazzate da e-mail e messaggi vocali nelle chat, al fine del ridurre i faccia-a-faccia al minimo indispensabile e, se si riesce, ancor meno di quello. Non ci si meraviglia di una omologazione tout-court delle nostre modalità di socializzazione, che diventano smaterializzate, impalpabili in un etere che appiattisce e ingrigisce tutto ciò che tocca. Le foto delle vacanze non sono più una cosa fine a sé stessa, ma un palcoscenico su cui esibirci in una performance volta a mostrare a tutti quanto siamo rilassati. Le foto di una mostra? Quanto siamo acculturati. Le foto di un campo di girasoli? Quanto siamo connessi alla natura. Un atto dopo l’altro, in una recita che non sembra finire mai. Una recita in cui siamo tutti spettatori e attori al tempo stesso, dove a colpi di like si partecipa a questa allucinazione collettiva dove siamo tutti felici.
Uno dopo l’altro, i social stanno implementando il ricatto più vecchio della Storia umana: se non vuoi essere dato in pasto (i.e. i nostri dati personali) ai lupi (i.e. il mondo delle multinazionali), pagami. La pubblicità domina e scandisce ogni momento della nostra vita, tutto è prodotto.
Davanti a questa avanzata inesorabile ci sentiamo impotenti, spogliate di qualsivoglia arma utile a non farci additare come “retrograde” e “all’antica”, quando il nostro obiettivo è quello di far risuonare dei campanelli di allarme: il fenomeno ci sta sfuggendo di mano, si sta trasformando in un tritacarne da cui non c’è scampo.
Ma un fil rouge c’è, anche se non si vuole vedere: il nostro sistema economico sta fagocitando la nostra umanità, e i social sono la forchetta.
Con un progressivo erodersi di tutti gli spazi di aggregazioni a noi cari nel mondo reale in nome di un fantomatico progresso, ci si è ritrovati spinti a forza in una dimensione neonata, quella digitale, senza regole di alcun tipo. La nostra ingenuità iniziale, la gioia bambinesca di avere tra le mani un mondo tutto nuovo da scoprire, ha fatto sì che diventassimo ciechi ai suoi pericoli nascosti, che l’1% dei Grandi del mondo ha subito ritorto contro di noi a suo vantaggio.
Non siamo persone, siamo potenziali prodotti e potenziali compratori. Anche se la nostra fonte di guadagno non sono direttamente i social, questi ci portano clienti, e per fidelizzare i clienti bisogna implementare strategie di marketing funzionali, e queste strategie di marketing vanno rinnovate ogni mese per non far calare l’interesse. Dobbiamo venderci ed essere felici di farlo, per poi essere gettati via quando abbiamo esaurito il nostro potenziale. Tanto, ci sarà sempre carne fresca, cresciuta a pane e TikTok, pronta a prendere il nostro posto. Uno schema piramidale degno delle peggiori compagnie di truffe.
Ma, in mezzo a tutto questo disfattismo, una speranza c’è, e parte da incontri come questo.
La battaglia frontale è inutile in questo primo tempo, quando la polvere non si è ancora posata, e bisogna lavorare sui fianchi: costruire degli argini per contenere il fiume in piena.
Questi argini si costruiscono con onestà e tanta, tantissima voglia di fare.
L’onestà di vivere la nostra vita e il nostro corpo così come sono, senza infiocchettarli con filtri e correzioni ad hoc, mostrandoci nella nostra forma più naturale. Onestà è rompere il circolo vizioso che ci tiene con le guance sempre tirate in un sorriso posticcio, con il flash sempre pronto.
E la voglia di fare, e la costanza, per cambiare la narrativa dominante dei social oggigiorno. Faticare tutte insieme per costruire basi solide da cui far partire un lento, lentissimo cambiamento sociale che ridefinisca il nostro modo di stare online e lo spazio che noi decidiamo di dedicare alla dimensione digitale, perché non ci annienti.
Arianna Premoli fa parte del collettivo Le Compromesse
(www.libreriadelledonne.it, 6 dicembre 2023)
L’autrice di questo articolo ha scelto di rimanere anonima.
Com’è stato accolto nelle scuole italiane il minuto di silenzio per Giulia Cecchettin? E qual è il vero volto della mascolinità tossica che non riusciamo a vedere? Per capirlo bisogna partire da un dato: la fragilità dell’identità maschile.
Era martedì 21 novembre, erano le 11 del mattino, l’aria che si respirava nelle aule delle scuole italiane incarnava la tensione della dialettica quando si fa corpo vivo e teso: in alcune aule il silenzio in nome di Giulia Cecchettin resta come di marmo a separare le parole dette prima e quelle dopo. In altre aule si fa rumore, più rumore possibile, non per gusto del caos ma per coscienza politica. Infine in aule più medie, più quotidiane l’appello nazionale al silenzio viene spezzato da risolini, battute, pernacchie fatte a mezza bocca per rompere l’imbarazzo di una posa che non si impone come il marmo, ma si appoggia come plastica posticcia sui corpi di ragazzi e ragazze che non ne colgono il valore.
In un’aula, la mia, al posto del minuto di silenzio si è acceso un dibattito che si è fatto subito antagonismo (e non dialettica), dinamiche di branco, strategie di autodifesa, reazioni istintive a una comunicazione che vede vittime e imputati senza inquadrare la struttura. Le poche ragazze di una classe di un istituto professionale hanno urlato le loro ragioni, provate dalla rabbia e dalla paura di vivere in un contesto in un cui non si sentono sicure, hanno spiegato le ragioni di un malessere legato a un contesto socio-economico e culturale che non ascolta. In quella scuola gli studenti di seconda generazione sono la maggioranza e le loro culture non sono comunicanti, ma sono isolate, tendono a radicalizzarsi e ghettizzarsi. Il bagaglio culturale di cui sono portatori diventa il marchio di fabbrica che garantisce loro l’appartenenza a una comunità, e in quanto “marchio” non dialoga, ma aggrega senza mediazione. Le ragazze hanno spiegato le ragioni di un malessere legato a quella scuola dove la sproporzione tra generi e una mascolinità tossica mai messa in discussione costringono quelle ragazze ad andare in bagno in coppia non per chiacchierare, ma per proteggersi da un costante stato di tensione. In tutta risposta alle parole delle ragazze, il resto della classe ha rioccupato il territorio facendo branco, ribadendo che «possono tornare a stare zitte e cucinare», perché «io rispetto mia madre e le donne adulte, non rispetto le prostitute». Discorsi detti per aggrapparsi a uno status quo, smorzati pian piano dall’apertura di un dialogo con l’insegnante (che sarei io) durante il quale i ragazzi si sono placati e richiamati reciprocamente a stare attenti, con serietà, promettendo di riflettere su quanto detto (ho raccontato un’esperienza personale).
Alla fine della conversazione sul volto dei ragazzi è apparso uno sguardo confuso, incerto, scomposto, decostruito verrebbe da dire, e silenzioso (finalmente). Il giorno dopo, tuttavia, quello stesso sguardo si è tradotto nello sguardo competitivo di chi sente di aver perso un po’ di territorio e vuole riconquistarlo: i ragazzi schierati mi hanno chiesto, con fare provocatorio, di parlare dei “froci” o di riaprire il discorso, spalleggiandosi, rinviandosi battute e pacche sulle spalle. Dovevo aspettarmelo: i ragazzi cercano l’identità di branco pur di riappropriarsi di un qualsiasi tipo di identità, pur di non rimanere nudi davanti alla realtà. E quella nudità la percepiscono più facilmente quando non hanno un’identità individuale strutturata (e con strutturata intendo “pensata”, e quindi in grado di attutire i colpi della contraddizione).
Un volto della mascolinità tossica
«Io non so come fai a stare in quelle situazioni mantenendo la calma, io impazzisco per comportamenti maschilisti molto meno espliciti», mi ha detto una mia amica quando le ho raccontato la vicenda. E anch’io, devo dire. Perché mi innervosisco per un mio amico che mi interrompe mentre parlo, sovrappone la sua voce alla mia, e non provo rabbia (tra le tante emozioni provate) di fronte a queste dinamiche scolastiche? Credo che una prima risposta riguardi le responsabilità: la responsabilità di un quindicenne è limitata se, per adeguarsi a un contesto che non gli dà strumenti conoscitivi necessari per emanciparsi, assume marcati ruoli di genere. Perché quel quindicenne è in gran parte frutto della classe sociale, del sistema sociale e culturale che gli ruota attorno, è in gran parte frutto di una porzione di realtà che è stata ghettizzata, ignorata, bistrattata in maniera classista dagli strati più privilegiati della società, come se mettere la testa sotto la sabbia eliminasse i problemi.
In secondo luogo la risposta sta in una egoistica, intima, individualistica percezione di pericolo e fastidio: quando entro in quelle classi, so che sto uscendo dalla mia bolla e che sto entrando in un’altra Italia, che pure esiste, che pure è viva, ma che teoricamente non permea la mia sfera privata, quella che ho scelto per me. Insomma, non sento violata la mia intima scelta di vivere in un certo modo. Non sento violata la mia libertà. Ma credo che ci sia anche un’altra motivazione: dietro quell’attaccamento disperato a valori inossidabili e assoluti come “la Famiglia”, “la Rispettabilità”, “l’Onore”, “la Donna pura”, credo ci sia l’attaccamento di chi sa che quelle maiuscole sono l’unico capitale di cui dispone. Se non so chi sono e chi sarò (o peggio: ho l’impressione di essere condannato a essere sempre, fino alla morte, questa persona qui), allora il mio avanzamento si misura per progressive acquisizioni di sicurezze: la mia impressione di non esistere e di non avere un’identità “pensata” porta alla ricerca spasmodica di sintomi della mia esistenza, in una sua manifestazione tutta esteriore. E se la donna è uno di questi “sintomi”, se è veramente un’emanazione della mia esistenza e non una persona autonoma, allora il mio affetto potrebbe assumere le sembianze del controllo per proteggerla, la donna. Proteggerla anche dalle sue stesse scelte, certo, cosa c’è di male, perché proteggere lei vuol dire proteggere un surrogato della mia persona.
L’altro volto della mascolinità tossica (lo stesso, ma più agiato)
«Noi non siamo talebani, io non ho mai insegnato a mio figlio a maltrattare le donne. Parlavamo spesso in casa di questi temi, soprattutto quando i ragazzi partecipavano agli eventi organizzati dalla scuola»: in quegli stessi giorni ho sentito queste parole, pronunciate dal padre di Filippo Turetta in un’intervista. «Noi non siamo talebani» è un’espressione curiosa e sintomatica che, al di là delle speculazioni educative che sicuramente l’intera vicenda ha attratto, lascia trapelare l’idea di un “noi” e di un “loro”, da un lato pace e armonia, dall’altro violenza e maschilismo, come se il maschilismo passasse solo attraverso le imposizioni violente e non attraverso la propagazione di strutture di pensiero, spesso implicite. Noi non siamo come loro, come gli stranieri, come i terroristi, come i pazzi che si fanno esplodere o che massacrano una ragazza a morte perché non si è coperta bene, quindi non posso essere colpevole, sembra dirci il padre. Io ho dato tutto a mio figlio, gli ho voluto bene a quel bravo ragazzo che andava bene a scuola e che faceva sport, e che poi ha accoltellato a morte la ragazza. Eppure c’è in questa storia, in questa presunta purezza e perfetta piccola borghesia italiana, uno scollamento tra ciò che si dice e ciò che accadeva (anche prima dell’omicidio) che continua a riportarmi a Pastorale Americana [romanzo scritto nel 1997 da Philip Roth], a una famiglia che è anche Storia e cultura, allo sconcerto di una culla che si crede sicura e caritatevole, ma che in fondo non si conosce, che non si pone domande trascinandosi in una tranquillità bovina, e che alla fine si scopre nutrice di una violenza senza capo:
«Marcia cominciò a ridere dell’ottusità di cui avevano dato prova davanti alla fragilità di tutto il meccanismo, a ridere di tutti loro, colonne di una società che, con sua grande gioia, stava colando rapidamente a picco; a ridere e a mostrare il proprio godimento per l’ampiezza che aveva preso il disordine galoppante, apprezzando enormemente l’attaccabilità, la fragilità, l’indebolimento di cose che avrebbero dovuto essere robuste. Si era aperta una breccia nel loro fortilizio, persino nella sicura Old Rimrock, e ora che era aperta non si sarebbe più chiusa. Non si riprenderanno mai. Tutto è contro di loro. Tutte le voci che dall’esterno condannano e ripudiano la loro vita! Ma cos’ha la loro vita che non va? Cosa diavolo c’è di meno riprovevole della vita dei Levov?»
Cos’ha la loro vita, la nostra vita piccolo borghese che non va? Cosa c’è di sbagliato in una cultura che conforta il figlio maschio prediletto raccontandogli che può ottenere tutto, basta volerlo, basta impegnarsi, basta andarselo a prendere, basta rifiutare il fallimento, basta mettere su famiglia e dare l’impressione di essere una persona risolta, basta performare, basta tenere tutto dentro perché fuori è ovunque competizione (la stessa competizione delle classi sociali più disagiate, ma con beni posizionali diversi), basta – in sostanza – percepirsi infallibili per essere veramente infallibili? Cosa c’è di sbagliato in un mondo dove soprattutto gli uomini acquistano dignità solo in base al bottino che ottengono? Di sbagliato, forse, c’è che in questo mondo gli uomini fanno fatica a creare relazioni, dove per “relazione” non si intende la dinamica gruppale, ma si intende la capacità di uscire da sé stessi per entrare a contatto con l’altro, perché uscire vuol dire entrare nell’ignoto, e quindi nella debolezza, e quindi nella sconfitta. Di sbagliato c’è che se si vive sempre, unicamente, la propria dimensione personale, l’altro diventa un feticcio e il sé diventa una prigione, la paura di instaurare una relazione sincera alimenta un’identità fondata sul vuoto di esperienze e riflessioni, la persona si riduce, ancora una volta, a marchio che non dialoga. C’è di sbagliato che, quando questo tipo di cultura mostra le sue falle, quella stessa cultura reagisce battendo i piedi e chiedendosi come mai, oppure inoltrandosi in litanie melense sui peccati del mondo e dei maschi, scambiando questo mea culpa vittimista per elaborazione del problema. E questo accade perché ciò che resta è sempre la solita esaltazione del bel, bravo, figlio maschio che può tutto, tranne sminuirsi. Questo è il nocciolo che permea le due Italie, quella dei “buoni” e quella dei “cattivi”, che riproduce gli stessi schemi ma con beni posizionali diversi, e si chiama mascolinità tossica, maschilismo, ossessione del potere e – nei casi estremi – femminicidio. Per decostruire, in sostanza, non basta scegliere a quale gruppo aderire (per semplificazione, maschilista o femminista), bisogna entrare nel gruppo antagonista ed esporsi, rompere la dinamica di branco e accedere alla relazione significativa. «L’infelicità degli uomini nei loro rapporti, il dolore che provano per il fallimento dell’amore, nella nostra società passa spesso inosservato perché in realtà alla cultura patriarcale non importa se gli uomini sono infelici. […] I costumi patriarcali impongono agli uomini una sorta di stoicismo emotivo in base al quale sono più virili se non provano sentimenti ma, se per caso dovessero provarli e quei sentimenti li ferissero, l’unica reazione virile sarebbe soffocarli, dimenticarli, sperare che spariscano. […] Una volta pensavo fosse una cosa da donne, questa paura degli uomini. Ma, quando ho cominciato a discutere con gli uomini dell’amore, li ho sentiti più di una volta parlare della paura degli altri maschi. Gli uomini che provano sentimenti, che amano, spesso nascondono le loro emozioni agli altri uomini per paura di essere attaccati e ridicolizzati. Questo è il grande segreto che tutti condividiamo: la paura della mascolinità patriarcale che impregna la nostra cultura», diceva bell hooks.
(L’Indiscreto, 6 dicembre 2023)
di Gino Cecchettin
Carissimi tutti, abbiamo vissuto un tempo di profonda angoscia: ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso questa pioggia di dolore sembra non finire mai. Ci siamo bagnati, infreddoliti, ma ringrazio le tante persone che si sono strette attorno a noi per portarci il calore del loro abbraccio. Mi scuso per l’impossibilità di dare riscontro personalmente, ma ancora grazie per il vostro sostegno di cui avevamo bisogno in queste settimane terribili.
La mia riconoscenza giunga anche a tutte le forze dell’ordine, al vescovo e ai monaci che ci ospitano al presidente della Regione Zaia e al ministro Nordio e alle istituzioni che congiuntamente hanno aiutato la mia famiglia. Mia figlia Giulia era proprio come l’avete conosciuta, una giovane donna straordinaria. Allegra, vivace, mai sazia di imparare. Ha abbracciato la responsabilità della gestione familiare dopo la prematura perdita della sua amata mamma. Oltre alla laurea che si è meritata e che ci sarà consegnata tra pochi giorni, Giulia si è guadagnata ad honorem anche il titolo di mamma.
Nonostante la sua giovane età era già diventata una combattente, un’oplita, come gli antichi soldati greci, tenace nei momenti di difficoltà: il suo spirito indomito ci ha ispirato tutti. Il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svaluta la vita delle donne, vittime proprio di coloro avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate, costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà prima di perdere anche la vita. Come può accadere tutto questo? Come è potuto accadere a Giulia? Ci sono tante responsabilità, ma quella educativa ci coinvolge tutti: famiglie, scuola, società civile, mondo dell’informazione… Mi rivolgo per primo agli uomini, perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento contro la violenza di genere. Parliamo agli altri maschi che conosciamo, sfidando la cultura che tende a minimizzare la violenza da parte di uomini apparentemente normali. Dovremmo essere attivamente coinvolti, sfidando la diffusione di responsabilità, ascoltando le donne, e non girando la testa di fronte ai segnali di violenza anche i più lievi. La nostra azione personale è cruciale per rompere il ciclo e creare una cultura di responsabilità e supporto.
A chi è genitore come me, parlo con il cuore: insegniamo ai nostri figli il valore del sacrificio e dell’impegno e aiutiamoli anche ad accettare le sconfitte. Creiamo nelle nostre famiglie quel clima che favorisce un dialogo sereno perché diventi possibile educare i nostri figli al rispetto della sacralità di ogni persona, a una sessualità libera da ogni possesso e all’amore vero che cerca solo il bene dell’altro. Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ci connette in modi straordinari, ma spesso, purtroppo, ci isola e ci priva del contatto umano reale. È essenziale che i giovani imparino a comunicare autenticamente, a guardare negli occhi degli altri, ad aprirsi all’esperienza di chi è più anziano di loro. La mancanza di connessione umana autentica può portare a incomprensioni e a decisioni tragiche. Abbiamo bisogno di ritrovare la capacità di ascoltare e di essere ascoltati, di comunicare realmente con empatia e rispetto.
La scuola ha un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri figli. Dobbiamo investire in programmi educativi che insegnino il rispetto reciproco, l’importanza delle relazioni sane e la capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo per imparare ad affrontare le difficoltà senza ricorrere alla violenza. La prevenzione della violenza di genere inizia nelle famiglie, ma continua nelle aule scolastiche, e dobbiamo assicurarci che le scuole siano luoghi sicuri e inclusivi per tutti. Anche i media giocano un ruolo cruciale da svolgere in modo responsabile. La diffusione di notizie distorte e sensazionalistiche non solo alimenta un’atmosfera morbosa, dando spazio a sciacalli e complottisti, ma può anche contribuire a perpetuare comportamenti violenti. Chiamarsi fuori, cercare giustificazioni, difendere il patriarcato quando qualcuno ha la forza e la disperazione per chiamarlo col suo nome, trasformare le vittime in bersagli solo perché dicono qualcosa con cui magari non siamo d’accordo, non aiuta ad abbattere le barriere.
Perché da questo tipo di violenza che è solo apparentemente personale e insensata si esce soltanto sentendoci tutti coinvolti. Anche quando sarebbe facile sentirsi assolti. Alle istituzioni politiche chiedo di mettere da parte le differenze ideologiche per affrontare unitariamente il flagello della violenza di genere. Abbiamo bisogno di leggi e programmi educativi mirati a prevenire la violenza, a proteggere le vittime e a garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. Le forze dell’ordine devono essere dotate delle risorse necessarie per combattere attivamente questa piaga e degli strumenti per riconoscere il pericolo. Ma in questo momento di dolore e tristezza, dobbiamo trovare la forza di reagire, di trasformare questa tragedia in una spinta per il cambiamento. La vita di Giulia, la mia Giulia, ci è stata sottratta in modo crudele, ma la sua morte, può anzi deve essere il punto di svolta per porre fine alla terribile piaga della violenza sulle donne.
Grazie a tutti per essere qui oggi: che la memoria di Giulia ci ispiri a lavorare insieme per creare un mondo in cui nessuno debba mai temere per la propria vita. Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere: «Il vero amore non è né fisico né romantico. Il vero amore è l’accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia…».
Cara Giulia, è giunto il momento di lasciarti andare. Salutaci la mamma. Ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che, strette insieme, il vostro amore sia così forte da aiutare Elena, Davide e anche me non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto, ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia. Sì, noi tre che siamo rimasti vi promettiamo che, un po’ alla volta, impareremo a muovere passi di danza sotto questa pioggia. Cara Giulia, grazie, per questi ventidue anni che abbiamo vissuto insieme e per l’immensa tenerezza che ci hai donato. Anch’io ti amo tanto e anche Elena e Davide ti adorano. Io non so pregare, ma so sperare: ecco voglio sperare insieme a te e alla mamma, voglio sperare insieme a Elena e Davide e voglio sperare insieme a tutti voi qui presenti: voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare. E voglio sperare che produca il suo frutto d’amore, di perdono e di pace. Addio Giulia, amore mio.
(Today.it, 5 dicembre 2023)
di Annarosa Buttarelli*
Per Giulia e per Elena
L’odio millenario verso le donne in quanto donne dei femminicidi dà un unico mostruoso senso a quello che sta capitando e che l’uccisione di Giulia Cecchettin fa ascrivere ancora una volta alla mai veramente affrontata “questione maschile”. Spiegazioni che richiamano la ragion di Stato e la geopolitica per le guerre sono, nel 2023, del tutto secondarie e forse inutili.
Non fermeranno nulla, mai. Così con il femminicidio di Giulia Cecchettin non si interromperà la catena degli assassinii delle donne, visto che i giovani maschi – dicono le statistiche – stanno superando i vecchi maschi nel darsi da fare con coltelli e fiamme. La morte dell’innocente Giulia, oltre a suscitarci profondo dolore e profonda tristezza, finalmente ha sollevato la reazione generale a un livello più elevato del solito tra noi femministe e nella popolazione italiana. Le richieste di intervento dello Stato, purtroppo non avranno immediata efficacia, perché non è quella la strada più urgente.
Più sensate sono le voci che chiedono un massiccio e generale intervento perché finalmente si provi a “formare” meglio i maschi, giovani, vecchi, padri, operatori, medici, psicologi, militari, giudici maschi e femmine, manager, questori… Tanti, troppi forse, anche se questa sarebbe la strada giusta, a condizione che anche la cultura generale accettasse la necessità di una trasformazione radicale. Ma, come intellettuale femminista, sono sull’orlo della disperazione.
Questa benedetta “formazione” chi la farà? Chi la sta facendo?
Dobbiamo chiederci sinceramente quanto sia efficace e, addirittura, sensato educare, formare i maschi da parte di coloro che dovrebbero essere formati a loro volta. Dobbiamo chiederci se sia efficace educare e formare alla vecchia maniera, cioè avendo come base e come obiettivo la parità, l’inclusione, la complementarietà, la bontà, l’uguaglianza, il giustificazionismo psicologico, l’educazione sessuale basata sugli organi genitali… I Centri antiviolenza delle donne non formano così, ma rischiano ogni giorno la chiusura perché, di solito, il sostegno pubblico va nella direzione del “politicamente corretto” buonista. Ma in questi interventi si vede benissimo com’è grave l’ignoranza della vera dinamica dei rapporti tra uomini e donne, come si è lontani dalla realtà e come si continui a intervenire in astratto per la maggior parte delle formazioni nelle scuole, ad esempio.
Da intellettuale femminista e formatrice di lungo corso, sostengo, insieme a molte altre, che il grande assente è il senso della differenza sessuale, esattamente come è assente nei banali e diseducativi dibattiti televisivi.
Ad esempio, a Napoli, in questo momento, stiamo provando a intervenire, noi formatrici della Fondazione Scuola Donne di Governo insieme alle psicologhe di SINAPSI dell’Università Federico II, con una proposta formativa che non riguarda più l’educazione sessuale, ma che ha per titolo “Per una nuova civiltà del rapporto tra i sessi”. È questa la meta che dobbiamo tenere presente radicalmente, affinché i troppi agnelli sacrificali della storia degli uomini, Giulia Cecchettin tra questi, riceva quella forma di giustizia che va ben oltre la Legge, e ben oltre lo Stato.
Per di più abbiamo a che fare con la parola “patriarcato” che purtroppo è sfuggita a Elena, la geniale sorella di Giulia. Si spiega il rapido contagio avuto da questa parola con il fatto che è una parola vuota oramai: non esiste più nemmeno come ordine sociale il patriarcato, abbiamo già detto e scritto molte volte che stiamo cercando di disfare anche il dominio del fratriarcato, che è anche peggio del patriarcato. Indignarsi contro il patriarcato è come indignarsi e coartare contro il nulla chi ignora la storia. Ancora una volta ci tocca dire che la “questione maschile” è satura anche di ignoranza.
Chi domina è ben contento che si parli di patriarcato perché sarà del tutto inefficace farlo. Tremo all’idea che i futuri ignari “formatori e formatrici” cadano nella trappola e vi facciano cadere anche chi sarà loro affidato. Insisto per amore delle mie simili: bisogna prima formare i formatori e anche molte formatrici.
(*) Direttrice Scientifica Scuola di Alta Formazione Donne di Governo
(Scuola di Alta formazione Donne di Governo, dicembre 2023)
di Chiara Saraceno
Ogni donna che compie anche un silenzioso atto di ribellione contro stereotipi che la inchiodano in comportamenti e destini che non sente confacenti a sé e alle proprie figlie, che insegna ai propri compagni, figli, colleghi che le donne non solo vanno rispettate, ma sono soggetti liberi e che un rapporto di coppia, ma anche di generazione, può fondarsi solo sul riconoscimento della libertà reciproca, contribuisce al cambiamento nei modelli di genere e nei rapporti tra uomini e donne. Non occorre scendere in piazza per fare questo. Ma perché il cambiamento sia riconosciuto nelle norme legali e sociali, occorre che ci si mobiliti collettivamente, che si scenda in piazza, che la ribellione privata diventi pubblica. Le «immense conquiste del femminismo storico» che qualche giorno fa su questo giornale Mastrocola ha dichiarato di apprezzare, le richieste del femminismo che Natalia Ginzburg, citata da Mastrocola, dichiarava di condividere in toto, pur non piacendole il femminismo, hanno potuto diventare almeno in parte realtà solo perché ci sono state donne che si sono mobilitate collettivamente, correndo il rischio delle semplificazioni degli slogan e anche del conflitto interno alle varie anime dei movimenti, oltre che dei costi sul piano personale e professionale. Legalizzazione della contraccezione, dell’aborto, eliminazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore, riforma del diritto di famiglia che finalmente ha dato attuazione al principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione ma ignorato per trent’anni, riconoscimento dello stupro come reato contro la persona anziché contro la morale, eliminazione delle restrizioni di accesso alle professioni, leggi contro le discriminazioni, estensione dei congedi di maternità a tutte le lavoratrici e persino il riconoscimento del diritto dei padri al congedo: sono tutti cambiamenti avvenuti in conseguenza della mobilitazione dei movimenti delle donne. Ovviamente, non basta scendere in piazza e non basta qualche slogan più o meno urticante per produrre cambiamento. Occorre un’azione costante, sostenuta da analisi adeguate, la costruzione di alleanze, tra donne e tra donne e uomini. Ma si parte sempre dalla denuncia di un’ingiustizia, di una situazione non tollerabile, che mobilita, diviene protesta collettiva e chiede risposte concrete, non occasionali.
I femminicidi e le violenze sulle donne in quanto donne sono appunto questo fatto ingiusto e intollerabile, non derubricabile a semplice patologia individuale e neppure genericamente imputabile a una supposta fragilità delle identità nelle società contemporanee, a una generica incapacità di reggere alle frustrazioni e ai rifiuti. Perché si tratta di uomini che aggrediscono e talvolta uccidono donne proprio in quanto donne, uomini che considerano le donne vuoi loro proprietà, vuoi a disposizione dei loro appetiti sessuali. Perciò, che piaccia o meno, chiama in causa modelli di genere e di rapporti tra uomini e donne insieme asimmetrici e fondati su quella che chiamerei una rivendicazione proprietaria di dipendenza da parte di uomini rispetto alle donne con cui stanno o vorrebbero stare. Il termine patriarcato non è (più) adeguato a rappresentare questa modalità di stare nei rapporti di coppia e neppure per rappresentare le persistenti diseguaglianze di genere in società (e politica, nonostante una presidente del Consiglio donna), anche se rimane come nostalgia per un mondo che non lo garantisce più, come traspare anche dall’intervista di Vannacci ieri su questo giornale. Il patriarcato ha perso da tempo le proprie basi sociali e normative. Ma è rimasta, per quanto minoritaria e non sempre esplicita, l’idea di un diritto maschile a essere soddisfatti nei propri bisogni e ad avere la precedenza nel mercato del lavoro, in politica, nelle diverse forme di riconoscimento sociale. Lo hanno da ultimo documentato i dati dell’indagine sugli stereotipi di genere. Persino la fragilità, l’incapacità di uscire da una dipendenza affettiva, possono venir ribaltate in rivendicazione a ogni costo e con ogni mezzo di un diritto a non essere lasciati. Ovviamente, non tutti condividono questi stereotipi. Anche tra chi li condivide non tutti diventano violenti. Ma costituiscono un terreno di coltura non solo per le discriminazioni, ma per pretese di controllo e l’incapacità ad accettare di non essere ricambiati nella propria richiesta di dipendenza e a riconoscere, pur con dolore, la libertà dell’altra. A differenza di Mastrocola, trovo importante che tra gli uomini sia iniziata una riflessione autocritica, senza farsi spaventare (o legittimare a non fare nulla) dalle denunce semplificatorie di patriarcato. Perché il problema è come favorire lo sviluppo di identità maschili e di relazioni tra uomini e donne basate sull’uguaglianza, il reciproco rispetto, incluso il rispetto della libertà dell’altra/o, contrastando sia l’assunto di un privilegio di genere (maschile) nel fare e nel non fare, sia la mancanza di controllo delle proprie pulsioni ed emozioni. È una responsabilità e un lavoro che certo devono avvenire nella quotidianità delle relazioni, in famiglia e fuori, da parte di uomini e donne. Ma che richiede anche una riflessione collettiva e ad ampio raggio, non limitata alla denuncia della violenza, cui devono partecipare, appunto, anche gli uomini. Non per dare lezioni o battersi il petto, ma per mettere in moto efficaci azioni di cambiamento. Allenare le proprie figlie a difendersi fisicamente dagli aggressori, come suggerisce Vannacci, non è sufficiente a proteggerle dalle discriminazioni, tanto meno a modificare l’immagine dell’uomo come potenziale aggressore.
Riportiamo di seguito il testo a cui Chiara Saraceno fa riferimento, pubblicato sulla stessa testata il 3 dicembre u.s. a firma di Paola Mastrocola.
“Non amo questo femminismo è un confronto armato tra i sessi”
Non so bene che cosa significhi, oggi, essere femminista. Credo che tutte le donne lo siano, nel profondo di loro stesse, e che conducano le proprie battaglie all’interno della cerchia di familiari e amici. Ma altra cosa è dichiararsi femminista e partecipare a lotte e cortei. Non tutte lo fanno, perché non tutte condividono le idee, le parole, gli slogan e i toni del femminismo (quello oggi dominante sui media). Mi chiedo cosa pensino, queste donne non dichiaratamente femministe, di fronte ai recenti efferati casi di violenza. Se sono, come me, turbate anche dal dibattito in corso, dai toni perentori, dalle idee agguerrite e monolitiche.
Penso alla massa delle donne che, sposate o meno, con figli o no, vivono con – o frequentano – uomini normalmente non violenti, penso alla vita di tutti i giorni, donne e uomini che cercano, insieme, di dividersi i compiti, affrontare i problemi, prendersi qualche sprazzo di felicità. Penso a queste donne che di colpo, da ogni parte e in ogni momento del giorno da quindici giorni (sui social, in tivù e alla radio), sentono dire che tutti i maschi sono corresponsabili della morte di Giulia Cecchettin, e potenzialmente portatori di una violenza che è in loro da sempre.
Penso che di colpo queste donne guardino con occhi diversi gli uomini che hanno intorno, in casa propria, in casa di amici, per strada; che osservino i gesti che compiono, gli sguardi che lanciano, i piatti che lavano o non lavano, le parole che usano e quelle che si dimenticano di usare. Osservano. Turbate e addolorate per i casi di stupro, femminicidio, violenza fisica e verbale tra le mura domestiche di cui la cronaca è piena, cercano ora di vedere quel che non hanno mai visto e di capire quel che non hanno mai capito, di scorgere la falla, la stortura, l’anello che non tiene. Cercano di vedere il mostro che può annidarsi nell’essere maschile. E si sentono smarrite, quasi in colpa per non aver visto e capito niente, percepiscono intorno un’aria di disapprovazione, o anche solo disagio e imbarazzo; quasi vi fosse, sopra di loro, un’astronave nemica fatta a forma di tribunale, gremita di sguardi accigliati e severi che le accusano.
Non so cosa faranno adesso, queste donne di colpo illuminate. E non so cosa faranno gli uomini che normalmente vivono intorno a queste donne non dichiaratamente femministe, e che si trovano improvvisamente di fronte altri uomini che corrono a professarsi femministi, a fare mea culpa, a dirsi unanimemente corresponsabili di ogni crimine per il solo fatto di essere maschi (trovo strabiliante questa autoflagellazione maschile collettiva che, seppur limitata agli ambienti intellettuali, declina in nuova forma l’ormai classico “singhiozzo dell’uomo bianco”).
Ho sempre apprezzato pienamente le immense conquiste del femminismo storico, divorzio e aborto in primis. Ma di fronte a questo nuovo femminismo dei media, che mi sembra piuttosto un fumoso “femministicamente corretto”, potrei usare pari pari le parole di Natalia Ginzburg, che in un articolo di cinquant’anni fa esatti, nel 1973, scriveva: «Non amo il femminismo. Condivido però tutto quello che chiedono i movimenti femminili. Condivido tutte o quasi tutte le loro richieste pratiche. Non amo il femminismo come atteggiamento dello spirito». E ancora: «Il sentimento essenziale espresso dal femminismo è l’antagonismo fra donna e uomo». Ecco. In questi giorni tremendi in cui siamo tutti quanti scossi dal femminicidio di Giulia Cecchettin, quel che non mi piace in quel che leggo e sento sui media è la granitica unicità della visione femminista, l’assertività stritolante delle tesi, la totale mancanza di dubbi e assenza di sfumature, il sistematico non-ascolto delle opinioni altrui, anche quando espresse da persone competenti in base ai dati e ai loro studi. Aleggia un enorme Pensiero Unico Femminista, un PUF che recita di continuo: i femminicidi dipendono dalla sopravvivenza del patriarcato; l’aggressività maschile non ha basi biologiche e dipende essenzialmente dall’educazione e dalla cultura; bisogna allevare i figli in modo neutro (no bambole alle femmine, no macchinine ai maschi), introdurre corsi di educazione sentimentale nelle scuole, vigilare sull’uso del linguaggio.
Eppure l’agire umano è così complesso, così astruso, e in particolare le ragioni dei più recenti efferati crimini sono così misteriose e variegate. Si dovrebbe avere una maggiore apertura, non un pensiero ermeticamente chiuso a ogni altra possibile visione delle cose. Provo a elencare ciò che il PUF non prende in considerazione: l’ipotesi che i femminicidi e la violenza dipendano anche dal consumismo e dalla cultura dei diritti; che l’indulgenza e iper-protezione in ambito famigliare e scolastico abbiano reso i ragazzi e le ragazze incapaci di gestire frustrazioni e sconfitte, di sostenere sacrifici e quindi anche di elaborare il lutto per un rifiuto della persona amata; l’ipotesi che il rischio di subire violenza sia riducibile con comportamenti più prudenti (come peraltro sosteneva già trent’anni fa Camille Paglia, femminista coraggiosa e controcorrente). Infine l’ipotesi che le scelte “non femministe” di una parte considerevole delle donne siano libere scelte e non sempre e soltanto frutto di condizionamenti; che se una donna si sente più felice a curare la casa e i figli, o andare a cavallo o coltivare piante grasse, ha tutto il diritto di farlo senza dover incorrere negli strali del PUF.
Non amo il femminismo perché non mi piace questa contrapposizione armata delle donne contro gli uomini. Non siamo due eserciti di cui l’uno deve far fuori l’altro, prendo in prestito ancora una volta le parole di Natalia Ginzburg: «Penso che tutte le lotte sociali debbano essere combattute da uomini e donne insieme». Non amo il femminismo perché non mi sono mai sentita una donna: cioè, non ho mai pensato che questa mia peraltro indubbia appartenenza al genere femminile potesse significare qualcosa di decisivo, così staccato dal resto. Non mi sono mai pensata staccata dal resto.
Mi sono sempre sentita soltanto un essere umano, che per caso era nata femmina, così come per caso era nata a Torino. Infine, non amo il femminismo (e tutte le ideologie) perché non tutto è chiaro e spiegabile del nostro vivere su questa terra. Voglio dire che, se anche debellassimo definitivamente il patriarcato, se annientassimo il capitalismo e tutti i peggiori incubi delle passate ingiustizie, non credo che la violenza sulle donne (e la violenza in generale) sparirebbe dal nostro mondo. Un margine di insondabilità, e quindi di nostra ignoranza, lo dovremmo sempre mettere in conto, di fronte alle tragedie. Tutto qui. E sopperire con la pietà. Quella pietà universale che, non so perché, mi riesce difficile scorgere nel dibattito attuale.
(La Stampa, 5 dicembre 2023)
di Pat Carra
È in libreria Libellule nella rete (ed. Zona 42), il romanzo di fantascienza di Loretta B. Angiori, pseudonimo di Loretta Borrelli (Angiori è l’acronimo delle iniziali delle sue sorelle). Sviluppatrice web e teorica critica della tecnologia, Loretta scrive importanti saggi e tiene corsi nelle accademie sulle arti multimediali. Tra le sue numerose partecipazioni a gruppi politici a cominciare dagli anni ’90, è cofondatrice di Erbacce e prima di Aspirina: dal 2013 è stata l’anima e la maestra digitale delle nostre riviste, e ha ispirato i fumetti La bracciante digitale. In redazione abbiamo imparato a perderci nel suo pensiero labirintico, incline ad aprire finestre su finestre su finestre, più che a tirare conclusioni e trovare facili soluzioni. Spesso ci è apparsa come un’avanguardia troppo in anticipo: affidandoci a occhi chiusi, abbiamo aperto gli occhi.
Libellule nella rete è il suo romanzo di esordio, nato dal bisogno di staccarsi dall’astrazione teorica per riuscire a raccontare il mondo dominato dalle macchine e le trasformazioni tecnologiche intese come sintomi di trasformazioni più vaste: della natura, delle emozioni, dell’espressività, del lavoro, dell’inconscio. La sua passione per la fantascienza, che spazia da Ursula Le Guin a Donna Haraway a Orwell, le ha offerto la chiave.
Il punto di partenza del libro è una critica alle utopie della Silicon Valley e dell’intelligenza artificiale, utopie basate su teorie come l’“utilitarismo radicale” che, mosso da un “altruismo effettivo” sogna di organizzare una società acquiescente oppure, all’opposto, utopie basate su teorie come l’“accelerazionismo effettivo” che spinge per l’automazione totale del lavoro. Dietro queste filosofie ci sono persone reali, potenti gruppi di estrema destra che con il loro progetto anarcocapitalista o millenarista hanno un grande peso nel sistema economico e politico statunitense e anche nel nostro. Senza dimenticare che dall’altra parte del mondo c’è il progetto comunista-capitalista della Cina.
Nel romanzo, Loretta costruisce una società della catastrofe in cui queste utopie hanno vinto su tutta la linea, i redditi e le organizzazioni economiche sono regolamentati, l’IA semplifica il lavoro e le valutazioni dei comportamenti, tutto è automatizzato e sotto controllo, i sistemi di monete e di crediti sono assolutamente trasparenti, quindi blockchain, interoperatività e decentralizzazione dei sistemi e così via.
Le protagoniste sono Rei, una microinfluencer che abita in una metropoli come tante (potrebbe essere Milano), e Chiara, amministratrice di sistema che vive in una comunità autogestita di montagna, Piana di Urlele. Le loro storie si alternano, nei capitoli dispari Rei è raccontata in terza persona, in quelli pari Chiara è l’io narrante. Le due donne sono destinate a incontrarsi e a mettere in discussione molte certezze, in uno spazio-tempo del futuro che è l’essenza stessa del nostro presente: la catastrofe climatica, lo strapotere delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale, la solitudine, la depressione, la sofferenza psichica nel tardocapitalismo della sorveglianza.
In questo universo Rei «si sentiva spesso distrutta e assente, svuotata. Spesso provava una grande noia sfogliando i contenuti della rete, ignorava le interazioni con altri utenti. Le sedute di supporto psicologico non l’aiutavano a identificare le cause del suo malessere». Per questo Rei si rivolgerà, come altri, alle stanze per il supporto emotivo della misteriosa Sight Holding, società apparentemente clandestina.
L’altro mondo, la comunità di Urlele e alcuni spazi periferici e notturni che Rei si trova a frequentare, evocano i gruppi di hacking nati per condividere la conoscenza, il cyberpunk italiano, i centri sociali, i movimenti ambientalisti e anticapitalisti, il femminismo che mette le relazioni al centro del cambiamento. A Urlele appaiono le libellule che per Chiara «sono simbolo del rapporto tra forze a volte divergenti, altre volte convergenti, sempre positive per le trasformazioni. I cambiamenti che sognavamo dovevano stare agli obblighi del mondo che ci circondava, ma spesso desideravamo volare in modo imprevedibile».
Nel romanzo divergono e convergono, appunto, le prese di coscienza che aprono spazi di libertà, riconoscendo dall’interno del sistema i punti di rottura su cui l’azione diventa possibile. La tensione politica sottesa è sempre fortissima e permette, anche a noi che leggiamo con il fiato sospeso, di restare nella rete senza cadere nella rete. In alcune pagine il linguaggio informatico è complicato e viene il dubbio, a chi non ne conosce i codici, che sia tutta una finzione. Si tratta invece di un idioletto, un sistema linguistico comprensibile a una comunità, che potrebbe corrispondere a verità pur restando ermetico ai più. Queste pagine saranno lette in modo differente da esperti o profani, ma poco importa nel flusso narrativo.
Le libellule sono «fuoco al di sotto dell’acqua», creature che mettono in comune desideri e conoscenze: hacker, femministe, filosofi e attivisti, robot chiamati Mer che raccolgono le fragole e capiscono gli alberi, amiche che preparano cene, adolescenti inquieti, una bambina pasticciona e una madre ansiosa, i manifestanti anonimi nella città alluvionata, il libraio che vende manoscritti…
Durante la presentazione alla libreria Anàrres a Milano, Loretta ha citato la celebre frase di Fredric Jameson ripresa da Mark Fisher «è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo», estendendola al patriarcato. Da quando le donne non hanno più dato credito al realismo capitalista-patriarcale e hanno immaginato e desiderato altro, è iniziato il declino di un potere che sembrava eterno e immutabile. Se questo nuovo mondo possibile è considerato fantascienza, Loretta lo fa suo e dichiara “Io sono fantascienza”.
Domenica 10 dicembre alle ore 12 – Libreria Tuba, Via del Pigneto 39, RomaIncontro con Loretta Borrelli e Elena Giorgiana Mirabelli, modera Barbara Leda Kenny
(Erbacce, 4 dicembre 2023)
di Redazione
Era nata il giorno della fondazione del Partito Comunista, fu partigiana cattolica e quindi esponente del Pci, venendo eletta nella prima legislatura della Repubblica, di cui era l’unica parlamentare ancora in vita. È morta la scorsa notte, Maria Lisa Cinciari Rodano, avanguardia del femminismo in Italia. Aveva 102 anni, ventitré dei quali trascorsi in Parlamento, dal 1948 al 1971. Fu la prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente della Camera nell’ultimo lustro a Montecitorio, dal 1963 al 1968, per poi essere eletta al Senato. Per sette anni consigliera provinciale a Roma, a cavallo tra gli anni settanta e ottanta fu anche europarlamentare.
Arrestata sotto il fascismo per la sua attività nella Resistenza nelle file del Movimento dei Cattolici Comunisti e nell’attività dei Gruppi di difesa della donna, fu cofondatrice dell’Udi, Unione donne in Italia, di cui è stata anche presidente. A lei – nonna del nostro collega Tommaso Rodano – si deve, fra l’altro, la scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo, Festa della donna. Nel 2015 è stata insignita del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
«Odiavo le forme d’autorità, l’inquadramento, il conformismo. Detestavo le sfilate a via dell’Impero, il dover mettere la divisa, le manifestazioni sportive allo stadio dei marmi. E ho impressa questa immagine che vidi a Monterado, nelle Marche: la fila delle persone disoccupate appoggiate alle spallette dei muri, lungo la strada. Povertà e impotenza. Mi colpì moltissimo», ha ricordato nel giorno del suo centesimo compleanno, intervistata dal nipote. Del giorno della sua elezione a vicepresidente della Camera invece disse: «La prima cosa che ricordo è che non sapevo come vestirmi. La seconda che tutti i commenti erano su come fossi vestita». Delle battaglie femministe si era detta “più che orgogliosa, contenta”: «La condizione femminile è cambiata profondamente. Eravamo relegate al ruolo di moglie o di madre, siamo diventate cittadine di pieno diritto. Sono felice di aver combattuto per questo, la sento come una delle cose positive della mia vita».
Come «partigiana e poi politica di grande spessore» che «ha lottato sempre per i diritti e la libertà di tutte e di tutti», la ricorda il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Mentre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ne parla come di una «donna combattente e appassionata, sempre in prima fila nella difesa dei valori della democrazia» ma «soprattutto una madre, sorella, compagna per tante donne nel cammino lungo e faticoso della parità» di genere. «Le siamo riconoscenti e grate – ha aggiunto la leader dem – per tutto quello che ha fatto e continueremo a farci guidare anche dalla sua passione». Il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, assicura che terrà Marisa Rodano «nel cuore e nella responsabilità di ricostruire unitariamente un senso e una prospettiva di umanità, oggi più che mai urgenti».
Le direzioni e le redazioni de Il Fatto Quotidiano e Ilfattoquotidiano.it partecipano al lutto del collega Tommaso Rodano per la perdita della cara nonna.
(Il Fatto Quotidiano, 2 dicembre 2023)
di Franca Fortunato
Le manifestazioni oceaniche della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne hanno visto – come nei giorni precedenti nelle università e nelle scuole – ragazze e ragazzi partecipare in massa, in risposta non tanto alla chiamata delle donne di Non Una di Meno, quanto all’appello della sorella di Giulia, Elena, che ha saputo trasformare il suo dolore e la sua rabbia in forza personale e collettiva. Nonostante il dolore per l’orrenda uccisione di Giulia, di fronte a quella marea mi sono sentita “felice”, come ho confessato con “pudore”, per paura di non essere capita, all’incontro tenuto quel giorno alla libreria “Non ci resta che leggere” di Soverato (CZ), organizzato dal gruppo donne di “Cittadinanzattiva”, ai cui incontri partecipo da un po’, invitata da Francesca Labonia, mia amica e cofondatrice del gruppo. La mia felicità nasceva nel vedere insieme tante ragazze che il femminismo ha cambiato dando loro consapevolezza dell’inviolabilità del proprio corpo. La mia felicità nasceva nel vedere come, grazie alle ragazze, siano cambiati anche tutti quei ragazzi che manifestavano con loro, rompendo così, in modo irreversibile, la complicità maschile che è dura a morire in quei padri che si affrettano a difendere i propri figli accusati di violenza sessuale, delegittimando e screditando le ragazze che li accusano per renderle non credibili. È questo un comportamento patriarcale che generazioni di donne hanno subito e che oggi quelle ragazze e quei ragazzi, eredi delle loro madri, non accettano più. Quanta dignità, invece, nel dolore e nella tragedia hanno dimostrato i genitori dell’assassino di Giulia rifiutandosi, per il momento, di incontrare il figlio omicida in carcere! La mia felicità mi ha riportata a quella provata quando ho incontrato il femminismo della differenza che mi ha cambiato la vita e quando ho letto nel 1996 il Sottosopra “È accaduto non per caso”, un documento scritto dalle donne della Libreria di Milano con cui annunciavano: «Il patriarcato è finito, non ha più il credito femminile ed è finito […]. Adesso è un altro tempo e un’altra storia». Ecco, mi sono detta quel giorno, l’altro tempo e l’altra storia, il tempo e la storia della libertà femminile, in cui quelle ragazze sono nate, oggi è anche il loro tempo e la loro storia. Quello che è accaduto il 25 novembre non è accaduto per caso ma è frutto anche del lavoro delle donne che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, si sono autorizzate a portare dentro la scuola il sapere e le pratiche del femminismo della differenza, rivoluzionando i saperi, la lingua e il rapporto con colleghe/i e alunne/i. Mi riferisco alla mia esperienza e di tante donne come me e di quelle a me maestre nella “Pedagogia della differenza” e al movimento dell’“Autoriforma gentile” nelle scuole e nelle università che ha coinvolto anche uomini. Di quel sapere e di quelle esperienze c’è un tesoro di libri a cui donne e uomini possono accedere per il loro insegnamento. Esperienze, figlie di un tempo nuovo che hanno dato inizio a una nuova storia, dando senso a scuola all’essere donne e scoprendo il piacere dell’insegnare e dell’imparare. Da ripetitrici e trasmettitrici di un sapere e di una lingua che cancellano noi donne, siamo diventate protagoniste e produttrici di nuovo sapere, nuove pratiche educative, nuovo linguaggio nel rispetto della differenza sessuale, in un rapporto relazionale tra chi insegna e chi impara. Si educa alla relazione praticandola. Oggi, in un continuum materno da madre in figlia, sono le ragazze e le giovani donne a insegnare la sessuazione dei saperi e del linguaggio, come ho visto fare nel gruppo “Cittadinanzattiva” da alcune di loro. Come non essere felice?
(Il Quotidiano del Sud, rubrica “Io, donna”, 2 dicembre 2023)
di Roberta De Monticelli
È questa settimana in libreria “J’Accuse”, un libro di Francesca Albanese – relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati – in conversazione con Christian Elia (Fuori Scena, RCS) che offre in sette brevi capitoli un glossario per capire che cosa è successo in Palestina e in Israele. Pubblichiamo un estratto della postfazione.
Gaza non c’è più – è solo un ammasso di dolore e rovina. Un’apocalisse è in corso, in tutti i sensi della parola. Una rivelazione, soprattutto. Non solo degli estremi di cui siamo capaci quando i vincoli del diritto e della civiltà sono violati. Ma anche dell’altra faccia della splendida luna di Israele, la faccia che era nell’ombra: la Palestina. Ora l’altra faccia della luna, tremenda, è nella luce della nostra coscienza, a dispetto del taglio totale di elettricità e connessioni imposto – come se solo la tenebra potesse essere testimone di un sacrificio umano così senza limiti e senza senso. E invece mai così visibile, mai così scoperchiata in tutta la sua tragedia, è oggi la storia intera della nascita e della crescita di Israele nella terra che fu la Palestina storica, delle vie che la costruzione di quello stato ha imboccato e sempre più sistematicamente perseguito, del dolore che queste scelte, non inevitabili, hanno causato: dal lato oscuro della luna soprattutto, ma anche dal lato lucente, in uno stillicidio di veleno e morte. Un dolore che oggi giunge al suo insopportabile zenit.
Dice un grande scrittore che un libro deve essere «un’ascia per rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi» (Franz Kafka). Questo J’Accuse dovrebbe essere un’ascia del genere per ciascuno di noi. Che sia almeno uno scalpello sottile, un cesello addirittura, che con la lama del diritto incida nella profondità della memoria, perché possiamo imparare che terribile cosa sia stata la nostra indifferenza fino ad oggi, e come ogni giorno del nostro ignorare la faccia oscura della luna, ogni ora del nostro silenzio, abbia portato un po’ di energia alla bomba atomica del male che ora sta distruggendo la nostra umanità, insieme ai corpi degli innocenti.
Lo scritto che avete in mano discende direttamente dall’ufficio di un «funzionario dell’umanità»: perché tale, nella sua indipendenza che lo solleva al di sopra dei funzionari stipendiati, è una relatrice speciale delle Nazioni Unite, e ben si adatta al suo ruolo questo appellativo che Edmund Husserl riservava agli eredi di Socrate.
Questo J’Accuse è scritto in nome degli ideali e delle corrispondenti norme e istituzioni che la comunità internazionale si era data per prevenire e spegnere le guerre; perché dov’era la selva geopolitica delle potenze sedesse il governo della legge, il diritto internazionale e i suoi organi di garanzia; perché dov’erano le radici di sangue e di terra delle nazioni scendesse il balsamo della ragione, e tutti noi ricordassimo le radici di carta e pensiero piantate in noi per sostenere la nostra umanità al di sopra degli strati di risentimento, dolore, impunità e violenza che ci salgono ormai alla gola.
Forse è ancora possibile. Che il dono dei vincoli di ragione, accolto dalla parte migliore della tradizione umanistica e della filosofia e infine dalla comunità internazionale, prevalga: e sventi questa ulteriore catastrofe del mondo globale di cui l’Europa annunciò, con le sue guerre novecentesche, l’avvento. Perché ciò che separa, nel mondo intero, il sottilissimo strato di civiltà per cui soltanto possiamo dirci umani dal sottostante oceano di stupidità e ferocia che ci minaccia, è solo l’impegno a brandirle, le carte di cui queste radici sono fatte, invece di brandire le armi.
Che vuol dire: rianimarle del nostro soffio, queste carte e questa lettera che solo lo spirito fa viva. Rianimarle del soffio per cui soltanto l’ideale eccede sul reale, e il valore sul fatto – e soprattutto la ricerca, il dubbio, la veglia critica e la trasparenza logica eccedono sul dogma, l’urlo tribale, la furia ideologica. Eccedono, vuol dire: non si lasciano ridurre a. Eccedono, solo per un soffio. Senza questo soffio, la nostra umanità è perduta. Mi pare che a questo bivio siamo, oggi.
(Il manifesto, 1° dicembre 2023)
di Antonella Nappi
Sono stata alla manifestazione di Milano il 25 novembre contro la violenza sulle donne con un cartello che diceva l’opposto di ciò che molte dicono e scrivono, e alcune sostengono anche in ambiente universitario: che il movimento LGBTQ+ ci rappresenta tutte e tutti. Insinuando così un potere di rappresentanza che mi è odioso perché pensiero del tutto maschile. È una violenza per me insopportabile, ora che ho imparato a riconoscere la violenza che non è Legge da imparare. Ho impiegato cinquant’anni a riconoscere la violenza che da bambina mi sembrava la Legge familiare o sociale che dava il giusto apprendimento. La devo additare e combattere!
Mi preoccupa grandemente che si manchi di elaborazione riflessiva nella protesta e che la si dia in mano al maschilismo mediatico, il maschilismo sempre vincente nella politica rappresentativa, che sia nei parlamenti o nelle strade. C’è invece una disponibilità piacevolissima nelle persone meno giovani e meno organizzate a considerare la violenza della politica, quella dell’economia.
La piazza di Milano il 25 novembre era immensa e molto pacifica, molto riflessiva nella disposizione a considerare la violenza contro le donne; la stessa disposizione che in questi anni considera la violenza della guerra in tutti i luoghi dove i conflitti economici e politici non sono analizzati e gestiti da pratiche di contrattazione verbale e diventano distruzione e morte. Era una piazza piena di giovani padri e madri con bambini. Quella popolazione che fa lo sforzo della comunicazione tra differenti e ci fa progredire, quella su cui investire.
Lì mi erano tutti amici, il mio cartello era il loro, per questa ragione dico che c’è un potenziale di capacità di dirsi ed essere solidali enorme, non buttiamolo nel fosso della contestazione non sapiente. Nel fosso di quell’esasperare l’inimicizia verso la scienza e la politica, solo perché l’economia le influenza e investe la sua potenza nel far sì che si prendano gioco di noi; dobbiamo distinguere tra la scienza e la politica asserviti al guadagno illimitato e quelle con le quali possiamo comunicare e che ci giovano.
Il mio cartello diceva:
«La più grande violenza contro le donne e i bambini è usare corpi di donne per diventare padri di figli a cui si nega la madre. È violenza patriarcale.
Gli uomini devono riconoscere l’altro da sé: le donne.
Con la storia di silenzio e censura che abbiamo noi donne, privarci della desinenza in -a, che da pochi anni ci dava visibilità, è un crimine politico. Chiunque voglia dare visibilità ad altre censure usi la stelletta o altro, ma in aggiunta alla -a, non in sostituzione, così dimostrando di non voler cancellare le donne.
Noi donne non siamo a disposizione degli uomini, non usate il nostro nome: il femminismo è interesse a valorizzare le donne. Non ci lasciamo cancellare.»
(www.libreriadelledonne.it, 1° dicembre 2023)
di Redazione Meduza
È nato un movimento dal nome “La strada di casa” che si sta diffondendo in tutta la Federazione russa. Le donne denunciano la drammatica condizione di un paese in cui in nome della stabilità e della sicurezza tanti giovani non fanno più ritorno a casa. Si sentono beffate dalla propaganda di regime che ha annunciato il 2024 come “anno dedicato alla famiglia”. Quale famiglia si può festeggiare se i padri, i fratelli, i figli, i nipoti non tornano?
Podcast del 15 novembre 2023 sul sito del quotidiano Meduza in lingua russa, con sede a Riga in Lettonia.
(Laura Minguzzi)
Come combattono le mogli e le madri dei coscritti russi per il ritorno a casa dei loro cari? E questo movimento può essere considerato contro la guerra?
«Il 7 novembre, diverse decine di mogli di mobilitati per la guerra in Ucraina hanno organizzato un presidio chiedendo il ritorno a casa dei loro mariti. Successivamente, proteste simili sono state organizzate in tutto il paese. Ora in diverse regioni della Russia le mogli dei mobilitati si trovano ad affrontare la pressione delle forze di sicurezza, scrive “Storie importanti” (rubrica della rivista Verstka). Al momento, è noto che nella regione di Kemerovo e nel territorio di Krasnoyarsk la polizia si reca dalle famiglie dei mobilitati o le convoca [per diffidarle].
In precedenza, nel luglio 2023, il “Consiglio delle madri e delle mogli”, organizzato dalle parenti dei mobilitati e dei coscritti, aveva cessato l’attività. Pochi mesi prima, le autorità avevano iscritto la fondatrice dell’organizzazione, Olga Tsukanova, e lo stesso “Consiglio delle madri e delle mogli” nel registro degli “agenti stranieri”. Le partecipanti al “Consiglio” avevano chiesto al comando militare della Federazione Russa di risolvere i problemi dell’equipaggiamento dei mobilitati* e della coscrizione illegale**. Inoltre, avevano cercato di ottenere un incontro con Putin. Il Cremlino al contrario ha organizzato un incontro con donne rappresentanti del governo».
Nel podcast si parla di come le donne in Russia cerchino di riportare a casa dal fronte i loro mariti e figli e di coloro che le contrastano.
Ospiti della trasmissione sono Anna Ryzhkova e Daria Kucherenko, giornaliste della testata Verstka.
(*) I soldati mandati al fronte non vengono forniti di uniformi, armi e attrezzature, ma sono costretti a comprarsele di tasca propria [Ndr].
(**) Vengono arruolati come soldati e mandati illegalmente al fronte anche uomini che fanno parte di categorie protette che secondo la stessa legge russa non possono essere mandate in combattimento [Ndr].
Qui il podcast in lingua originale del 15 novembre 2023. Durata: 45 minuti
(Quotidiano in lingua russa Meduza, https://meduza.io/,16 novembre 2023)
di Graziella Balestrieri
Intervista di Graziella Balestrieri a Maria Luisa Boccia pubblicata su “L’Unità” del 25/11/2023.
Il femminicidio di Giulia ha innescato una rivolta da parte delle giovani e dei giovani, che chiedono una risposta politica e culturale profonda. Al contrario, i media non accolgono le istanze del discorso femminista e la sinistra si limita a soluzioni normative senza proporre linguaggi o rappresentazioni diverse della società.
Dopo il femminicidio di Giulia sono aumentate le chiamate al 1522, qualcosa sta cambiando?
Questo femminicidio ha provocato una reazione forte e diffusa tra le giovani e i giovani, credo anche per la posizione forte e molto efficace della sorella Elena, che è una di loro, una di quelle generazioni, e che ha detto delle cose decisive e fondamentali ovvero che l’assassino, Filippo, è un uomo normale, il figlio sano del patriarcato. E questo, secondo me, in qualche modo ha provocato quella reazione, di rottura, di ribellione molto forte: non più il silenzio ma fare rumore, i versi «se domani sono io, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima», che significano dire basta. Una reazione politica di rivolta – per usare un termine forte del femminismo delle origini, di Carla Lonzi – che è quell’atto di presa di coscienza individuale che poi diventa collettiva e questo si esprime anche con l’atto della denuncia. Anche la denuncia è un segno di questa rivolta, se trova terreno politico su cui si motiva e si trova anche la volontà di reagire. Non sono così convinta che si abbia fiducia nella capacità di risposta alla denuncia da parte delle istituzioni, di chi deve poi appunto intervenire rispetto alla denuncia. Spesso si continua a pensare che il problema sia il vuoto normativo quando invece il problema è il vuoto operativo cioè: delle norme poi cosa facciamo? Come le applichiamo? C’è la sensibilità alla preparazione, gli strumenti, il rapporto con la rete, per esempio, delle operatrici che rendono effettive anche le norme oppure no? È lì che bisognerebbe intervenire per dare una risposta, invece mi pare che di questo non si parli proprio.
Figlio sano del patriarcato: chi è nella società di oggi?
Sono gli uomini, non c’è da costruire l’identikit del criminale o del patologico, come spesso si fa. No, è la normalità, la violenza anche nelle sue forme estreme più efferate come sono molti femminicidi, anche questo di Giulia lo è, via via che emergono i dettagli è sempre più terrificante il comportamento del femminicida. È una normalità, sono uomini che diventano violenti, perché è nella loro identità maschile, nella sessualità maschile è iscritto il possesso del corpo della donna, che segna la storia millenaria dei rapporti tra i sessi. E si trovano di fronte all’imprevisto della libertà femminile, di una donna che non si adegua, non consente quella modalità. Questo è ciò che è avvenuto, il fatto nuovo, l’evento imprevisto è la libertà femminile che prende le forme più diverse. E non parlo di diritti, parlo proprio dell’attitudine e della predisposizione della donna a seguire sé stessa, a non adattarsi, a non adeguarsi a quello che è previsto, alla normalità cosiddetta dei rapporti tra i sessi, il rapporto affettivo, sessuale… Questo ha messo in crisi non solo le strutture, le culture, ma dall’interno ha messo in crisi i singoli uomini e questo produce diffondersi anche di violenza. È la crisi del patriarcato, è il disordine che produce il di più di violenza.
Perché l’uomo ha paura di una donna libera?
La sua identità è costruita sul possesso. Carla Lonzi parla di patologia possessiva, la donna come primo oggetto del possesso, e la riconosce proprio nella modalità della pulsione e del coito, della forma di realizzazione del piacere, penetrare è possedere e queste sono strutture profonde radicate nell’inconscio. Poi l’immaginario, la rappresentazione, ma ancora di più il discorso pubblico che tendono a ribadire che la famiglia è solo una cosa, che le identità sono quelle, che l’uomo deve corrispondere a quei canoni e la donna a quegli altri. Nelle relazioni sociali, politiche, economiche, sessuali, personali non viene acquisito un principio fondamentale che è quello della differenza, di rivolgersi all’altro e all’altra come differente, prestando attenzione e ascolto a quello che è differente. Quando si scompagina l’ordine che presumiamo naturale si producono anche queste forme di violenza, per questo per affrontarle ci vuole una capacità di lavorare sul terreno politico e culturale, sul terreno del linguaggio, dell’immaginario, delle rappresentazioni, del simbolico prima che su quello delle leggi, tanto più se vengono intese nella dimensione securitaria e punitiva. Gli uomini non sanno come rapportarsi, certo non tutti arrivano alla violenza o all’uccisione però…
Molti danno responsabilità alla scuola…
Stiamo parlando di una questione molto complessa che ha varie facce e coinvolge i rapporti tra generazioni in tutte le dimensioni. Se vogliamo cominciare da quelle fondamentali, sono la famiglia e la scuola. Però prima di mettere l’una contro l’altra dovremmo fornire sia alle famiglie, sia agli educatori degli strumenti, dei materiali. Se i libri di testo rimangono quelli che sono, la storia che studio, la letteratura, le scienze rimangono quelle che sono, l’educazione affettiva è come una goccia nel mare. Dovremmo intervenire, ma non è cosa che si fa in un giorno.
La figura della Presidente Meloni…
La Meloni sul piano pubblico si conforma al maschile, sul piano personale, privato «io sono una donna, sono una madre, sono italiana» ho una famiglia tutta femminile, risponde alla femminilità in pieno. Quindi femminile dove è previsto che devi essere femminile, tradizionale al 100%, quindi nel privato, uniformata al sistema maschile nel pubblico. L’ideologia Dio, Patria e famiglia è un’ideologia di restaurazione. C’è una spinta regressiva a ritornare ad un ordine tradizionale, i cui pilastri sono appunto Dio, Patria e famiglia.
E i social?
Colpire con le parole, con le immagini oggi è molto più diffuso. Però insisto: anche lì, una cosa sono le forme di controllo, ma altra cosa invece è intervenire per una maggiore consapevolezza, investire sul linguaggio dell’immaginario e del simbolico. È più complicato però è più efficace, c’è tanta produzione di un linguaggio differente da parte delle donne e non solo, tante soggettività, perché non raccoglierle? Perché nel mainstream non si dà spazio a queste presenze, queste voci? Ne vede di femministe che hanno pensato, elaborato, scritto nel mainstream? Nei media, nei giornali, poche… Eppure questa presenza migliorerebbe la qualità dei rapporti di tutti. Il femminismo vuole restituire le relazioni alle soggettività, differenti e plurali.
La sinistra invece?
La sinistra italiana è completamente afona su questo. Non sanno far altro che pensare a qualche norma, perché diciamolo: la sinistra dove è che si impegna a produrre, a creare nella società una cultura, un linguaggio, una rappresentazione diversa? A costruire un proprio discorso culturale? non lo fa più. Non ha più gli strumenti, non ha i luoghi. Non c’è una stampa funzionale a questo, una produzione di libri, anche proprio quell’attività che si faceva nella società, nella costruzione dei rapporti, della presenza dei soggetti politici nella società. Se dovessi dire quale sarebbe il punto di vista della sinistra non strettamente politico, ma su quale rappresentazione di una società di uomini e donne libere e differenti hanno, io non saprei con chi confrontarmi, non le so dare un riferimento di un testo, di un convegno, io non ce l’ho tutto questo da parte della sinistra.
Il 25 novembre in piazza cosa si aspetta?
Potrebbe esserci una maggiore presenza dei giovani e delle giovani, e questa è una cosa molto positiva e mi auguro anche che siano presenti più uomini in modalità di attenzione e rispetto per la presenza e il mondo femminile.
(crs.it, 30 novembre 2023)
Testo di Ida Dominijanni
Disegni di Pat Carra
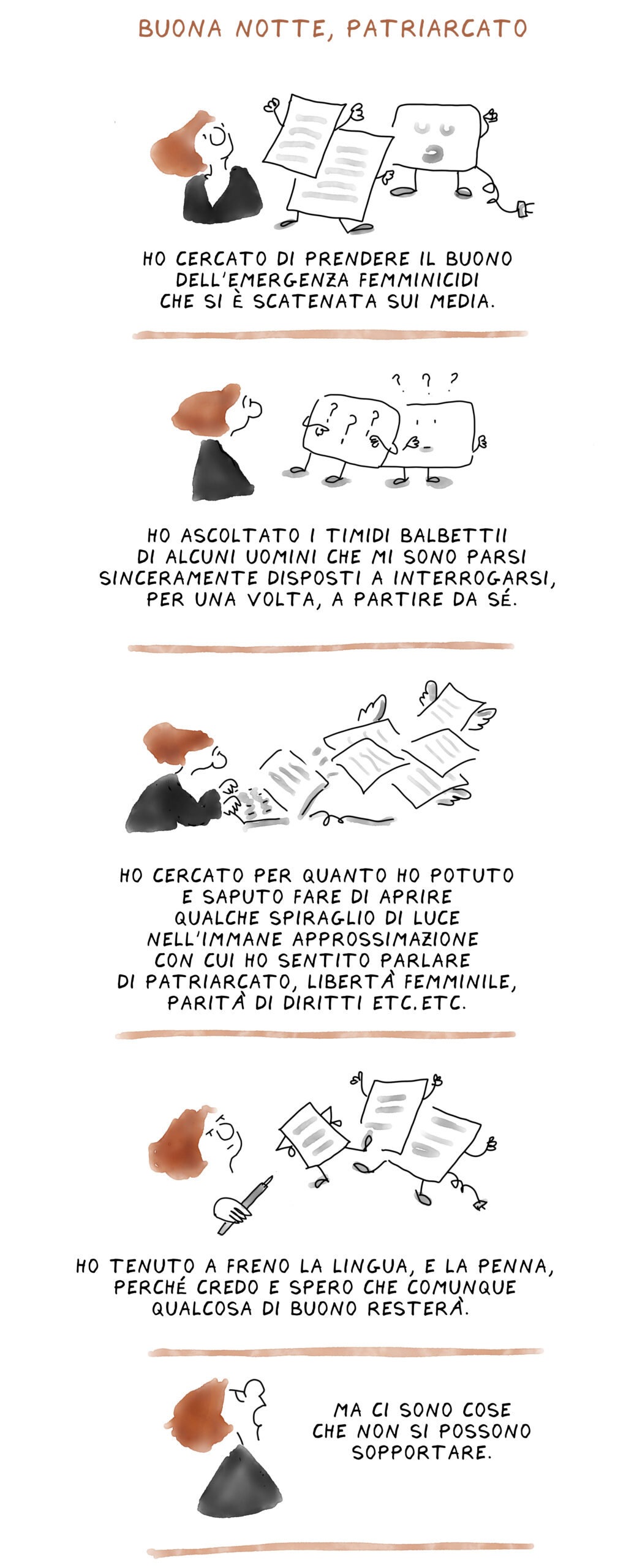

Erbacce, 28 novembre 2023
Leggi Il campo di battaglia del patriarcato vacillante di Ida Dominijanni qui.
di Elsa Fornero
«Siamo libere, e nessuno può toglierci questa libertà, nessuno può pensare che siamo nel loro possesso», ha postato Giorgia Meloni a proposito della tragica morte di Giulia per mano del giovane che pretendeva di amarla. Più poeticamente, Charlotte Brontë, nata nella brughiera dello Yorkshire da un severo pastore protestante e da una mamma morta al sesto parto, fa dire a Jane Eyre: «Non sono caduta in nessuna rete; sono un essere libero, con una volontà indipendente». Giorgia ha acquisito la sua libertà non soltanto con la forza della volontà ma anche impegnandosi in politica, e ricevendone un reddito. Charlotte l’ha conquistata scrivendo libri e racconti, anch’essa ricavandone introiti. Giulia, decisa e consapevole, aveva intrapreso un duro percorso di studio per ottenerla. Ha pagato il prezzo più alto.
Gli esempi sono moltissimi, la conclusione è una sola: la libertà non si conquista senza l’indipendenza economica e questa a sua volta si ottiene con il lavoro. Senza l’indipendenza economica femminile, gli uomini mantengono potere sulle donne, limitandone – poco o tanto, secondo la loro educazione e la loro indole – i gradi di libertà. Che si tratti di padre, marito, compagno, fratello, è ancora troppo spesso un uomo a decidere – o a pretendere di decidere – per una donna, relitto di un passato in cui la forza fisica faceva premio sulle capacità intellettuali e dove il dominio maschile era accettato (o subito) in cambio di protezione, arrivando a giustificare la violenza in caso di “rottura” del “contratto implicito” da parte della donna e perciò di offesa all’onore maschile. Una maschera, in realtà, della paura maschile di essere inadeguati, di non saper gestire una relazione paritaria. Spesso dimentichiamo le battaglie del passato troppo presi dai rigurgiti violenti dell’incultura della superiorità maschile, della (presunta) “inadeguatezza” delle donne a decidere in libertà della loro vita. E ricordiamo allora Angela Bottari, prima firmataria nel 1981 della legge che abrogò il “delitto d’onore” e il “matrimonio riparatore”, da poco scomparsa.
Oggi le donne reclamano il principio costituzionale di uguaglianza, nei rapporti affettivi nella famiglia, nelle istituzioni, nella società. Ma quante donne possono oggi dire di avere quell’indipendenza economica che è il presupposto della loro libertà? Certo, nell’istruzione – che è la premessa per l’occupazione – le donne hanno, pian piano, conquistato il primato (ci sono più laureate che laureati e con voti mediamente più elevati); la parità, però, non è ancora raggiunta nelle discipline più scientifiche, non per inadeguatezza ma per sottili “consigli” a seguire percorsi di studi più “adatti alle donne”, secondo pregiudizi diffusi. Questi percorsi formativi, però, sono più avari di posti di lavoro, soprattutto di quelli ben remunerati. L’occupazione femminile in Italia è in drammatico ritardo rispetto ad altri paesi europei e con forti divisioni interne e, nonostante le norme a presidio della parità salariale, i dati confermano la persistenza del divario salariale di genere, a dimostrare che le norme non bastano se poi non seguono i comportamenti.
Il mondo del lavoro è stracolmo di sottili discriminazioni nei confronti delle donne, magari esercitati dietro una patina di gentilezza come quando, in occasione di una competizione per un incarico lavorativo o una promozione, dopo che la scelta è caduta su un uomo, alla donna sconfitta viene detta la frase “in fondo, tu sei moglie e madre”. Come se l’ambito familiare debba essere il luogo di massima aspirazione femminile, per il quale vale la pena sacrificare l’autonomia di una carriera di lavoro. In moltissime occupazioni, la gestione delle risorse umane o anche semplicemente la stratificazione gerarchica si traducono in differenziazione delle opportunità ed è quasi “normale” che una donna, pur svolgendo sostanzialmente gli stessi compiti di un uomo, magari sotto l’etichetta solo formalmente diversa, sia meno retribuita del collega.
Un’opinione deleteria ancora molto diffusa è che l’occupazione delle donne vada a scapito di quella maschile. Vi sono due obiezioni a questa tesi. La prima è di logica economica: non vi è alcuna ragione per la quale il mondo del lavoro debba funzionare a numero fisso di posti. Piuttosto ci si deve chiedere quale configurazione del mercato del lavoro e dei suoi rapporti con il mondo dell’istruzione e della formazione professionale e quali norme, quali servizi pubblici possano favorire, anziché ostacolare, l’obiettivo della piena occupazione. Non è possibile continuare a considerare le donne in generale (e i giovani) segmenti deboli del nostro mercato del lavoro. La debolezza non è loro, ma della società che nutre tali concezioni e che, paternalisticamente, offre spesso compensazioni a posteriori (vedasi pensione di reversibilità un tempo assai generose) per discriminazioni a priori.
La seconda ragione è empirica: là dove il tasso di occupazione femminile è più alto, è più elevato anche quello degli uomini. Lo dimostrano i dati dei paesi del Nord Europa, caratterizzati da una visione inclusiva e non sostitutiva del lavoro femminile; da noi, la stessa correlazione positiva si ritrova nelle regioni/province (tipicamente nel Nord-Est del paese) nelle quali le politiche attive funzionano meglio.
È possibile, infatti, una visione del mondo del lavoro diversa, dove i giovani, le donne e, anche le persone meno giovani, alle quali pensiamo spesso soltanto in termini di pensionamento anticipato, possano trovare occasioni di lavoro dignitoso, adeguatamente retribuito. Si tratta di cambiare paradigma, di cambiare la nostra visione del mondo del lavoro; di affermare concretamente il principio costituzionale del diritto al lavoro e, attraverso di esso, il valore sociale, oltre che individuale, dell’indipendenza economica delle donne, come base di un’eguaglianza più grande. Non è facile, ma ci si deve provare. L’occasione offerta dal Pnrr, sotto questo profilo, non va mancata, Giorgia.
(La Stampa, 27 novembre 2023)
di Pinella Leocata
Catania. Una passeggiata lungo i luoghi delle varie realtà femministe che, nel corso di cinquant’anni, hanno segnato il tessuto e la realtà cittadina con il loro pensiero e le loro pratiche improntante all’autocoscienza, al partire da sé, dal proprio corpo, dai propri bisogni e desideri. Pratiche che hanno sfumature diverse – e proprio per questo sono ulteriore espressione di ricchezza – e che hanno contribuito e contribuiscono a un cambio di cultura segnato dai valori dell’uguaglianza, del rispetto delle differenze e della libertà, della centralità delle relazioni di cura. Una cultura che si contrappone a quella segnata dalla violenza e dalla sopraffazione in tutti gli aspetti della vita, economici, lavorativi, istituzionali, privati, amorosi. Perché “Il privato è politico”. È la cultura delle donne, delle femministe. Una cultura che prelude e tende a un cambio di civiltà cui, adesso, sono chiamati a concorrere anche gli uomini.
Un 25 novembre insolito, quello di ieri, dedicato all’iniziativa promossa dalle femministe de La Città Felice e La Ragna-Tela ed estesa alle altre realtà femministe cittadine e al coordinamento donna della Cgil. Una passeggiata alla riscoperta dei luoghi, ormai storici, del femminismo catanese, quelli del passato e quelli attivi ancora oggi. Un modo per contrapporre «alla violenza maschile e a quella istituzionale, la bellezza e la pienezza dei luoghi cui hanno abitato e abitano le pratiche e le politiche femministe che continuano a trasformare la città». «Pratiche – sottolinea Anna Di Salvo che guida la passeggiata – che hanno contribuito a un reale cambiamento della città cui hanno impresso un sentire da donna, anche nel pensare l’urbanistica, l’abitare, la convivenza con gli uomini».
Si parte da via Santa Maddalena 59, in un antico palazzo di fronte uno degli ingressi della Villa Bellini, dove aveva sede – a pochi passi dalla vecchia sede della facoltà di Scienze Politiche – il collettivo “Differenza Donna”, uno dei primi gruppi di autocoscienza e uno dei primi a porsi il problema delle politiche femministe in una prospettiva diversa da quella dell’MLD (Movimento di liberazione della donna) che si poneva soprattutto il problema del corpo e dell’aborto. «Qui – ricorda Emma Baeri Parisi che era una delle animatrici di “Differenza Donna” – praticavamo nuovi pensieri e nuove pratiche, dall’autocoscienza al parlare a partire da sé. Ci incontravamo tutti i giovedì, mentre il venerdì questo spazio era aperto a tutte le donne».
Seconda tappa in via dei Crociferi 40, sede della Cgil, dove si apre il “Centro donna Elvira Colosi”, un centro di ascolto delle problematiche delle donne, dalla violenza allo stalking, alle discriminazioni sui luoghi di lavoro. Ci sono consulenti esperti ed è collegato a una rete di associazioni, servizi sociali e al centro antiviolenza. È aperto martedì, dalle 9,30 alle 12,30, e venerdì, dalle 16,30 alle 18,30, tel. 095/7198111. Qui la femminista Carmina Daniele ha letto alcune pagine struggenti del testo “Ferite a morte” di Serena Dandini.
Ulteriore tappa in via Caff 21 dove hanno sede La Ragna-Tela e La Città Felice, nata nel 1993 dal precedente gruppo Le Lune. Realtà femministe che attingono alle pratiche della Libreria delle donne di Milano e della comunità filosofica Diotima di Verona improntate all’autocoscienza, all’inconscio e al partire da sé. Qui è in corso anche una ricca attività di confronto e di scambio con alcuni uomini che rifiutano la cultura patriarcale e la violenza cui è improntata e che vogliono percorrere insieme il cammino verso un cambio di civiltà. La sede, che è anche un luogo d’arte dove ci si confronta su libri e argomenti d’attualità, è aperta ogni martedì alle 17.
E ancora il ricordo dei luoghi del femminismo delle origini. Piazza Spirito Santo 4, dove dal 1980 al 1985 aveva sede il “Coordinamento autocoscienza donna” che cominciò a elaborare il pensiero femminista. E poi via Corridoni 24/b, di fronte al cinema Odeon, dove nel 1987 c’era la sede del “Se-No” del collettivo Le Lune dove le donne – eterosessuali e lesbiche – s’interrogavano sulla complessità portando avanti la pratica del separatismo. Ma la mappa dei luoghi femministi include tanti altri luoghi che saranno oggetto di ulteriori passeggiate che seguiranno, così come un convegno su questo tema dove sarà possibile leggere e conoscere molti documenti elaborati nei primi anni del femminismo catanese.
(La Sicilia, 26 novembre 2023)
di Alessandra Sarchi
Il 3 ottobre 2020 inaugurò alla National Gallery di Londra un’imponente mostra dedicata ad Artemisia Gentileschi (Roma, 1593 – Napoli, 1653 circa) a cura di Letizia Treves; era la prima monografica mai dedicata a un’artista donna dalla prestigiosa istituzione londinese. Non era peraltro isolata, numerose altre nel corso degli ultimi trent’anni si erano susseguite e altre ne sarebbero venute, sparse per i musei europei, come ad esempio quella da poco aperta al Palazzo Ducale di Genova a cura di Costantino D’Orazio.
La crescente fortuna critica di questa pittrice che nel 1916, quando Roberto Longhi le dedicò un articolo insieme al padre, il ben più noto Orazio Gentileschi, contava un catalogo che non superava la decina di dipinti, mentre oggi è quasi decuplicato (come il loro prezzo peraltro), è intrecciata a doppio filo a quella del romanzo a lei dedicato da Anna Banti, uscito nel 1947 e ora ripubblicato da Mondadori per la cura di Daniela Brogi che firma un’introduzione e un saggio finale accompagnato da immagini di alcune opere pittoriche, impegnandosi in un corpo a corpo con le due facce di quest’erma bifronte: la biografia romanzata di una pittrice e l’invenzione-rivelazione della scrittrice Anna Banti, nata Lucia Lopresti, coniugata Longhi (Firenze, 1895 – Massa, 1985).
Fin dall’incipit – «Non piangere» – le due voci sono infatti sovrapposte: quel tu poetico che interpella il lettore si rivolge tanto alla scrittrice Anna Banti, che ha perso il primo manoscritto del romanzo nei bombardamenti su Firenze, fra il 3 e il 4 agosto 1944, quanto alla ragazzina di grandissimo talento che nel 1612 dovette sostenere un processo per lo stupro subito da Agostino Tassi, il pittore al quale il padre Orazio l’aveva affidata per migliorare la sua arte.
L’alternanza fra queste due voci, il loro frammentario parlarsi in controcanto fino a fondersi talvolta, insieme alla temporalità mai lineare sempre tesa fra presente e passato, costituiscono alcuni elementi con cui Banti costruisce un romanzo che a pieno titolo Brogi definisce modernista e anticipatore di molti dispositivi narrativi in cui l’io si parcellizza e si sdoppia, nelle acrobazie della biofiction o autofiction che tanto successo hanno goduto in tempi recenti.
«Artemisia è il nome di una pittrice, dunque; è il titolo di un libro; è il simbolo di battaglie contro la violenza sulle donne; è, infine, il nome di una finzione romanzesca. Artemisia però non è un saggio, né un romanzo storico e nemmeno una biografia classica, ma un testo di invenzione in cui si rielaborano documenti d’archivio studiati direttamente, intrecciandoli a competenze storiche, letterarie e critiche», scrive Brogi con una sintesi che è già strumento di lettura tanto del romanzo quanto della figura di Banti, ingiustamente lasciata ai margini del canone letterario. Artemisia non fu un esordio per Banti, ma il romanzo in cui sigillò quella che divenne poi la sua cifra peculiare: «Scrivere di quello che la Storia tace a sé stessa». Utilizzare tutto il bagaglio della sua formazione storico-artistica per attraversare il tempo, restituire voce a una pittrice poco conosciuta come Artemisia o ai garibaldini della spedizione dei Mille in Noi credevamo (1967).
Quanto debba essere stato faticoso e ostile il passaggio dalla storia dell’arte, e dal ruolo di moglie del celebre Roberto Longhi, a quello di scrittrice in proprio si capisce dall’ultimo libro di Banti, Un grido lacerante (1981). Ma è proprio la consapevolezza di come il genere sia decisivo per una donna, nella lotta per l’affermazione di un linguaggio proprio e di una carriera artistica, ciò che Banti trasferisce dalla sua esperienza a quella di Artemisia, rendendola viva ai nostri occhi. E se è vero, come ricorda Brogi, che la vicenda dello stupro viene fornita fin da subito nell’avvertenza al lettore: «Oltraggiata, appena giovinetta, nell’onore e nell’amore. Vittima svillaneggiata di un pubblico processo di stupro», scrive Banti, è altrettanto vero che la scrittrice decide con una efficacissima ellissi di non raccontare nei dettagli stupro e processo, pur avendone lei stessa trascritto le carte nel 1939. Felice scelta stilistica, tanto più apprezzabile se confrontata con la centralità voyeuristica e distorta data alla vicenda nella versione cinematografica di Agnès Merlet, Artemisia. Passione estrema (1997) o nel romanzo di Susan Vreeland, La passione di Artemisia (2002).
Banti muove, viceversa, dalla precisa intenzione di dare una forma al destino e alla vocazione della pittrice che non fosse schiacciata dalla violenza patita: Artemisia infatti non se ne fece schiacciare, ma seppe attraversarla e rielaborarla, e non dovette essere facile per una giovane donna marchiata dalla vergogna e dalla riprovazione sociale. Il dipinto, ora a Pommersfelden, Susanna e i vecchioni, un tema su cui la pittrice tornò più volte, le due versioni della Giuditta e Oloferne, ora agli Uffizi e a Capodimonte, esprimono questo attraversamento della violenza, subita in prima persona e incistata in una società in cui, a quattro secoli di distanza – commenta Brogi – «il paradigma storico culturale e simbolico che equipara prepotenza e virilità è ancora in piedi». Un confronto con i medesimi soggetti trattati da artisti uomini, Caravaggio ad esempio, ci dà la misura di quanto lo sguardo maschile sfumi i contorni della violenza, idealizzando il corpo femminile, mentre Artemisia fa vibrare il sangue, la ripulsa, la paura; nella sua pittura le storie delle eroine bibliche diventano storie quotidiane delle donne.
Banti con acuta cognizione di causa rifugge la prosa d’arte e le descrizioni ecfrastiche, viceversa ricostruisce il lavorio incessante dello sguardo pittorico di Artemisia in brani come questo: «Una bella occasione, questa lucerna, recata a mano da una donna bianca e bionda, che a ogni passo forma un’ombra bizzarra: un’occasione da studiarci allo specchio per esercizio di quella pittura che oggi tanto incontra, di Gherardo Fiammingo». E ci mostra l’asperità di comporre un racconto non risolvibile in dicotomie scontate (il genio e il trauma, la vittima e la riscossa), con mosse metanarrative che mettono in campo l’autrice, spiazzano, e suggeriscono una ricerca di verità superiore: «Trecento anni di maggiore esperienza non mi hanno insegnato a riscattare una compagna dai suoi errori umani e a ricostruirle una libertà ideale, quella che l’affrancava e la esaltava nelle ore di lavoro, che furono tante».
Artemisia troneggia, ora, fra i pittori caravaggeschi; è tempo di riportare anche Anna Banti al posto che le spetta.
(Corriere della Sera, La lettura, 26 novembre 2023)
di firmatarie e firmatari
Noi, ricercatori ucraini, artisti, attivisti politici e sindacali, membri della società civile, siamo solidali con il popolo palestinese che per 75 anni è stato sottoposto e ha resistito all’occupazione militare israeliana, alla segregazione, alla violenza coloniale dei coloni, alla pulizia etnica, all’espropriazione delle terre e all’apartheid. Scriviamo questa lettera da persone ad altre persone. Il discorso dominante a livello governativo e anche tra i gruppi di solidarietà che sostengono le lotte di ucraini e palestinesi spesso genera divisioni. Con questa lettera vogliamo rifiutare queste divisioni e affermare la nostra solidarietà con tutti coloro che sono oppressi e lottano per la libertà.
Come attivisti impegnati per la libertà, i diritti umani, la democrazia e la giustizia sociale, e pur riconoscendo pienamente le differenze di potere, condanniamo fermamente gli attacchi contro le popolazioni civili – siano essi israeliani attaccati da Hamas o palestinesi attaccati dalle forze di occupazione israeliane e dalle bande di coloni armati. Prendere di mira deliberatamente i civili è un crimine di guerra. Eppure questa non è una giustificazione per la punizione collettiva del popolo palestinese, che identifica tutti i residenti di Gaza con Hamas, né per l’uso indiscriminato del termine “terrorismo” applicato all’intera resistenza palestinese. Né questa è una giustificazione per la continuazione dell’occupazione in corso. Facendo eco a molteplici risoluzioni delle Nazioni Unite, sappiamo che non ci sarà pace duratura senza giustizia per il popolo palestinese.
Il 7 ottobre siamo stati testimoni della violenza di Hamas contro i civili in Israele, un evento che ora viene indicato da molti per demonizzare e disumanizzare del tutto la resistenza palestinese. Hamas, un’organizzazione islamica reazionaria, deve essere vista in un contesto storico più ampio e alla luce di decenni di invasione israeliana del territorio palestinese, cominciata molto prima che questa organizzazione venisse fondata alla fine degli anni ’80. Durante la Nakba (“catastrofe”) del 1948, più di 700.000 palestinesi furono brutalmente sfollati dalle loro case, con interi villaggi massacrati e distrutti. Dalla sua creazione Israele non ha mai smesso di perseguire la sua espansione coloniale. I palestinesi furono costretti all’esilio, dispersi sotto amministrazioni di regimi diversi. Alcuni di loro sono cittadini israeliani colpiti da discriminazione strutturale e razzismo. Coloro che vivono nella Cisgiordania occupata sono soggetti a un regime di apartheid, sotto decenni di controllo militare israeliano. La popolazione della Striscia di Gaza soffre del blocco imposto da Israele dal 2006, che limita la circolazione delle persone e delle merci, con conseguente aumento di povertà e privazioni.
Dal 7 ottobre e al momento in cui scriviamo il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza è di oltre 8.500 persone. Donne e bambini rappresentano oltre il 62% delle vittime, mentre più di 21.048 persone sono rimaste ferite. Nei giorni scorsi Israele ha bombardato scuole, quartieri residenziali, la chiesa greco-ortodossa e diversi ospedali. Israele ha anche tagliato tutta la fornitura di acqua, elettricità e carburante nella Striscia di Gaza. C’è una grave carenza di cibo e medicine, che causa il collasso totale del sistema sanitario.
La maggior parte dei media occidentali e israeliani giustifica queste morti come meri danni collaterali alla lotta contro Hamas, ma tace quando si tratta di civili palestinesi presi di mira e uccisi nella Cisgiordania occupata. Solo dall’inizio del 2023, e prima del 7 ottobre, il bilancio delle vittime da parte palestinese aveva già raggiunto 227. Dal 7 ottobre, 121 civili palestinesi sono stati uccisi nella Cisgiordania occupata. Più di 10.000 prigionieri politici palestinesi sono attualmente detenuti nelle carceri israeliane. Pace e giustizia durature sono possibili solo con la fine dell’occupazione in corso. I palestinesi hanno il diritto all’autodeterminazione e alla resistenza contro l’occupazione israeliana, proprio come gli ucraini hanno il diritto di resistere all’invasione russa.
La nostra solidarietà viene da un luogo di rabbia per l’ingiustizia e da un luogo di profondo dolore per la conoscenza degli impatti devastanti dell’occupazione, del bombardamento delle infrastrutture civili e del blocco umanitario derivanti dalle esperienze nella nostra patria. Parti dell’Ucraina sono occupate dal 2014 e la comunità internazionale non è riuscita a fermare l’aggressione russa, ignorando la natura imperiale e coloniale della violenza armata, che di conseguenza è aumentata il 24 febbraio 2022. I civili in Ucraina vengono bombardati quotidianamente, nelle loro nelle case, negli ospedali, alle fermate degli autobus, nelle code per il pane. A causa dell’occupazione russa, migliaia di persone in Ucraina vivono senza accesso all’acqua, all’elettricità o al riscaldamento, e sono i gruppi più vulnerabili a essere maggiormente colpiti dalla distruzione delle infrastrutture critiche. Nei mesi dell’assedio e dei pesanti bombardamenti di Mariupol non esisteva alcun corridoio umanitario. Di fronte agli attacchi israeliani contro infrastrutture civili di Gaza, il blocco umanitario e l’occupazione della terra da parte di Israele risuonano in modo particolarmente doloroso con la nostra esperienza. Da questo luogo di dolore, esperienza e solidarietà, invitiamo i nostri connazionali ucraini a livello globale e tutto il popolo ad alzare la voce a sostegno del popolo palestinese e a condannare la pulizia etnica di massa israeliana in corso.
Respingiamo le dichiarazioni del governo ucraino che esprimono sostegno incondizionato alle azioni militari di Israele e consideriamo tardivi e insufficienti gli appelli del Ministero degli Affari Esteri ucraino a evitare vittime civili. Questa posizione rappresenta un passo indietro rispetto al sostegno dei diritti dei palestinesi e dalla condanna dell’occupazione israeliana, che l’Ucraina persegue da decenni, anche con il voto alle Nazioni Unite. Consapevoli del pragmatico ragionamento geopolitico dietro la decisione dell’Ucraina di fare eco agli alleati occidentali, dai quali dipendiamo per la nostra sopravvivenza, vediamo l’attuale sostegno di Israele e il rifiuto del diritto palestinese all’autodeterminazione come contraddittori con l’impegno dell’Ucraina nei confronti dei diritti umani e della lotta per la nostra terra e la nostra libertà. Noi ucraini dovremmo essere solidali non con gli oppressori, ma con coloro che sperimentano e resistono all’oppressione.
Ci opponiamo fermamente all’equiparazione degli aiuti militari occidentali all’Ucraina e a Israele da parte di alcuni politici. L’Ucraina non occupa i territori di altri popoli, ma combatte contro l’occupazione russa, e quindi l’aiuto internazionale serve a una giusta causa e alla protezione del diritto internazionale. Israele ha occupato e annesso territori palestinesi e siriani, e gli aiuti occidentali confermano un ordine ingiusto e dimostrano doppi standard in relazione al diritto internazionale.
Ci opponiamo alla nuova ondata di islamofobia, come il brutale omicidio di un bambino palestinese americano di sei anni e l’aggressione alla sua famiglia nell’Illinois, negli Stati Uniti, e all’equiparazione di qualsiasi critica nei confronti di Israele all’antisemitismo. Allo stesso tempo, ci opponiamo anche a ritenere tutti gli ebrei del mondo responsabili della politica dello Stato di Israele e condanniamo la violenza antisemita, come l’attacco della folla all’aereo in Daghestan, in Russia. Rifiutiamo inoltre la rinascita della retorica della “guerra al terrorismo” utilizzata da Stati Uniti e UE per giustificare crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale che hanno minato il sistema di sicurezza internazionale, causato innumerevoli morti e sono state prese in prestito da altri stati, inclusa la Russia, per la guerra in Cecenia, e la Cina per il genocidio degli uiguri. Ora Israele lo sta usando per effettuare la pulizia etnica.
Appello all’azione
– Sollecitiamo l’attuazione dell’appello al cessate il fuoco, avanzato dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
– Chiediamo al governo israeliano di fermare immediatamente gli attacchi contro i civili e di fornire aiuti umanitari; insistiamo su una revoca immediata e indefinita dell’assedio di Gaza e su un’operazione di soccorso urgente per ripristinare le infrastrutture civili. Chiediamo inoltre al governo israeliano di porre fine all’occupazione e di riconoscere il diritto degli sfollati palestinesi a tornare nelle loro terre.
– Chiediamo al governo ucraino di condannare l’uso del terrorismo sancito dallo stato e del blocco umanitario contro la popolazione civile di Gaza e di riaffermare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese. Chiediamo inoltre al governo ucraino di condannare gli attacchi deliberati contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata.
– Chiediamo ai media internazionali di smettere di contrapporre palestinesi e ucraini gli uni agli altri, dove le gerarchie della sofferenza perpetuano la retorica razzista e disumanizzano coloro che sono sotto attacco.
– Abbiamo visto il mondo unirsi nella solidarietà per il popolo ucraino e invitiamo tutti a fare lo stesso per il popolo palestinese.
(il manifesto, 24 novembre 2023, in calce all’articolo di Francesco Brusa)
di Ida Dominijanni
Ci sono due buone notizie nello shock di massa provocato dall’efferato femminicidio n. 106 di Giulia Cecchettin (già diventato il penultimo: l’ultimo, il n. 107 è quello di Rita Talamelli, 66 anni, Fano, strangolata dal marito di 70 che poi ha provato a suicidarsi senza riuscirci). La prima buona notizia è la reazione di Elena, la sorella di Giulia, seguita da quella del corpo studentesco di Padova e di tutta Italia. Con la lucidità che solo il dolore riesce talvolta a dare, Elena ha lanciato quattro messaggi lapidari: che il suo non è un lutto privato ma pubblico e politico, che l’assassino della sorella non è un mostro ma un ragazzo mostruosamente normale (“il vostro bravo ragazzo”), che gli uomini tutti devono mettersi una mano sulla coscienza perché questi ragazzi normali li produce una società di uomini che non rispettano e non sanno amare le donne, che l’unico modo per onorare la morte di Giulia non è piangere in silenzio ma parlare e “bruciare tutto”. Le/gli studenti l’hanno capita al volo, ribaltando il minuto di silenzio programmato dall’alto in memoria di Giulia in un minuto di rumore autogestito dal basso e corredato dallo slogan “vento corri con me”. Basta con i minuti di silenzio, basta con le fiaccolate sommesse, basta pure con le scarpette rosse e le giornate di stato contro la violenza di genere. Ribellarsi è giusto, bruciare tutto, quantomeno metaforicamente, è sacrosanto. Finalmente.
La questione è maschile
La seconda buona notizia è che stavolta un po’ di uomini hanno finalmente provato a dire, o quantomeno a balbettare, qualcosa di sé. Lo ripetiamo da anni scontrandoci contro un muro di silenzio lesionato solo da poche eccezioni: la violenza contro le donne è una questione maschile; devono risolverla i carnefici, non le vittime. Stavolta il muro s’è rotto, fra scrittori, artisti, attori, uomini di sport, intellettuali, attivisti di sinistra. Contiamo di riscontrarne presto i risultati nelle loro opere e nelle loro pratiche, personali e politiche.
Passiamo alle notizie cattive. Che come sempre vengono dalla televisione, dai giornali mainstream e dalla scena istituzionale, il solito circolo mediatico-politico sempre uguale a sé stesso dove anche le tragedie si volgono immancabilmente in farsa. Qui la parola maschile perde ogni barlume di autocoscienza e ritrova il piglio fastidioso e molesto del mansplaining: uomini che pretendono di spiegarci tutto anche di cose di cui non sanno nulla. Esempio, il patriarcato, su cui fior di opinionisti hanno preso a sproloquiare a vanvera. Abituati come sono a fare da trent’anni i ventriloqui della narrativa occidentale dello scontro di civiltà, si erano convinti che il patriarcato è un arcaismo da paesi islamici o da autocrazie orientali, e che noi democratici occidentali ce lo siamo lasciato alle spalle da quel dì. Senonché nei paesi occidentali le donne continuano a essere massacrate, e in paesi più moderni e paritari del nostro tipo la Svezia ancor più che nel nostro. Il che significa evidentemente che certe strutture patriarcali permangono, o non si dissolvono d’incanto, anche nelle democrazie occidentali più avanzate; ma i nostri mansplainer preferiscono dedurne che i femminicidi non c’entrano niente col patriarcato. Altri, da destra, la fanno più breve: i femminicidi non hanno niente a che fare con il contesto sociale, culturale e politico né tantomeno con ventilate responsabilità o complicità dell’umanità maschile, sono gesti inconsulti ed episodici di criminali da sbattere in galera buttando la chiave, punto e basta. Quanto al patriarcato, è morto e sepolto dal giorno in cui c’è una donna a capo del governo, per giunta, come lei stessa ama sottolineare, nata e cresciuta in una famiglia di donne: e poco importa se guida un partito da lei battezzato Fratelli d’Italia, se si fa chiamare “il presidente”, se ha un piglio fallico da fare invidia ai suoi compagni di ventura e se governa in nome della patriarcalissima triade Dio patria e famiglia.
Fra struttura e storia
Tocca ribadire qualche nozione di base, e provare a ragionare. Il patriarcato è una struttura socio-simbolica (cioè un ordine sociale sorretto dall’ordine simbolico e viceversa) basata sulla legge e sul cognome del padre, sul dominio degli uomini, sull’oppressione e sul consenso delle donne. È una struttura transculturale (cioè radicata in tutte le culture), trasversale (cioè né di destra né di sinistra), trans-storica (cioè resistente al cambiamento d’epoca). Il che non significa però né che sia dappertutto uguale né che sia immodificabile o invincibile. Avere a che fare con la cultura patriarcale che permane nelle democrazie occidentali è certamente preferibile a dover lottare contro uno stato patriarcale islamico strappandosi il burqa o il velo di dosso e rischiando la galera o la lapidazione. Tuttavia la parità di genere e i diritti democratici occidentali di per sé non salvano le donne né dalla misoginia né dalla violenza maschili, che del patriarcato sono ingredienti fondamentali, e se ne infischiano sia della parità che dei diritti, come le statistiche europee sui femminicidi per l’appunto dimostrano. Giulia e decine di donne come lei non sono state uccise perché non avevano diritti; sono state uccise, nonostante li avessero, perché hanno detto “no” a un uomo.
Il “no” che uccide
Quel “no”, che agli assassini sembra evidentemente un capriccio (esattamente come il “no” a un rapporto sessuale non desiderato sembra agli stupratori un mezzo sì), condensa la libertà e l’indipendenza dal desiderio e dalle imposizioni maschili che da un secolo a questa parte le donne stanno conquistando in tutto il mondo, ivi compresi quei pezzi di mondo dove alle donne i diritti non sono concessi, come dimostra il caso dell’Iran. Ed è quel no che gli uomini-killer, e non solo loro, letteralmente non sopportano: perché non ne va solo dell’inappropriabilità e dell’inaddomesticabilità dell’altra, ma della percezione di sé, di un sé evidentemente ancora talmente ingabbiato in un’identità maschile tradizionale, fuori tempo massimo, da non trovare ragioni d’esistenza fuori da quella gabbia. Non è un caso che al femminicidio faccia seguito tanto spesso un suicidio: come se privato del possesso di una donna, un uomo non solo si sentisse autorizzato a sopprimerla, ma non potesse sopravviverle. Attenzione, perché è qui che interviene l’appello di Elena agli uomini, tutti, perché si mettano una mano sulla coscienza: perché di femminicidi ce n’è “solo” uno ogni tre giorni, ma di relazioni fra un uomo e una donna che vanno a male perché lei finisce annichilita e lui auto-amputato ce ne sono migliaia al giorno. Non c’è donna che, a qualunque età e a qualunque latitudine, non abbia avuto a che fare con un uomo incapace di rapportarsi al di lei desiderio senza distruggerla e senza autodistruggersi.
Senza il credito femminile
Ma se il dominio maschile ha bisogno di queste dosi massicce di violenza per confermarsi, e se le donne non sono più addomesticabili, di quale patriarcato stiamo parlando? «Il patriarcato è finito, non ha più il credito femminile ed è finito», recitava già più di vent’anni fa un testo della Libreria delle donne di Milano intitolato “È accaduto non per caso”. Quel testo fece scandalo, perché il patriarcato appariva allora, come appare ancora oggi, pieno di risorse. Invece era un testo profetico, perché vedeva che, con la rivoluzione novecentesca della libertà femminile, per l’ordine patriarcale era cominciato il declino, ne gioiva ma contemporaneamente ammoniva che quel declino avrebbe avuto dei costi molto salati. I femminicidi di oggi sono uno, il più terribile, di questi costi. La libertà femminile e la fine del consenso femminile al dominio maschile hanno inferto una ferita insanabile al patriarcato, che proprio perché è ferito e destabilizzato reagisce con maggiore violenza: finché le donne erano addomesticabili e sopportavano in silenzio, lo mostra bene il film di Paola Cortellesi che non a caso di questi tempi riempie le sale, non c’era bisogno di sopprimerle, bastava un ceffone di prima mattina per tenerle in riga. Oggi siamo più a rischio non perché siamo più oppresse, ma perché siamo più libere.
La legge del padre non fa più ordine
Ma il patriarcato vacilla anche per altre ragioni, e sotto spinte di tutt’altro segno. Lungo tutto il corso della modernità la legge del padre, che non è solo dominio ma anche principio di autorità e dispositivo simbolico garante del rapporto fra desiderio e legge, ha funzionato come presupposto e collante di un ordine sociale che procedeva dalla famiglia alla fabbrica allo stato subordinando le pulsioni individuali e collettive a fini superiori e condivisi. Ma oggi, e non da oggi, questa coerente sequenza è saltata e la legge del padre non fa più ordine né nella sfera privata né nella sfera pubblica. E non solo perché, come tutti sono pronti a riconoscere non senza nostalgie sospette, la famiglia patriarcale si è disfatta, i ruoli di genere sono cambiati e la trasmissione generazionale si è inceppata. Bensì perché il “discorso del capitalista”, come lo chiamava Jacques Lacan, ha soppiantato la legge del padre, imponendo un’economia psichica e un ordine – o un disordine – sociale basati sul principio di prestazione e sul godimento immediato dell’oggetto e dell’altro ridotto a oggetto, che non tollerano il differimento del desiderio, la frustrazione della mancanza e la smentita di un “no”. Se il possesso di una donna diventa così irrinunciabile e il suo diniego così insopportabile, le ragioni vanno ricercate anche nell’economia psichica propria dell’impero della merce e del mercato, che non genera mostri devianti ma figli disciplinati e conformi, perfettamente assoggettati alle sue norme: “i nostri bravi ragazzi”, insospettabili fino a un attimo prima di estrarre un coltello dallo zaino.
Il fuoco amico che viene da destra
Senonché questo impero indiscusso della merce e del mercato, della prestazione e del possesso compulsivi, non è privo di nemici interni, e prospera sotto il rischio costante del fuoco amico. Il libertarismo senza padri e senza autorità, senza mancanza e senza limiti del “discorso del capitalista” non poteva non produrre il suo doppio speculare e reazionario e infatti l’ha prodotto, nella sagoma dell’autoritarismo neo-patriarcale e sovranista che il rapporto con l’altro lo risolve innalzando muri e fili spinati e armando fino ai denti le nazioni, i popoli e gli individui (maschi) sotto la già citata formula “Dio patria e famiglia” riesumata dal cimitero della storia. E qui a doversi mettere la mano sulla coscienza sono le destre oggi ovunque dilaganti, perché se il romanzo di formazione maschile torna a essere un romanzo militarista e violento osannato nella sfera pubblica non ci si può poi scandalizzare delle sue ricadute nella vita personale e nei rapporti con l’altro sesso. Nella cascata di commenti sui fatti di Vigonovo brilla l’assenza di qualunque riferimento al contesto di guerra permanente in cui le giovani generazioni maschili si stanno formando. Eppure qualcuno il nesso lo vede eccome: «Contro la deriva del neomatriarcato serve appellarsi ad Abramo», titola un pezzo del Foglio del 23 novembre, e così fra Vigonovo e la tragedia israelo-palestinese il cerchio della violenza si chiude.
I femminicidi non sono un fatto nuovo nella lunga storia del patriarcato. Ma ne sono, di tempo in tempo, un sintomo. Quelli di oggi parlano di un patriarcato ferito e vacillante, sottoposto alle spinte contrapposte della libertà femminile da un lato e della macchina capitalistica dall’altro, e oggetto di pericolosi desideri di restaurazione e di revanche da parte dei nostalgici dell’ordine perduto. Il patriarcato non è un relitto del passato e non è un destino che ritorna sempre uguale: è un campo di battaglia di cui è nelle nostre mani decidere le sorti. Nostre, cioè di noi donne e degli uomini che sapranno e vorranno fare la differenza dal “maschile come valore dominante”, come titolava un testo inaugurale del femminismo di fine anni sessanta, e dalle maschere con cui non smette di ripresentarsi. Nei falò accesi in memoria di Giulia si riaccende la miccia di un desiderio politico ormai antico e sempre nuovo.
(Internazionale, 24 novembre 2023)